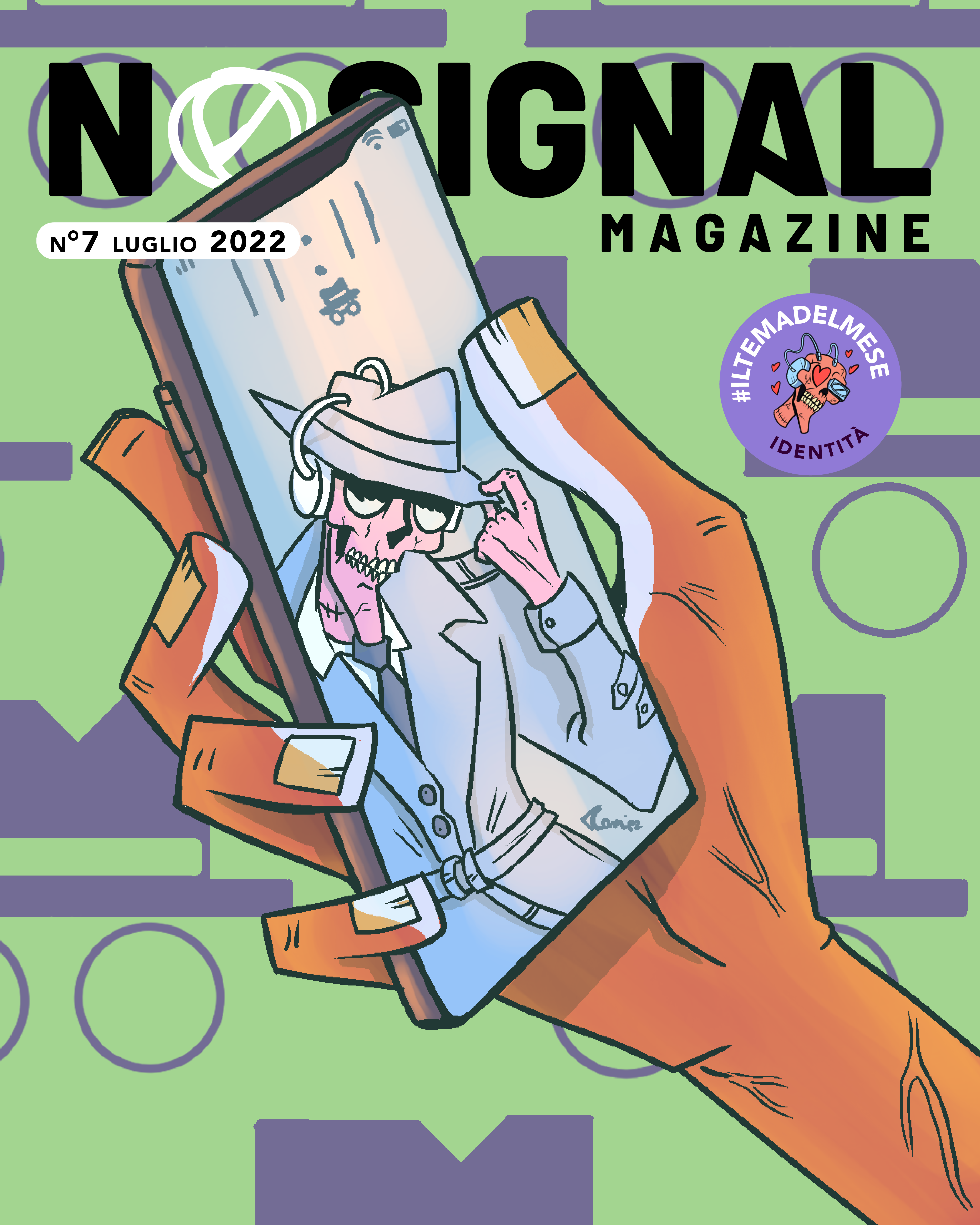Due settimane fa durante lo scrolling mattutino su Instagram, in attesa che il mio vecchio bollitore scaldasse l’acqua del tè, sono incappata nel tutorial di un make up per halloween. L’ho guardato dodici, tredici volte con l’acqua che nel frattempo raggiungeva la temperatura di ebollizione. A folgorarmi non era stata tanto l’incredibile trasformazione dei connotati della make up artist, quanto la musica, la colonna sonora del Reel. Una canzone che conoscevo molto bene, ma che non avevo mai sentito in quella versione. Sono due settimane che non ascolto altro: mentre corro la mattina per arrivare a lavoro in tempo, durante la sigaretta della pausa pranzo, quando mi strucco la sera sotto la doccia. Sto parlando di Once Upon a Dream cantata da Lana Del Rey.
Come la stragrande maggioranza di noi, ho ascoltato per la prima volta Once Upon a Dream (composta da George Bruns nel 1959) da bambina, seduta sul divano davanti a uno schermo in cui una fanciulla dai boccoli perfetti e con un girovita della misura del mio polso volteggia scalza nel bosco sognando l’arrivo di un principe. Principe che in effetti arriva, e non solo si inserisce nel ballo con tanta naturalezza che sulle prime Aurora nemmeno se ne accorge, ma che in più conosce anche le parole della canzone! Una coincidenza tale che la Bella Addormentata si concede giusto un paio di secondi di esitazione, e poi riprende a ballare e a cantare insieme a Filippo tra betulle, violette e scogliattolini.
Le stesse note sognanti su valzer in 3/4 tornano nel finale del film, quando Aurora è finalmente riunita a corte con la sua famiglia e il tremendo drago Malefica (che paura!) è sconfitto. La melodia è leggera e vivace, gli archi e i fiati creano un’atmosfera eterea, i cambi di accordi fluidi sostengono questa sensazione di serenità e speranza che culmina con il commosso squittio della fata Flora: «I just love the happy endings». E la me bambina anche si commuoveva, perché questo principe e questa principessa, il cui vestito continua a cambiar di colore, mi promettevano che tutto ciò che avrei sognato si sarebbe esaudito. (Fun fact: la gag per cui Fauna e Serenella litigano sul colore del vestito di Aurora nasce della disputa tra i due disegnatori che non riuscivano a mettersi d’accordo).
Sono passati vent’anni, la televisione a casa non ce l’ho più, guardo i film al computer, nelle sere speciali proiettati sulla parete di fronte al letto. Ascolto Once Upon a Dream cantata da Lana Del Rey e mi rendo conto che l’incanto si è spezzato. Che una canzone che mi parlava di futuro e di sogni, ora, intonata dalla voce grave di Del Rey, sa più di passato, di disillusione. Il ritmo rallentato permette alla realtà di insinuarsi tra gli accordi, alla malinconia di permeare il ritmo. Rispetto al Do maggiore dell’originale, la nuova versione viene trasposta in una tonalità minore (Sol minore) che ammanta la canzone di un’aura cupa, di un profumo inquieto. La voce misteriosa di Del Rey si appoggia languida ai suoni più ombrosi e sintetici rendendo il brano gotico e drammatico.
Cosa mi ipnotizza tanto di questa versione? È solo l’avvicinarsi dei trent’anni che mi spinge a crogiolarmi nel timbro profondo di Lana Del Rey?

Magari c’entra, magari barcamenarsi nello spaesamento è parte del diventare adulti. Ma se mi guardo intorno, quasi tutti i miei amici e le mie amiche stanno male: non può essere che la realizzazione della maturità sia scesa come l’incantesimo di Serenella su tutti e tutte noi nello stesso momento. Credo che abbia più a che fare con questo: che nell’ultimo anno la mia generazione si è scontrata, forse per la prima eclatante volta, con il disincanto. In questi mesi abbiamo dovuto apprendere una tremenda verità: che informarsi, di per sé, non cambia le cose. Che scendere in piazza, manifestare, non ferma i genocidi. Che forse boicottare sì, a qualcosa serve, ma non blocca i bombardamenti.
E magari è stato uguale anche per ogni generazione prima della nostra che si è trovata costretta a crescere: ha dovuto accettare la propria impotenza, ha dovuto accordarsi con il cinismo e trattare su quanto spazio concedergli quotidianamente. Ma è solo questa l’alternativa che ho, che abbiamo, per affrontare i prossimi quarant’anni di vita? Scegliere se diventare adulti cinici e indifferenti oppure ingenui e illusi?
Quella gioia spensierata nei confronti del futuro che risuona cristallina nella versione originale di Once Upon a Dream ci è ancora concessa o, dati i 3,6 miliardi di persone a rischio sopravvivenza a causa dell’emergenza climatica, è sintomo di miopia? E d’altra parte arrendersi, considerare la felicità una prerogativa solo del passato, convincersi che davvero non ci sia nulla da fare, non è da vigliacchi? Posso essere allegra e speranzosa, entusiasta del mio presente, mentre la Terra brucia e il popolo palestinese viene sterminato? Quanto mi rende egoista? Quanto mi rende umana?
La versione di Del Rey mi ossessiona perché la sua voce mi culla in un dolce malessere malinconico, senza promettermi il «Vissero per sempre felici e contenti», ma senza nemmeno colpirmi all’improvviso, lì nel punto più scoperto. È questa la soluzione? Questa terza via? Rifugiarmi in una dolce tendenza quasi apatica disunita dalla realtà?
Smetterò di ascoltare in loop questa canzone, lo giuro. Recupererò il fatidico Reel e tra qualche settimana mi presenterò a una festa truccata da Malefica; aprirò Instagram per postare una foto in cui con gli zigomi scavati abbraccio un’amica con del sangue finto all’angolo della bocca, e sulla home mi apparirà il video di due bambini estratti dalle macerie. Come reagirò? Ignorerò il video e posterò la storia? Lo guarderò con la mia amica? Passeremo la serata a parlare dell’invasione israeliana? Ci diremo di non volerci rovinare la festa e butteremo giù il primo shot a tiro?
In ogni caso, quei due bambini resteranno morti sotto le macerie.
Nessun Once upon a dream per loro. E per noi? ♦︎
Illustrazione di Lara Milani