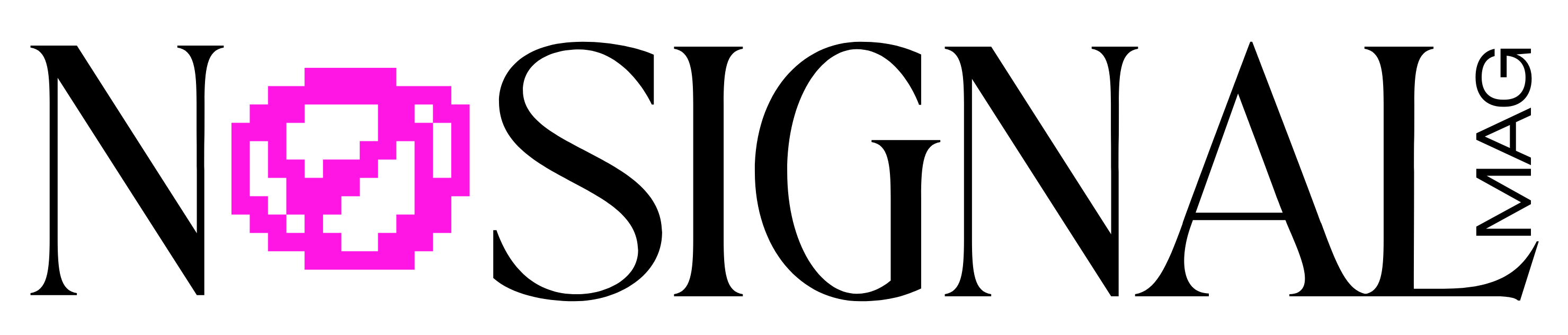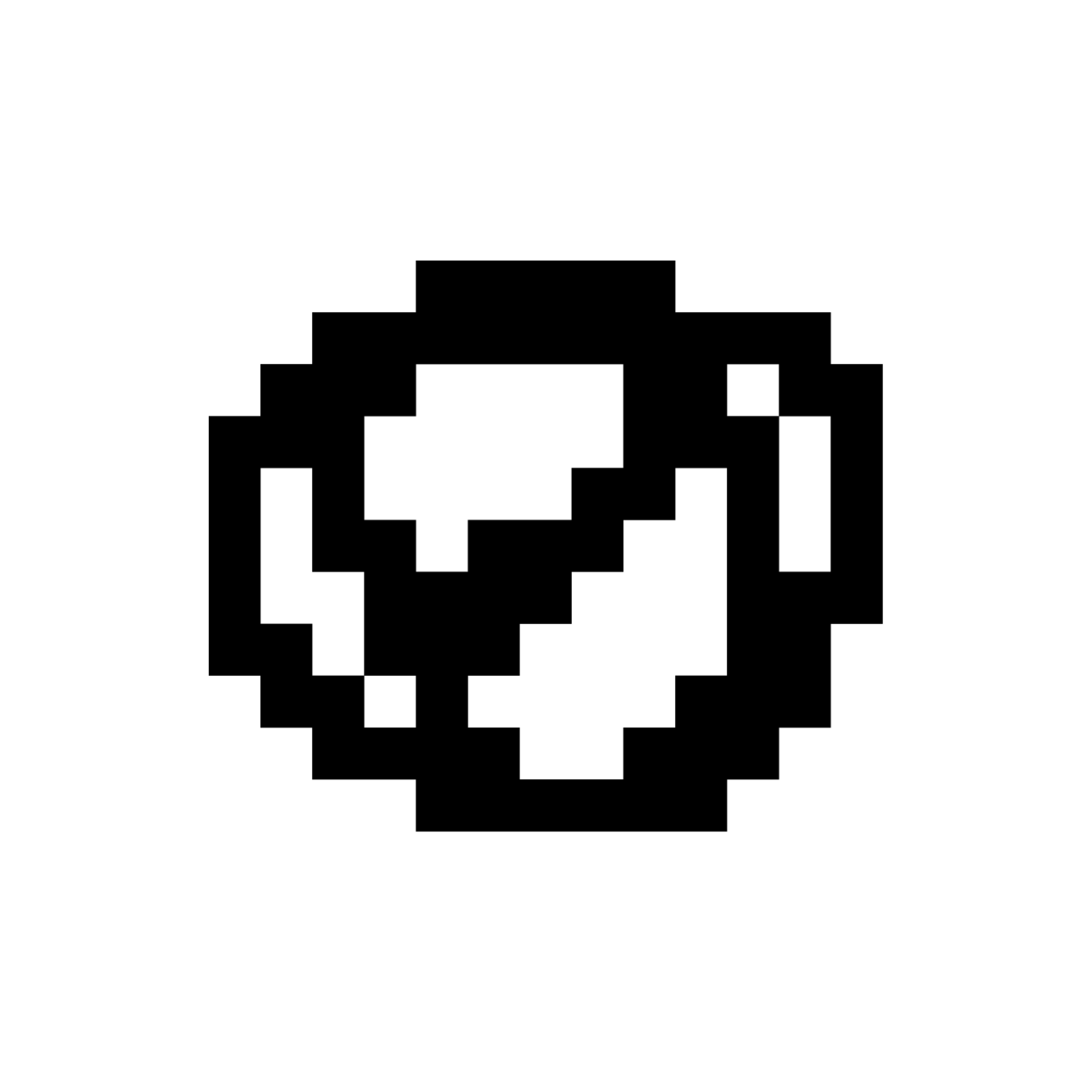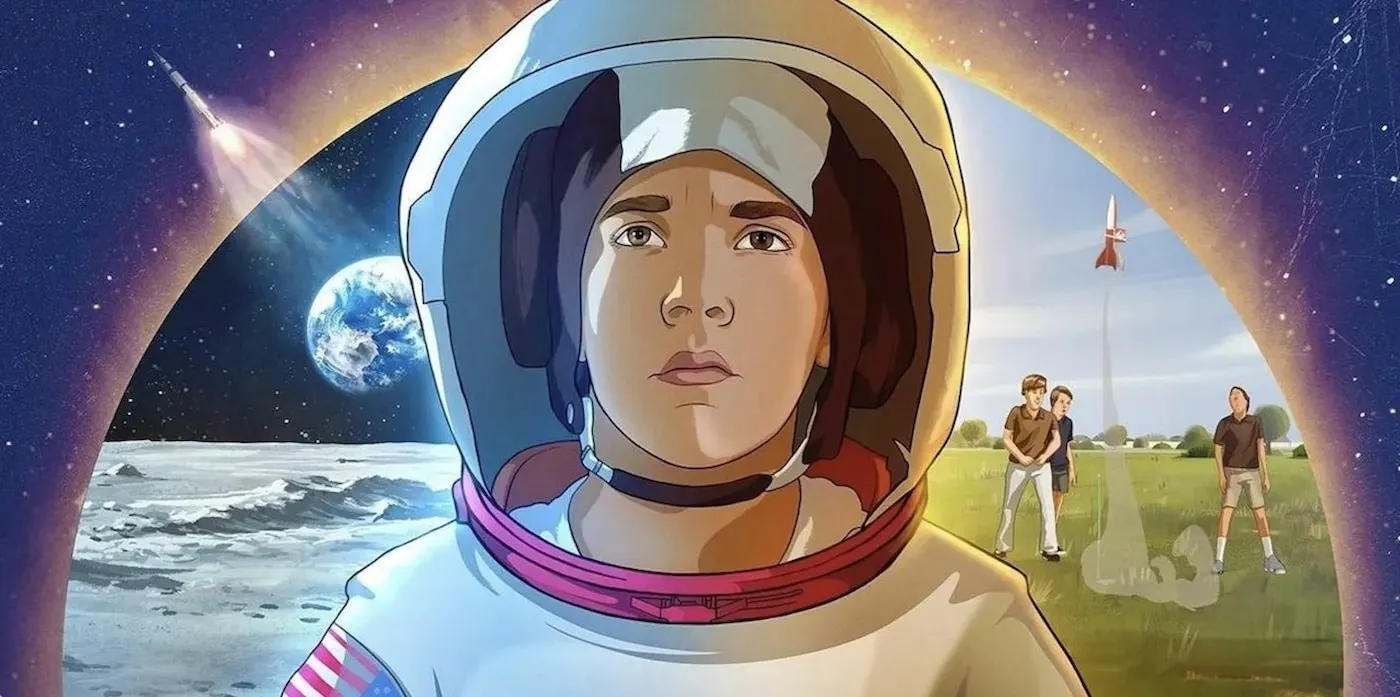Con Parthenope, presentato in concorso a Cannes, Sorrentino consolida una costante, da La grande bellezza a This must be the place, fino a È stata la mano di Dio: l’importanza delle scelte, gli aut-aut, a cui tutti siamo stati chiamati, almeno una volta, a rispondere. Ma a che prezzo?
Ha chiuso con oltre sette milioni al box office ed è diventato il film con maggior incasso italiano dell’anno. L’ultimo aut-aut è questo: ma quindi Parthenope è una «truffa» o un «mistero»? A chiederselo non è solo la protagonista in una scena dell’ultima pellicola di Sorrentino, paragonandosi al miracolo di San Gennaro. Ce lo siamo chiesto anche noi, pubblico, a fine proiezione, con gli occhi ancora incollati ai titoli di coda sulle immagini del corteo post festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli.
Chi è Parthenope?
Una cosa è certa: qualcosa di Parthenope, e dell’ultimo Sorrentino, ci ha lasciato frastornati.
Chi è Parthenope? L’adolescente in cerca di sé, l’attrice mancata, la studentessa universitaria affamata di nuove esperienze, l’insegnante in pensione? O forse è tutte queste versioni di sé insieme? Tutti i personaggi di Sorrentino sono scissi in una duplice identità: Jep Gambardella in La grande bellezza è diviso fra il sé delle feste mondane e il sé scrittore del romanzo dal titolo L’apparato umano; Cheyenne, in This must be the place, sotto l’apparenza rock e aggressiva nasconde un animo innocente da bambino; Fabietto, dall’autobiografico È stata la mano di Dio, dopo la tragedia personale della perdita dei genitori ispirata alla vicenda personale di Sorrentino, deve scegliere se lasciare per sempre l’adolescenza spensierata o entrare nel mondo disincantato degli adulti.
Portare con sé o lasciare andare: è questo aut-aut a rendere ogni personaggio sorrentiniano in bilico tra due alternative che si autoescludono a vicenda. Anche Parthenope è scissa in due, un po’ come la Napoli che il nome della protagonista racchiude così bene: si chiama ‘Partenope’, secondo il mito, una delle sirene che per Ulisse si sono suicidate; è proprio il corpo della sirena Partenope ad essere stato trasportato sulle rive di quella che diventerà poi la città, appunto, partenopea per eccellenza. Sorrentino non nasconde quindi di fare un film sulla sua città, della quale cerca di racchiudere le molteplici anime, opposte tanto quanto necessarie, come quelle che abitano Parthenope. In una recente intervista Sorrentino ricorre a Kierkegaard: la giovinezza di Parthenope si interrompe quando si entra nella fase etica, razionale ordinata borghese, e si esce dalla fase estetica, sperimentale incerta accidentale. «Quello che sei non ti piace e fai tentativi per uscire da te stesso, senza riuscire: fino a quando finisci per accettarti»: sta in questo la scissione, ed è questo che Sorrentino ha voluto indagare con questo film che rispetto a Youth rappresenta la giovinezza da un punto di vista privilegiato e diretto, non come rimpianto ma come scoperta perenne.

Era già tutto previsto
Un costume da bagno ad asciugare su una sedia, un ragazzo che lo prende, lo tocca, lo odora. Essere desiderata, ma soprattutto desiderare: il primo modo per fare esperienza di sé per Parthenope è la scoperta del proprio corpo, attraverso l’ascendente che sa di avere attraverso gli sguardi degli altri, in particolare dell’amico d’infanzia Sandrino e del fratello Raimondo. Si può parlare quindi di un rovesciamento del male gaze tradizionale, anche se è attraverso gli occhi inebetiti di Sandrino che Parthenope ci viene restituita nelle prime scene del film, in un’estatica contemplazione. Forse è qui che Sorrentino allenta la presa e va fuori dagli schemi delle rappresentazioni attuali: Parthenope non è meno forte perché vittima di uno sguardo, forse proprio perché non ne è vittima ma predatrice dello sguardo altrui, se ne nutre per costruire l’immagine che ha di sé, definirne i limiti, divenire consapevole del suo essere nel mondo. Benché non si apra mai un vero e proprio dibattito di genere e, anzi, la questione sia lasciata sullo sfondo, Parthenope non è ‘vanillizzata’ o appiattita, per quanto il compendio di «frasi fatte» con cui pensa di avere sempre la risposta pronta siano stucchevoli e talvolta indigeste. Tutto è mosso sempre in base alle sue scelte e alla voce del suo ‘io’ e questo basta a renderla indipendente e protetta, in un mondo immaginifico almeno, dagli abusi maschili.
La questione dell’aborto è solo stata sfiorata ed è invece ignorata completamente la storia che, come nella scena della scalinata dell’università, vede scorrere dietro di sé mentre lei sta seduta. Parthenope lascia passare ogni cosa accanto a sé: l’acqua è il suo elemento, è attraverso il mare che le arriva la carrozza-letto, ed è nel mare che nasce. È il mare che deve solcare per arrivare a staccarsi dai genitori e superare il suicidio del fratello Raimondo che si è ‘lasciato andare’. È gestita così anche la scena cardine della tensione sessuale giovanile: il desiderio incestuoso nei confronti del fratello e la tensione erotica con Sandrino portano il trio a consumare la passione. L’esito tragico della triangolazione amorosa e incestuosa tra Parthenope e Raimondo è anticipata dalle ultime note della canzone di Riccardo Cocciante: ‘Non ho saputo prevedere / solo che però adesso io / vorrei morire’ che rientra appieno nella moda della triangolazione del desiderio che ha iniziato a spopolare dopo il triangolo Zendaya-Josh O’Connor-Mike Faist.
Con Parthenope, Sorrentino cambia il target, complice anche la forte pubblicizzazione sui social e il rimescolio di certe tematiche, come la triangolazione del desiderio così amata già in Challengers di Guadagnino, e i quadri-animati tipici del suo cinema estremamente manieristico, che evocano ambientazioni più sognati. Del Sorrentino classico resta ovviamente lo stile: lo riconosciamo nei sapienti movimenti di macchina con crane e dolly, nel barocco esibito dalla prima scena della carrozza trasportata dal mare, fino all’incontro di eccessi e trasgressioni con l’arcivescovo Tesorone in revival kitsch delle feste de La grande bellezza.
Ogni amore giovane porta con se la stessa illusione e non sfugge a questo nemmeno l’epica, il tentativo di riscattare il ricordo dalla realtà la rende ancora più tagliente: il dialogo che si scambiano Parthenope e Sandrino anni dopo conferma la premonizione dell’ ‘Era già tutto previsto’ di Cocciante la sera della festa: che «gli amori giovanili non sono serviti a nulla» lo conferma solo il tempo.
Altrove
«La verità non fa parte della giovinezza: è un luogo dove si ha a che fare con l’insincerità, si ha a che fare con il sogno, si fa un racconto epico di sé, si balla da soli davanti allo specchio», continua Sorrentino. Così Parthenope per la sua giovinezza ha un compito: fare esperienza. La sua conoscenza è diretta e avviene con gesti concreti: se la storia le passa accanto senza che lei se ne curi, così non avviene per le persone che popolano il film e che diventeranno i personaggi del suo romanzo di formazione, sparsi ma coerenti. Parthenope li accarezza, li tocca, li bacia. È attraverso un contatto diretto, empirico, che impara, capisce, trae a sé dalla sua inesperienza nutrimento per imparare. Ma c’è di più.
Parthenope ci stupisce perché manca deliberatamente il bersaglio: con la verità ci ha a che fare, la maneggia, la tocca, ne fa esperienza ma è solo una scoperta momentanea che dura il tempo di un incontro. È così l’esperienza con John Cheever (sigillato dalla performance impeccabile di Gary Oldman), così l’incontro con Flora Malva, anziana diva mascherata, e anche con Greta Cool, attrice di basso livello ma che ha fatto fortuna, fino poi a Roberto Criscuolo, che le permette di accedere a un’altra Napoli, a un’altra dimensione del reale, non quella delle acque blu di Posillipo dove è nata, ma una Napoli di miseria e squallore. È qui che si squarcia il velo della narrazione che diventa raccontata, qui l’esperienza fiabesca incontra la realtà e lascia intravedere la verità e la fine dell’epica giovanile. È solo dopo questa esperienza che il professore di antropologia Devoto Marotta si decide a mostrarle il figlio: l’esperienza col deforme collide con il conforme a cui eravamo abituati e per la prima volta ad accecarci di bellezza non è l’intensità di Celeste Dalla Porta (vincitrice del premio ‘giovane rivelazione’ alla fondazione Virna Lisi), ma è il corpo antiestetico del figlio di Marotta, che fa finire sullo sfondo tutto il resto. Insieme a Parthenope siamo cresciuti anche noi e abbiamo acquisito una nuova vista che, come le aveva anticipato Marotta, avrebbe acquisito solo quando «non ti rimane più niente»: Parthenope si è liberata del giudizio degli altri, ha distrutto l’immagine che aveva costruito grazie agli occhi degli altri ed è pronta ad vedere, vedersi, con i occhi nuovi: i propri.
È un finale dolceamaro e goffo allo stesso tempo, che ci coglie impreparati. Parthenope ritorna nei suoi luoghi e resta fedele a se stessa. Richiama nel finale l’accettazione di Jep nell’ultimo monologo in La grande bellezza: «Altrove, c’è l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove». Come Jep ha fatto la sua scelta, ha sciolto il suo aut-aut, così ha fatto Parthenope: scegliendo di non scegliere.
Parthenope ci lascia frastornati perché non ci ha lasciati affatto, è ancora lì con noi, assieme alla duplice domanda che porta con sé: sono questo o quello? Chi sono, cosa voglio essere? L’ultimo Sorrentino ha confezionato così un film che parla esplicitamente ai giovani, in un monito a vivere questi anni prima che diventino parte di un racconto epicizzato della propria giovinezza. ♦︎