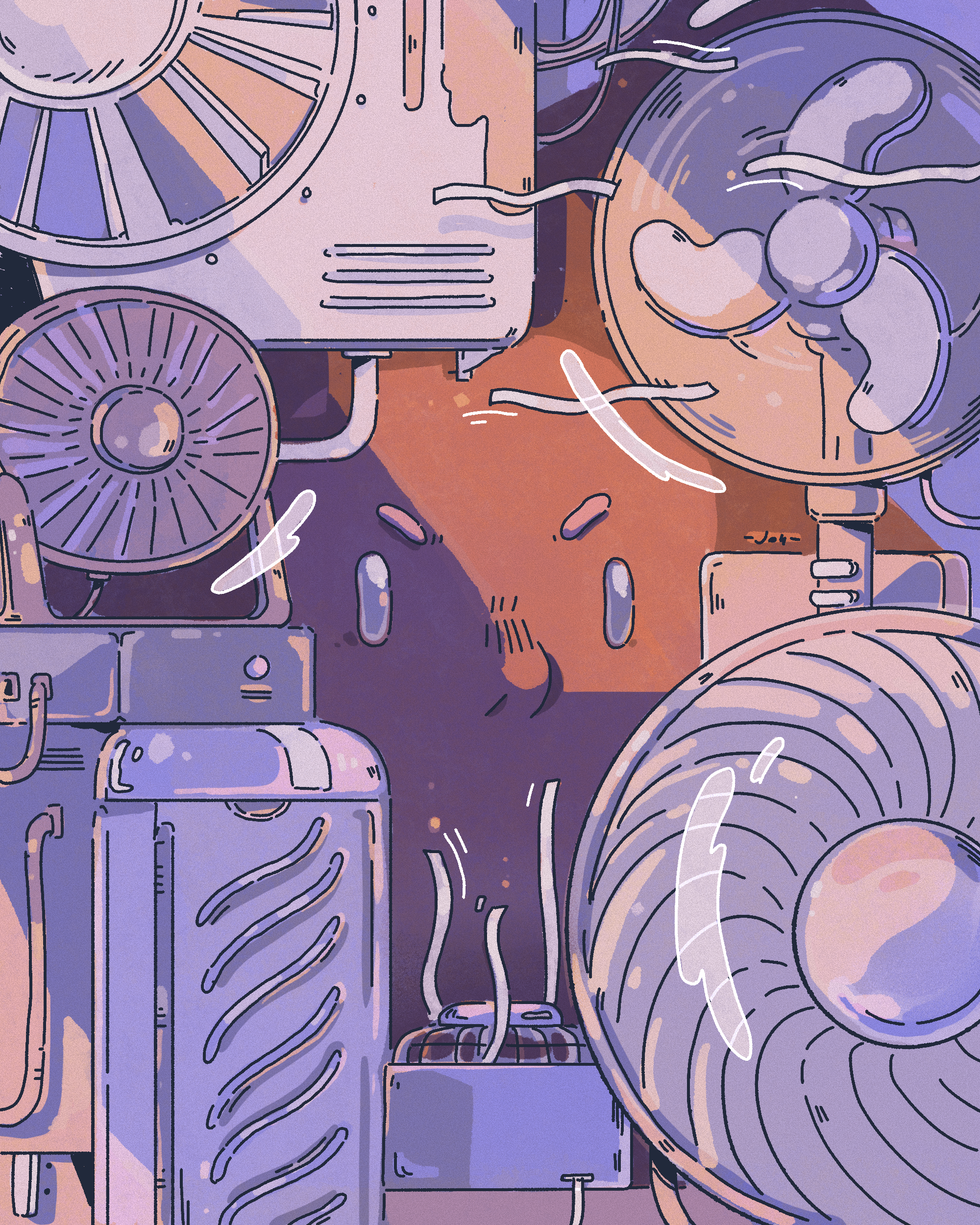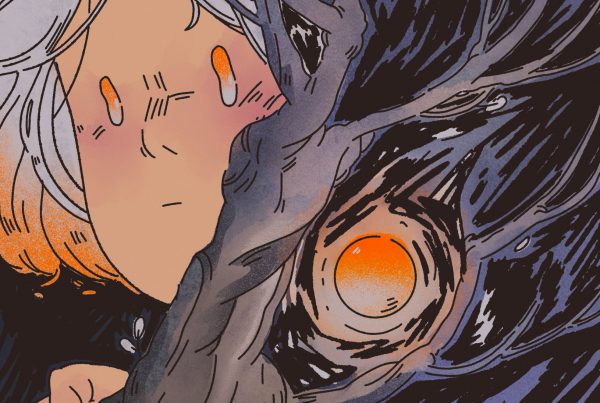Maledetta estate
Ho sotto mano un disegno.
Sull’F4 Fabriano, rigorosamente liscio c’è rappresentato un ragazzo seduto di spalle su una panchina; solo e da solo.
I capelli sono disegnati orizzontalmente per dare l’idea del vento. Ha un braccio allungato sulla spalliera che lo fanno sembra seduto comodamente. Ai lati due lecci. Di fronte una fontana a muro con sopra il rubinetto il graffito di un demone. La strada è deserta.
Sul foglio, in alto a sinistra la scritta:
18 settembre 2006.
2A scuola media Primo Levi.
Titolo: Attesa.
A destra:
Compito: disegna quello che ti ha insegnato la tua estate.
Quel ragazzo di dodici anni, sulla panchina in campagna, sono io.
Siamo abituati a pensare all’estate come sabbia, sole, mare. La goccia che dal bordo del ghiacciolo ci cade fredda sul petto nudo, mentre strizziamo gli occhi sotto l’ombrellone di un chiosco. Le spiagge affollate, i servizi dei Tg della rai con le voci cantilenanti dei giornalisti che raccontano l’estate sulle spiagge. Le feste di sera sul lungo mare tra pareo e profumi di creme dopo-sole.
Per me, l’estate era la condanna di vacanze non volute. La vita che si ferma. Il vuoto riempito da un unico suono: l’incessante frinire delle cicale, giorno e notte.
Degli otto compagni di classe solo due erano dello stesso paese, quindi finita la scuola finiva il tempo del folto gruppo. Si rimaneva in tre a mangiare Cornetti Soft dell’algida alla stracciatella fuori dall’unico bar del paese. Passavamo ore silenziose a costruire la casetta sull’albero e andare in bici per i campi.
Le vacanze però arrivano per tutti. Il trio, si riduceva ancora, e il mio periodo di vacanza non coincideva mai con quello scelto dai loro genitori.
Così per settimane interminabili, mi rifugiavo nella mia casa degli oggetti: i miei dinosauri con l’ultimo arrivato: Collolungo (un brontosauro grigio), la mia spada, il vestito da Gandalf fatto dalla nonna sarta di un amico, (che comunque mettevo anche d’estate); e mi rifugiavo anche nei luoghi, come le vie conosciute dei campi, il nocciolo che segnava il confine di due proprietà di contadini. Luoghi in cui non ero proprio così solo. Esistono spazi che sanno tenere compagnia.
Tutto questo, potrà già sembrarvi il momento della solitudine che porta l’estate. Ma non è così. Questo non era altro che una preparazione, un’attesa, un sintomo, un manifestarsi precoce della vera solitudine a cui sarei andato in contro.
Mia madre aveva una valigia per le pentole. Si portava al mare le sue pentole, padelle e strumenti da cucina perché «quelle che ci sono nella casa dove andiamo non sai mai chi le ha usate prima di te».
Al contrario mio padre aveva invece la sua valigia, con così poche cose dentro che sarebbero potute stare in uno zaino. Io avevo una valigia piena di dinosauri, vi chiederete se Collolungo era compreso fra loro. Certo che no! Rimaneva fuori dalla valigia sulle mie gambe per tutto il viaggio. I miei erano così affezionati alle tradizioni che l’unico bagaglio, il più pesante, che si portavano dietro e che avevano in comune, era quello del conflitto.
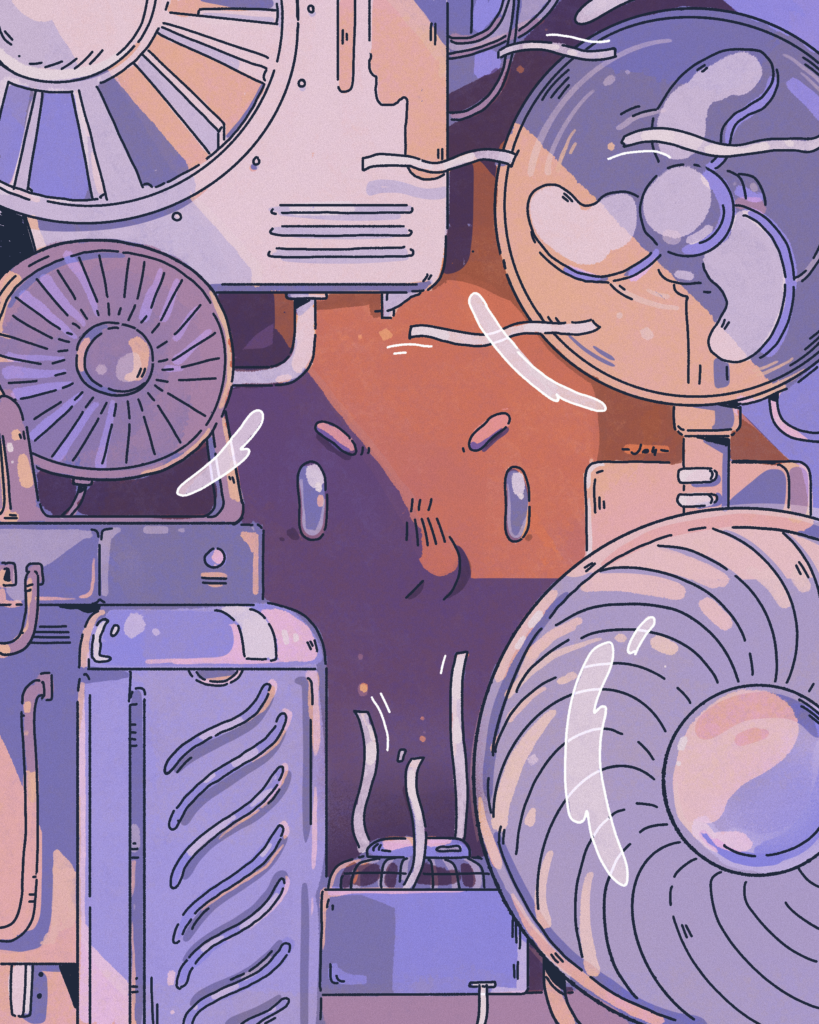
Per me, le due lunghissime settime avevano la durata della vita stessa carica di scontri il bagaglio del conflitto veniva già aperto in macchina. Non esisteva un attimo in cui non si gridassero addosso; la loro unica premura era combattere. Anche se dopo tanti anni, non sapevano più per cosa. Così la mia estate diventava una trappola, e maledicevo l’estate e le sue vacanze obbligate! Costretto in una cella con compagni poco graditi, in una città sconosciuta, costretto a stare ogni ora con loro.
Come ogni galeotto il mio pensiero correva verso casa, alle colline, ai boschi, ai fiumiciattoli, ai campi. Rimpiangevo quella solitudine del paese; pensavo al fresco del mattino e alla voce di mia nonna in giardino che parlando con la vicina mi svegliava. Così, iniziavo a scrivere cartoline a tutti per sentirmi più vicino a loro. Quando potevo sfuggivo in mare dove passavo tutto il tempo possibile con Collolungo e con una petroliera di plastica di circa cinquanta centimetri, blu, gialla e rossa con cui simulavo centinaia di volte l’affondamento del Titanic. E raccoglievo conchiglie da portare a tutti, anche ai morti. E, ignara di tutto, mentre mio padre dormiva al sole, mia madre mi sorrideva e mi salutava entusiasta.
L’ultima maledetta estate in cui sono andato in vacanza con i miei, la destinazione cambiò. Andammo in Grecia. La colpa o il merito di questo cambio era il mio. Ogni settembre i miei amici tornavano sempre carichi di foto scattate in posti bellissimi del mondo. Mentre io, oltre tornare senza foto, perché le macchinette usa-e-getta venivano sviluppate dai miei genitori mesi dopo, tornavo anche senza vicissitudini interessanti. Loro erano ritratto in cattedrali immense, immersi in culture diverse e raccontavano, raccontavano di cose di cui non sapevo nulla e che anche io volevo conoscere.
Così costrinsi i mie genitori ad una vacanza culturale. La mediazione fu trovata in Rodi: un’inferno. Costringere persone diverse a fare quello che non sanno fare (stare insieme) in condizioni a loro sfavorevoli fu un errore. Di quella vacanza, volontariamente o involontariamente, cancellai tutto. A parte una guida del posto, con un rosario in mano che ci portava in giro per l’isola insieme ad altri turisti. Lo ricordo perché a fine vacanza, forse per compassione quel rosario me lo regalò.
Le cose cambiarono quando diversi anni dopo mi trasferii in città. I morti smisero di ricevere le miei conchiglie. L’estate è stata un memento bellissimo per vivere la città da solo. Usai quella solitudine che avevo sperimentato nel paesino vuoto e avevo imparato ad apprezzare durante i conflitto delle vacanze familiari, per provare a capire la vita (o non vita) nella città deserta. Quindi questo, l’estivo, è l’unico momento in cui conoscere davvero una città. Il nostro rapporto con la metropoli non è diverso da quello con le relazioni umane: si impara meglio a conoscere una persona nei rapporti duali. Così mi concentrai sulla città e sulle sue vie, i suoi silenzi, i suoi spazi ridisegnati dal ricordo di voci e corpi che la riempivano fino a qualche giorno prima.
L’estate è quando tutto finisce e rincontriamo noi stessi. È uno spazio per crescere nel silenzio. È l’intersezione tra quello che sei diventato nell’anno passato e le nuove basi che getti per vivere la vita nel futuro. È un momento embrionale cheimprovvisamente cresce velocissimo in pochi mesi facendoti esperire più di quello che potresti fare tutto l’anno. Così pian piano lasciamo il vecchio Io con cui approdiamo a giugno, per iniziare una nuova vita a settembre.
E adesso eccomi, all’inizio della mia trentunesima estate, e chissà cosa sarà pronta a regalarmi.
E io, con la schiera dei fantasmi delle estati passate, la aspetto su quella panchina tra i lecci, dove mi aveva insegnato a vivere solo e da solo. E chissà, se avrò l’occasione questa’anno, raccoglierò una conchiglia anche per Collolungo che mi guarda da dove vanno a finire tutte le cose dell’estate e dell’infanzia: in qualche cassonetto dell’anima. Perché forse l’estate, come tutto del resto, è fatta per diventare ricordo.
Maledetta estate!