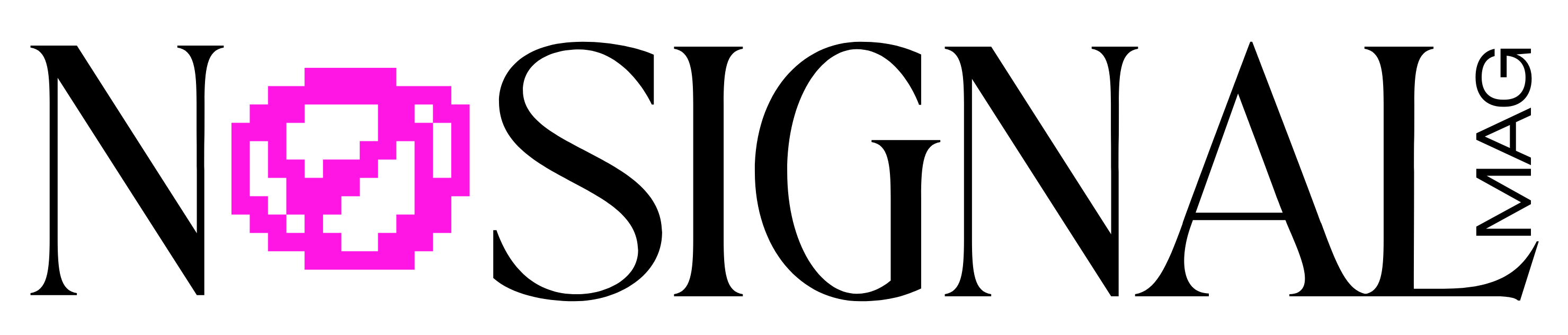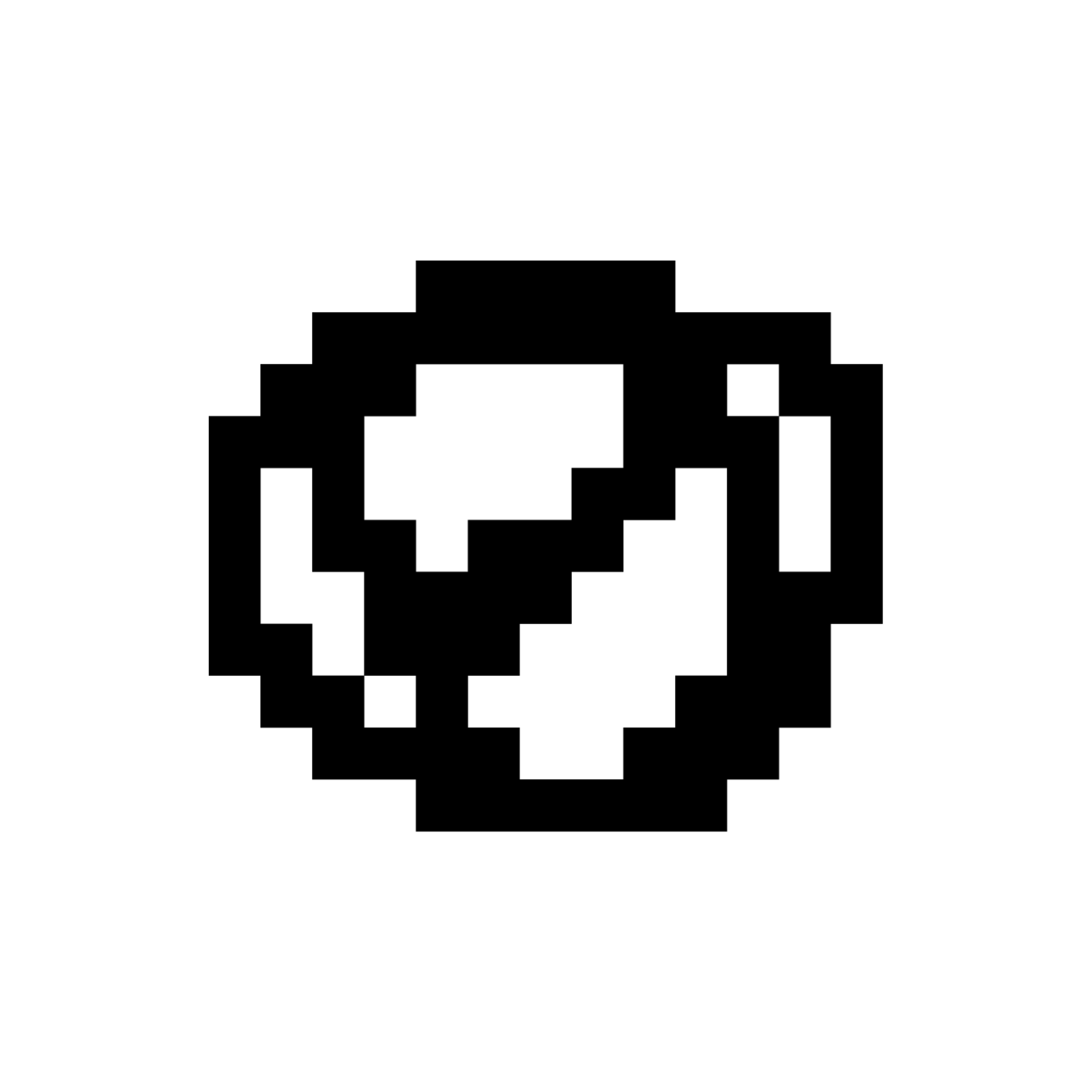Tra miti e storie di martiri, da millenni le persone associano il loro destino agli astri.
Anche se la scienza ha dimostrato che si tratta in realtà di frammenti di meteoriti, ancora ai giorni nostri nell’immaginario comune le stelle cadenti continuano a essere considerate astri che si staccano dal cielo. Tuttora affascinano ed emozionano le persone con la loro sfuggente scia luminosa, promessa di sogni, che in un lampo attraversa il cielo notturno per poi sparire nell’oscurità.
Fin dall’antichità questi frammenti di roccia incandescenti non sono parsi semplici pietre agli occhi dei popoli, tanto che su di loro hanno intessuto innumerevoli leggende. Particolarmente curioso è il fatto che in svariate culture e per disparati motivi le stelle cadenti sono state associate nel corso dei secoli al destino delle persone e alla realizzazione dei loro desideri.
Le stelle cadenti come simbolo di fertilità: i miti greci e latini
Tra i più antichi racconti riguardanti la natura delle stelle cadenti vi è quello di Priapo e della Grande Madre. Secondo i greci la pioggia di meteoriti ammirata nel cielo notturno di agosto avrebbe rappresentato il seme di Priapo che, cadendo sulla Terra, feconda la Grande Madre, incarnazione della Natura. Le stelle cadenti erano, quindi, un simbolo di fertilità e, non a caso, proprio in questo periodo dell’anno, adiacente a quello del raccolto, si tenevano numerose feste in onore di queste due divinità: le falloforie.
Il legame fra le stelle e la fertilità non era, in realtà, una novità: già gli antichi egizi raccontavano una storia simile, la cui protagonista era Nut, dea della nascita. Secondo questa leggenda la volta celeste era il ventre della dea e le stelle erano le anime delle persone che, una volta morte, venivano accolte nel corpo di Nut. Da qui l’interpretazione delle stelle cadenti quali doni preziosi fatti dai defunti alle persone ancora in vita.
Ma arriviamo finalmente a vedere cosa c’entrano le stelle cadenti con i desideri.
Uno dei primi a collegare le meteoriti all’usanza di esprimere un desiderio fu l’astronomo greco egiziano Tolomeo, che le riteneva uno spiraglio di luce nell’oscurità frapposta tra il Regno dei Cieli e la Terra, attraverso il quale Dio poteva osservare gli uomini ed esaudire le loro richieste.
Per i latini, successivamente, il legame tra le meteore e il destino delle persone era ancora più marcato. Basti pensare all’etimologia stessa della parola “desiderio”, de sidera, che tradotto significa “senza destino”: il fato di una persona era già prestabilito dalla nascita e scritto nelle stelle, così, quando queste cadevano, gli uomini avevano la loro unica possibilità di cambiare il loro destino e di realizzare i loro sogni.
Inoltre, nell’immaginario politeista romano, le stelle cadenti erano legate al mito di Acca Larentia, figura mitologica, in alcune storie rappresentata come una donna molto ricca che, alla sua morte, decise di donare al popolo tutto ciò che possedeva; in altre era vista come l’incarnazione stessa della lupa che allattò Romolo e Remo. In ogni caso fu sempre descritta come simbolo di fertilità, che attraverso la pioggia di stelle nelle notti di agosto elargiva doni preziosi alla terra, dimostrando la sua generosità. In alcune leggende, Larentia viene addirittura definita come la Grande Madre, la fonte stessa della vita sul pianeta. Agosto si presta bene, in effetti, a questi collegamenti, dato che è proprio questo il mese in cui si raccoglie il frutto del lavoro nei campi ed è anche uno dei periodi in cui le stelle cadenti sono maggiormente visibili, con il passaggio delle perseidi.

La notte di San Lorenzo
Con l’avvento e la diffusione del cristianesimo, una nuova figura divenne il simbolo delle stelle cadenti nelle notti agostane: San Lorenzo.
Secondo le cronache, il martirio del santo, il cui culto fu fortemente promosso dall’imperatore Costantino, (che fece erigere persino un tempio in suo onore) avvenne proprio il 10 di agosto, giorno a lui dedicato secondo il calendario cristiano: questa data è divenuta emblema della pioggia di meteoriti che si concentra, in questo periodo dell’anno, nella costellazione di Perseo.
Inoltre si tratta, anche, di uno dei numerosi esempi di festività cristiana derivata dal mondo pagano e ripresa per avvicinare e convertire alla nuova religione monoteista il maggior numero di romani. Il nome stesso di Lorenzo ben si predispone, infatti, ad essere associato a quello di Acca Larentia.
Nel tempo si sono, poi, attribuite ulteriori spiegazioni che riconducono la figura del martire valenziano alla pioggia di stelle: secondo alcune fonti si credeva che le stelle cadenti fossero i tizzoni ardenti del corpo del santo martirizzato sul rogo; in seguito, quando la storia del suo martirio lo volle non arso su una pira, ma decapitato, si passò ad associare lo sciame di meteoriti alle lacrime di Lorenzo.
In entrambi i casi queste manifestazioni del martirio venivano considerate doni propizi che il santo elargiva alle persone, le quali in questa notte potevano anche rivolgersi a lui per chiedere di esaudire un loro desiderio.
Le stelle quale simbolo di cattivo auspicio
Per la cultura cinese, ma anche per altre culture medio-orientali, le stelle cadenti non erano simbolo di fertilità, ma un presagio infausto, così come numerosi eventi naturali rari. Le stelle cadenti erano, infatti, associate al pianto degli dei e per questo ritenute negative, perchè se gli dei sono tristi e addolorati riversano il loro rancore sugli uomini.
Per i cinesi un imperatore era in pericolo ogni volta che si avvistava una cometa in cielo. Una visione curiosamente opposta rispetta a quella cristiana secondo cui fu proprio una stella cometa a guidare i magi a Betlemme per adorare Gesù bambino. I cinesi furono, tra l’altro, i primi a documentare l’osservazione scientifica di sciami di meteore.
Anche per i persiani il passaggio delle stelle cadenti era segno di cattivo auspicio e gli astri che attraversavano il cielo erano visti come demoni e streghe in fuga da Sirio, la stella più luminosa della costellazione del Cane Maggiore, che tornava a mettere ordine nella volta celeste. Al contrario delle meteore, Sirio rappresentava, infatti, un riferimento fisso nelle notti estive, essendo facilmente individuabile grazie alla sua intensa luminosità.
Ma anche nel mondo greco, che dava alle stelle cadenti una connotazione, come visto, positiva attraverso il mito di Priapo, si possono ritrovare interpretazioni negative di questo fenomeno. Se i cinesi ritenevano che le meteore fossero un brutto segno per l’imperatore, gli spartani studiavano il cielo e i suoi astri ogni nove anni durante il regno di un monarca, arrivando a deporlo se in una di queste occasioni osservavano il passaggio di una cometa.
Gli stessi greci paradossalmente, pur legando la caduta delle stelle ai festeggiamenti propiziatori dell’abbondanza, spiegavano in altre circostanze il fenomeno della pioggia di astri attraverso un mito dal finale triste. Si tratta della leggenda di Fetonte, figlio del dio del sole Helios, e di una delle ninfe del mare, Climene.
Sfidato a dimostrare di essere veramente il figlio di un dio, Fetonte un giorno chiese in prestito il carro del Sole al padre e lo sostituì nel suo compito di guidarlo intorno alla terra: durante la corsa, però, perse il controllo dei cavalli, portando scompiglio sia nei cieli, sia nel mondo terreno. Questo mito spiegava anche la nascita dei deserti, luoghi dove Fetonte sarebbe passato troppo vicino con il suo carro ardente, bruciando tutto quello che trovava lungo la sua corsa sfrenata. Per fermare il semidio incompetente dovette intervenire Zeus, costretto a colpirlo mortalmente con una sua saetta: le stelle cadenti sarebbero, quindi, i frammenti del corpo di Fetonte che da quel giorno piovono saltuariamente sulla terra.
Che sia visto come un dono o un cattivo auspicio, il fenomeno delle stelle cadenti non ha mai smesso di affascinare gli esseri umani nel corso dei secoli. E anche se oggi sappiamo che si tratta di frammenti di meteoriti e non esprimiamo più un desiderio al loro passaggio perché abbiamo perso il coraggio di sognare e ci accontentiamo di soddisfare solo i bisogni più superficiali, il cielo notturno continua ad affascinarci. La volta trapunta di stelle fa ancora battere forte il cuore a chi la guarda, pur in un’epoca in cui sembra non esserci più nulla in grado di stupirci. Ancora le stelle ispirano le opere degli artisti, ancora rappresentano la cornice migliore per gli innamorati.
E la notte di San Lorenzo, pur sapendo che non sono loro ad attraversare il cielo, non abbiamo smesso di alzare gli occhi e guardare all’insù per vederle cadere. ♦︎