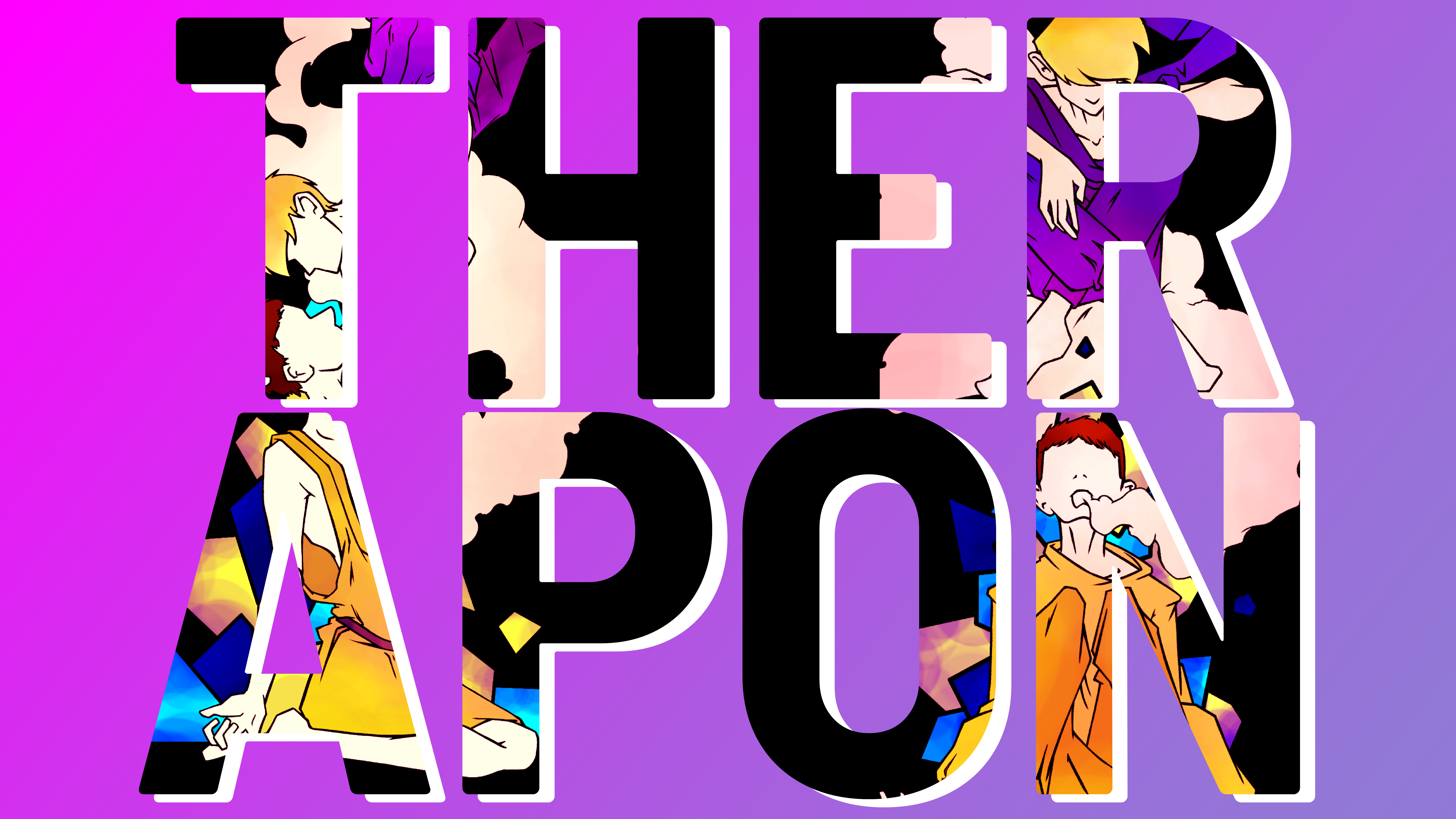La potatura
La mattina seguente mi svegliai ancora vestito di tutto punto, pronto per il sabato sera. Vidi moltissime chiamate perse sullo schermo del mio cellulare e altrettanti messaggi infuriati dei miei amici, non risposi e decisi di metterlo via, avevo bisogno di stare da solo. Scesi in cucina e trovai i miei genitori intenti in una inusuale colazione assieme, era la loro classica postura da “ramanzina del mattino” e infatti: “mi ha chiamato la mamma di Andrea questa mattina”, esordì mio padre, “dice che suo figlio e gli altri siano rientrati a piedi perché tu sei sparito a metà serata. Si può sapere dove sei andato?”. “A casa, papà”, dissi svogliatamente, “avevo bisogno di stare da solo”. Iniziai a versarmi il caffè e presi un plum cake impasta-bocca dalla dispensa ma sentivo distintamente i loro sguardi farsi più pesanti alle mie spalle. Non so perché ma cedetti a quell’osservarmi nell’animo e mi aprì con loro: “Sapete ho litigato con un mio amico, una cazzata a dir la verità, perché è tutto partito dal fatto che non abbiamo potuto fare questo tatuaggio insieme, ricordate?” e scoprì la manica svelando gli strani caratteri della parola “םימחר”, “rahmim”, “Da allora tutto è precipitato. Abbiamo discusso per ogni cosa e qualsiasi parte di me sembrava un problema. Alla fine ci siamo visti ma mi ha chiesto di sparire dalla sua vita ed è stato brutto sapete? Ieri sera l’ho rivisto, e ho visto anche uno strano tipo che mi diceva che sono un apanthes, un adulto senza cuore proprio per questo litigio, diceva anche che cerco la perfezione e che non sarò mai felice e ancora …” le parole mi si strozzarono in gola. Piansi come un bambino o forse piansi davvero per la prima volta come un adulto: l’angoscia del futuro non l’avevo mai avuta, ora era lì e mi guardava negli occhi così insistentemente da paralizzarmi. Bruciavo di dolore e le lacrime che solcavano il mio viso per ricadere in una barbetta incolta altro non facevano che ustionare una pelle ferita. Mi abbracciarono, quei genitori che per anni avevo pensato distanti e freddi tutto d’un tratto era diventati i miei migliori alleati, anche papà con i suoi inquietanti occhiali blu elettrico pareva aver messo in gioco quel virile affetto degli anni 70. “Forse dovresti prenderti una pausa da loro” mi disse mentre le mani ruvide accarezzavano il mio capo quasi grattando via i capelli, “un mio amico molti anni fa è entrato in un monastero, lontano da qui, nella zona della Val de Grupo, hanno una sorta di foresteria per chi ha bisogno di rimanere da solo e riflettere. Che dici? Ti prenderesti questo tempo per te?”
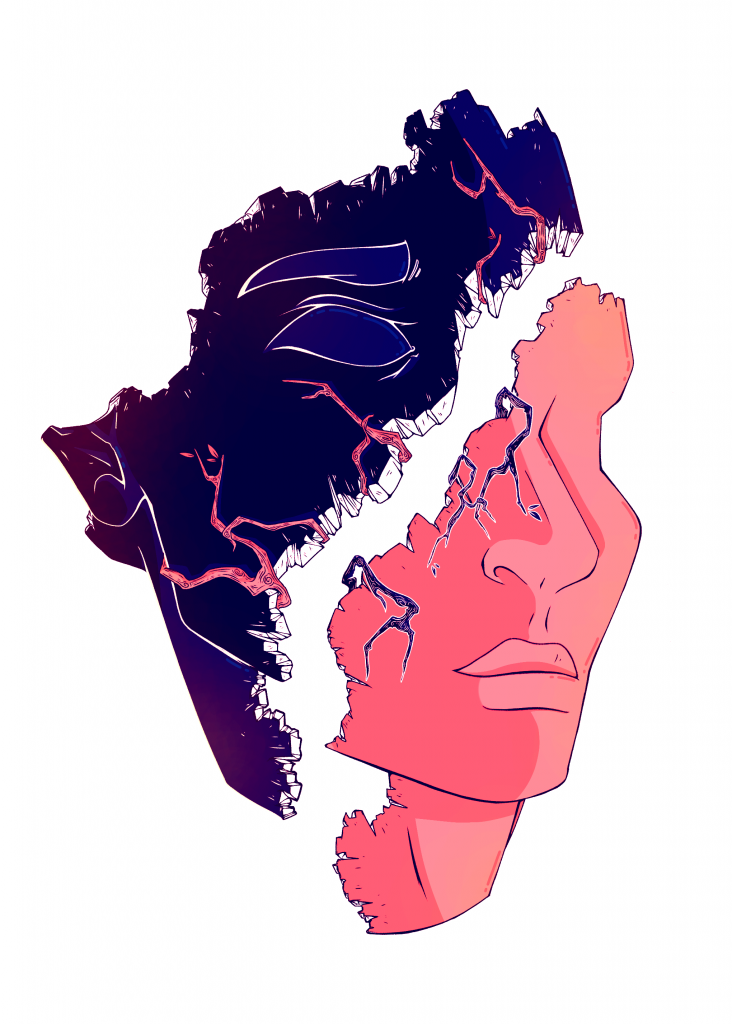
Ripensai all’uomo in giacca e cravatta, forse la soluzione era affrontarlo e per ora era comparso solo nei momenti di fragilità più intimi. Stando da solo potevo incontrarlo senza essere interrotto, nel caso in cui si fosse ripresentato. “D’accordo papà, non ho nulla da perdere tanto”, questa volta quelli sorpresi erano loro. L’ultima volta che ho acconsentito ad una loro proposta probabilmente avevo 10 anni. Salì in camera ed iniziai a preparare una valigia. Ci misi più roba possibile, non potevo sapere quando tempo avrei dovuto passare in quella solitudine e con cura certosina inizia a comporre un bagaglio di ricordi: la maglietta regalatami dai miei amici per il compleanno, i jeans consumati della festa in collina della scorsa estate, la felpa di istituto, i calzini di spugna della Nike, un paio di Vans logore come solo gli adolescenti sanno portare, la biancheria e gli asciugamani. Le lacrime ricominciarono a scendere, questa volta tra i singhiozzi e la nostalgia. Presi qualche libro per combattere il silenzio e spensi il telefono definitivamente. Quando un ragazzo spegne il telefono le cose sono due, cari lettori, o si sta divertendo o sta soffrendo in maniera inspiegabile, qui era sicuramente il secondo caso. Terminati i bagagli mi resi conto che mio padre era rimasto sulla porta ad osservarmi tutto il tempo, senza dire una parola, come quei medici che studiano con attenzione e angoscia un paziente dolorante. Mio padre era un uomo semplice e dai modi all’apparenza bruschi ma tipici di chi è cresciuto con il sole della campagna che accarezza la pelle. Faceva l’agricoltore, un mestiere duro ma che gli aveva insegnato più cose sulla vita di quanto una buona prof di filosofia potesse mai fare. Non parlavamo molto noi due, mio padre sapeva giocare di sguardi e di emozioni mosse al momento giusto. Si sedette sul mio letto oramai troppo piccolo per il mio metro e 80 di altezza e con tono dolce come mai avevo sentito mi disse: “So bene cosa ti sta accadendo, Federico”, si passo una mano sul volto come a raccogliere le forze sparse sul viso, “quando è necessario far crescere una pianta io e i miei garzoni scegliamo con cura i rami da tagliare, un taglio errato può portare la perdita della produttività dell’arbusto, e nel momento in cui il taglio viene fatto la pianta “piange”. La linfa cola lungo i rami, e quando termini la potatura sembra quasi che la pianta sia stata menomata della sua bellezza. Rimane un tronco con pochi rametti verdi e le gemme su di esso, nulla di più. Se hai fatto un buon lavoro, col tempo, la pianta darà frutto e ti sembrerà impossibile che un arbusto menomato abbia potuto donare così tanto e così gratuitamente. Non sei amputato Federico, sei stato potato dalla vita”. “Ma io stavo bene prima papà, ero felice”, dissi con voce gracchiante, “che vergogna farmi vedere così” mi dissi mentre cercavo di capire le parole di quell’agricoltore di mezz’età. Si alzò senza aggiungere altro, mi diede una pacca sulla spalla e con il solito fare burbero mi intimò “Forza, non hai tempo da perdere. Accendo la macchina e partiamo”. E mi lasciò lì tra le lacrime e la speranza di un frutto buono. Caricai le valige e partimmo, ancora non sapevo che quel viaggio avrebbe cambiato il corso della mia storia.