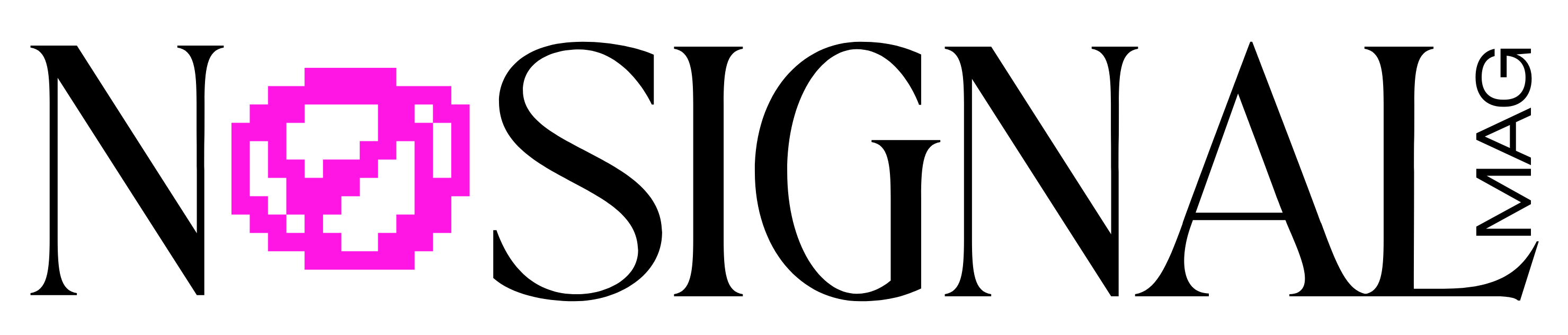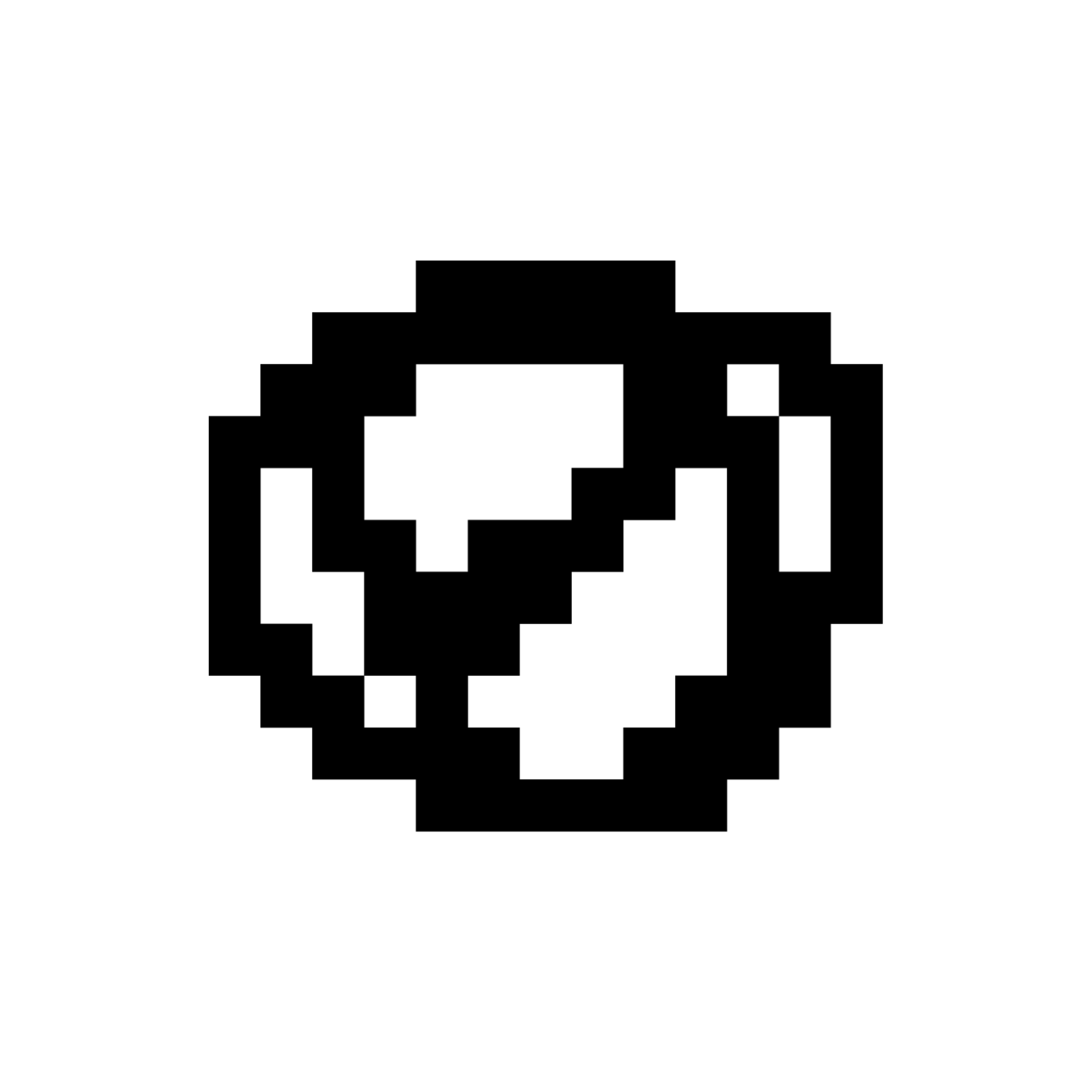Sucre, capitale costituzionale della Bolivia, mi accoglie con la sua luce abbagliante e il candore delle sue case coloniali, in netto contrasto con l’intenso azzurro del cielo. Questa città è uno stato d’animo, un inno alla lentezza e alla gioia di vivere. Passeggiando per le sue strade, vengo conquistata dall’atmosfera semplice e di genuina allegria, quasi contagiosa. Qui la vita scorre lentamente: la gente si gode la siesta, i negozi e i musei chiudono nelle ore centrali della giornata per riaprire nel pomeriggio. Non percepisco stress. Ma c’è di più. Girovagando per il centro, avverto una forza particolare: l’energia femminile e la fierezza delle donne. Nell’aria si respira un grande senso di emancipazione e libertà. Molte donne boliviane hanno avuto un ruolo dominante nella storia, e il loro coraggio riecheggia ancora oggi. Una forza che risplende nei volti segnati dal tempo e nelle loro mani abili che intrecciano tessuti su antichi telai. Questa città sembra portare con sé l’eco delle lotte femminili, un richiamo alla loro determinazione e al loro contributo storico.
L’attivismo delle donne boliviane
In Bolivia il ruolo della donna non è confinato alle mura domestiche né alla tessitura tradizionale. Le donne boliviane hanno scritto capitoli importanti nella storia del Paese, dimostrando forza, coraggio e determinazione in varie occasioni. Nel 1957 un gruppo di donne coraggiose — guidate da Elffy Albrecht, Anita Suarez, Alicia Ribera de Cerruti e Giselle Bruun — fondò la prima organizzazione civile femminile a Santa Cruz de la Sierra. Questo gruppo sostenne il Comitato Pro Santa Cruz nella lotta per ottenere l’11% delle regalie petrolifere, una percentuale delle entrate generate dall’estrazione del petrolio destinata allo sviluppo della regione. Si trattava di una battaglia cruciale per garantire maggiore equità economica e supportare le infrastrutture locali.
Uno degli episodi più emblematici di questa lotta avvenne il 7 novembre 1957, quando oltre cento donne occuparono il palazzo municipale di Santa Cruz e organizzarono il primo sciopero della fame femminile nella storia boliviana. Queste donne non lottavano solo per questioni economiche, ma per una visione di giustizia sociale e autonomia politica. Oggi, l’eredità di queste attiviste vive nel Comitato Civico Femminile e nell’impegno di molte imprenditrici boliviane, che continuano a promuovere lo sviluppo delle loro comunità. Ma l’attivismo delle donne in Bolivia ha radici ben più antiche, incarnato da figure storiche straordinarie come Juana Azurduy Padilla, che hanno lasciato un segno indelebile nella lotta per l’indipendenza del Paese.
Juana Azurduy: un simbolo di lotta e coraggio
Prima di arrivare a Sucre, non conoscevo la figura di Juana Azurduy Padilla. Viaggiare serve anche a questo: ampliare la nostra cultura e conoscenza. Juana è stata una leader guerrigliera durante la lotta per l’indipendenza boliviana; una donna indigena che ha combattuto valorosamente contro le forze coloniali spagnole insieme al marito Manuel Ascencio Padilla. La sua storia è un esempio del ruolo cruciale delle donne nei movimenti rivoluzionari, anche se, nonostante il suo eroismo, Juana non ricevette il riconoscimento che meritava durante la sua vita. Oggi, però, è considerata una figura eroica e un simbolo di uguaglianza e resilienza. A Sucre, diversi murales e dipinti la ritraggono con uno sguardo severo e marcati lineamenti indigeni, segno di un’identità mai rinnegata. Juana non è solo una figura del passato: incarna lo spirito delle donne boliviane, che oggi come allora lottano per i loro diritti e per affermare la propria autonomia.
La recoleta, il quartiere delle tradizioni
Prima di lasciare Sucre per raggiungere Potosi, decido di esplorare l’antico quartiere della Recoleta. Dopo una colazione a base di succo di mango fresco preparatomi da Agostine, mi inerpico lungo salite e scalinate caratteristiche, decorate con murales colorati che sono autentiche opere d’arte. Ogni murales lancia un bellissimo messaggio. Uno mi colpisce in particolare. Si trova in cima alla scalinata che porta al museo dove mi sto dirigendo; raffigura una veduta di Sucre con le Ande sullo sfondo e la scritta in spagnolo recita così (tradotto) “forse non abbiamo tutto, ma abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno” . Parole semplici e rimbombanti, che invitano alla riflessione e che riflettono la resilienza e l’autenticità della cultura boliviana.
Cammino in queste prime ore del mattino e mi sento felice. L’energia in questa città è fantastica. Finalmente raggiungo la mia destinazione: il museo delle etnie indigene. Un luogo che definire museo è sbagliato, essendo uno spazio culturale vivo, attivo, che mantiene una tradizione centenaria, preservando e contribuendo all’economia locale e al sostentamento delle donne Yampara. L’unica entrata di questo centro è data dai biglietti di ingresso (oggi di 25 bolivianos, che pago con piacere per sostenere la causa) e dalla vendita dei prodotti di artigianato artistico esposti. I tessuti che si trovano qui sono preziose opere d’arte, rigorosamente fatte a mano. Una tradizione ancestrale, che vive dentro ogni donna indigena; un sapere che si trasmette nel DNA da madre in figlia e che le nonne hanno il compito di mantenere viva nella memoria, raccontando aneddoti e storie alle proprie nipoti, affinché capiscano quanto questa lavorazione tessile sia parte intrinseca della loro cultura e identità.
Visitare il Museo delle Etnie Indigene è come immergersi in un mondo antico. Le donne Yampara tessono a mano opere d’arte utilizzando tecniche tramandate di generazione in generazione. Ogni pezzo, dagli axsu ai poncho, è unico e racchiude storie di matrimoni, rituali e scene di vita quotidiana. Mi affascina sapere che realizzare un axsu richiede mesi di lavoro; il risultato è un capolavoro che celebra la cultura e l’identità indigena. Non si tratta solo di tessuti, ma di un modo di preservare un legame con il passato e di affermare la propria identità in un mondo sempre più globalizzato e uniformato. Non mi sorprende che questi manufatti siano riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Rifletto sull’importanza dell’appartenenza e dell’identità culturale. Questa lavorazione artigianale racchiude qualcosa di più profondo. Un chiaro e deciso senso di appartenenza indigeno, di cui la gente del posto è estremamente orgogliosa e gelosa, come è giusto che sia. Per noi è difficilissimo da capire, perché stiamo lentamente perdendo il senso di appartenenza, plagiati e manipolati da una globalizzazione che cerca di omologarci, sradicandoci dalle tradizioni. Qui le persone si vestono cucendosi a mano gli abiti tipici, con colori e figure specifiche, in base all’ etnia di appartenenza. Un segno di distinzione e riconoscimento. Noi ormai ci vestiamo dalle grandi marche, che propongono le stesse cose ovunque, da Milano a Lisbona a Londra… Morale: siamo tutti uguali, figli di Zara, Mango , Tiffosi, Tezenis, tanto per citarne alcune delle più comuni marche, globalmente riconosciute. Così, andare a far shopping in centro a Roma oggigiorno è come andare a Parigi o Porto: trovi le stesse cose, ovunque. Peccato. Come se essere diversi e distinguersi dalla massa fosse un segno di debolezza. Ci si vergogna spesso delle proprie origini, usi tipici e tradizioni, che consideriamo “roba da vecchi”. Qui si lotta per il contrario: difendere la propria appartenenza, cultura, ideologia e identità, che è diversa dalle altre. Unica. Per questo, patrimonio dell’umanità, da tutelare.
Il valore delle scelte
Acquistare un tessuto o visitare il laboratorio artigianale non è solo un modo per immergersi nella cultura locale ma è anche un modo per sostenere le comunità femminili coinvolte. Questi piccoli gesti alimentano un’economia che valorizza il lavoro delle donne e protegge tradizioni millenarie di una cultura distante dalla nostra, proprio per questo interessante e affascinante.
La responsabile dello spazio artistico mi spiega per filo e per segno il progetto, come è nato, il ruolo fondamentale che ha nell’appoggio e sostegno delle comunità femminili e come la realizzazione e la vendita dei tessuti sia fonte di reddito per le donne che vivono in aree remote rurali, difficilissimi da raggiungere, se non con giorni di cammino in mezzo al nulla. Mi segnala poi il villaggio di Potolo, una comunità isolata tra le Ande, famosa per il mercato indigeno e i colori dei suoi tessuti. Mi prometto di tornare con un gruppo di donne viaggiatrici, per esplorare questi luoghi dove il turismo può davvero avere un impatto positivo.
Prima di uscire scatto qualche fotografia a una donna indigena che, seduta a terra, sta abilmente tessendo il suo telaio e realizzando un tappeto meraviglioso, con la tecnica “pallay”. Rimango sempre allibita dalla velocità e maestria con cui le donne riescano a tessere. Io che a fatica riattacco un bottone, mi rendo conto di quanta arte e sapere ci sia dietro quei gesti veloci, per nulla semplici.
Oltre i telai
Lasciare Sucre non è facile. Questa città, con la sua energia vibrante, mi ha insegnato che l’emancipazione femminile è un mosaico di storie e che le donne boliviane continuano a tessere il loro futuro con coraggio e determinazione. Sento che qui, tornerò. Di questa storia parlo in maniera più approfondita nel mio libro Sotto il Cielo di Atacama, nato proprio alla fine del mio viaggio in solitaria tra Cile e Bolivia. Un libro che racchiude tante storie di donne, incontri straordinari e approfondimenti storici, intrecciati con le mie avventure personali. Spero che queste pagine possano ispirare chi le legge a valorizzare il ruolo unico e insostituibile delle donne nella costruzione di un futuro più equo e consapevole. ♦︎
Testi e immagine di copertina di Ilaria Bonfante