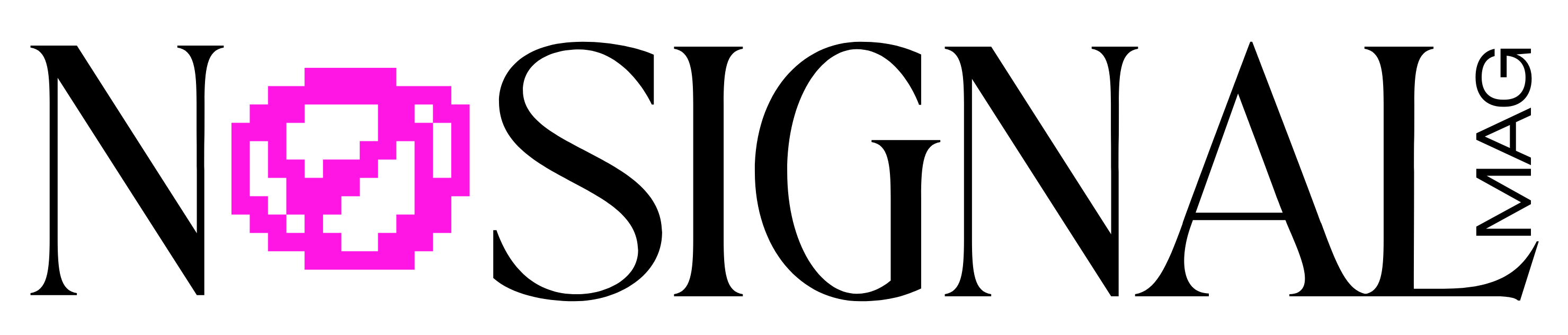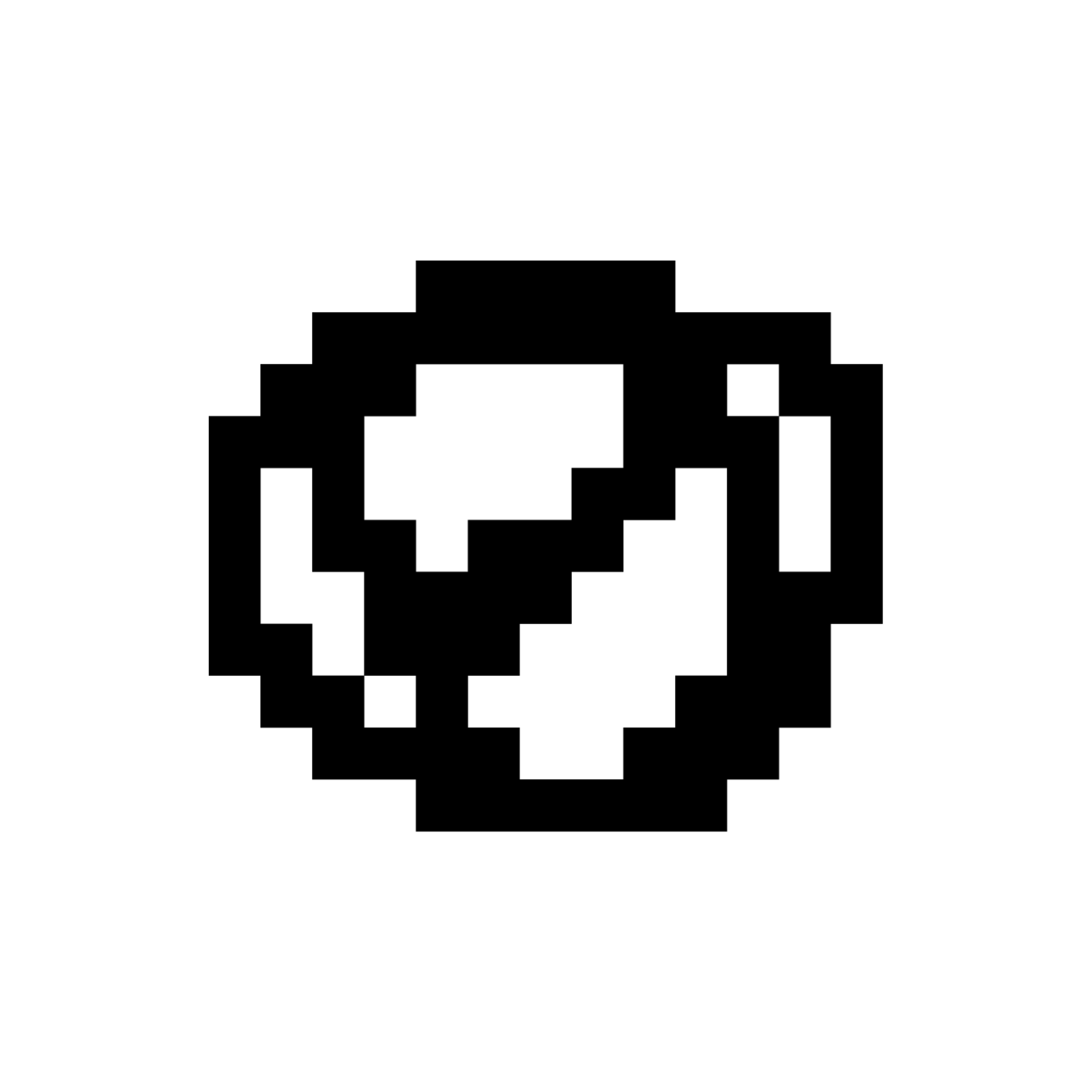Nel romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, pubblicato in Italia da Einaudi nel 2023, il protagonista è convinto che un suo nuovo compagno di scuola sia un serial killer conosciuto come il Pescatore a Strascico, che terrorizza la Los Angeles degli anni Ottanta. Il dubbio finisce per trasformare il protagonista in uno stalker che monitora tutti i movimenti del presunto omicida, nei cui confronti nutre un misto di odio e interesse. Osservare qualcosa che si detesta, ma da cui non si riesce a distogliere lo sguardo, è un’abitudine diffusa, al punto da meritare una serie di neologismi digitali: si passa dall’hate-watching all’hate-following, fino all’hate-reading. La parola hate-watching, coniata nel 2012 dalla critica Emily Nussbaum, fa riferimento al guardare programmi televisivi con l’intenzione di criticarli e ridicolizzarli. Un’esperienza lontana dal concetto di guilty pleasure, che prevede il godersi qualcosa pur essendo consapevoli della sua scarsa qualità. L’hate-reading riguarda la lettura di libri, mentre l’hate-following appartiene al mondo dei social, descrivendo la tendenza a seguire gli account di persone che si detestano, con l’obiettivo di contestarne ogni foto, post o video.
Chi fa hate-watching dedica parte del suo tempo ad analizzare storie che disprezza, cercandone i difetti e, spesso, condividendo le proprie opinioni online, unendosi a comunità di hater che condannano i peccati capitali della televisione: lo scarso realismo, la bassa qualità dei dialoghi, la recitazione da saggio di fine anno, il declino rispetto alle prime gloriose stagioni di una serie, che verranno idolatrate e contrapposte alla sua disastrosa prosecuzione. Più aumenta la quantità di programmi disponibili, più crescono le comunità dedite alla visione con il solo scopo di odiare, smontando film e serie tv con un cinismo e un impegno che hanno più a che fare con lo sfogo che con la critica cinematografica. Serve una buona dose di dedizione, d’altronde, per sorbirsi volontariamente dieci episodi pieni di buchi di trama, stereotipi e cliché. Le vittime di questa abitudine, o forse i carnefici, a seconda del punto di vista, comprendono una vasta gamma di esemplari, che vanno dal reality show a prodotti televisivi che si prendono molto sul serio, deludendo le proprie grandi ambizioni con un’esecuzione discutibile. L’hate-watching è poi intensificato dalla possibilità di fare binge-watching, guardando un’intera serie tv di fila, punendosi con otto o dieci ore di ininterrotta pessima televisione.
La rabbia, il fastidio, la polemica, la possibilità di esprimere pubblicamente il proprio crescente orrore, diventano la ragione stessa per continuare a guardare. Una forma di evasione dalla realtà anomala ma efficace: un programma che non piace agli spettatori farà sì che questi lo scartino, selezionandone un altro, mentre un programma che riesce a suscitare odio li incoraggerà a proseguire fino alla fine. Questa tortura auto-inflitta si spiega in parte con gli ormoni rilasciati quando si sperimentano emozioni intense, e con quel masochistico divertimento che si prova nel fare a pezzi qualcosa, fluttuando tra la soddisfazione e l’indignazione. Ogni utente ha le sue preferenze, più o meno popolari. Può capitare persino che le storie più odiate riescano ad arrivare in cima alle classifiche. Emily in Paris, la cui trama ruota attorno a Emily Cooper, che si trasferisce da Chicago a Parigi per lavorare in una società di marketing, ha raggiunto la soglia dei 58 milioni di spettatori nel primo mese dall’uscita della prima stagione, pur comparendo spesso nelle liste delle serie più hate-watched. Lo stesso vale per Riverdale, teen drama ispirato ai fumetti della Archie Comics, rinnovato per sette stagioni nonostante le critiche online. Il motivo per cui guardiamo o leggiamo qualcosa è del tutto irrilevante, perché il successo si nutre dell’engagement di fan e hater. Chi crea un post per manifestare la propria delusione rischia anzi di incentivare la proliferazione di prodotti simili a quelli che disprezza, incrementandone la visibilità e facendo sì che se ne parli. Altro rischio, che interessa il versante più umano della questione, è quello di abituarsi alla critica distruttiva a tutti i costi, scatenando ondate di ostilità verso autori e attori.
A che serve finire otto stagioni con episodi di quaranta minuti, se non ci si diverte neanche? L’analisi di quello che guardiamo è un’attività di per sé sana e necessaria. Direzionare la propria frustrazione verso un reality show, sfoggiando capacità critiche che farebbero impallidire la giuria degli Emmy Awards, può essere comprensibile finché si tratta di un’abitudine limitata, che non approda al discorso d’odio a tutti gli effetti. Al di là dei dubbi su quanto sia proficuo trascorrere ore del proprio tempo a guardare o leggere qualcosa che non ci piace, se l’hate-watching riesce a trasformare prodotti mediocri in storie virali, forse stiamo sbagliando qualcosa. La cattiva televisione non può farci del male, purché continuiamo a riconoscerla e, a volte, a concederci di guardarla. Non per farla a pezzi, ma per puro e semplice intrattenimento. ♦︎