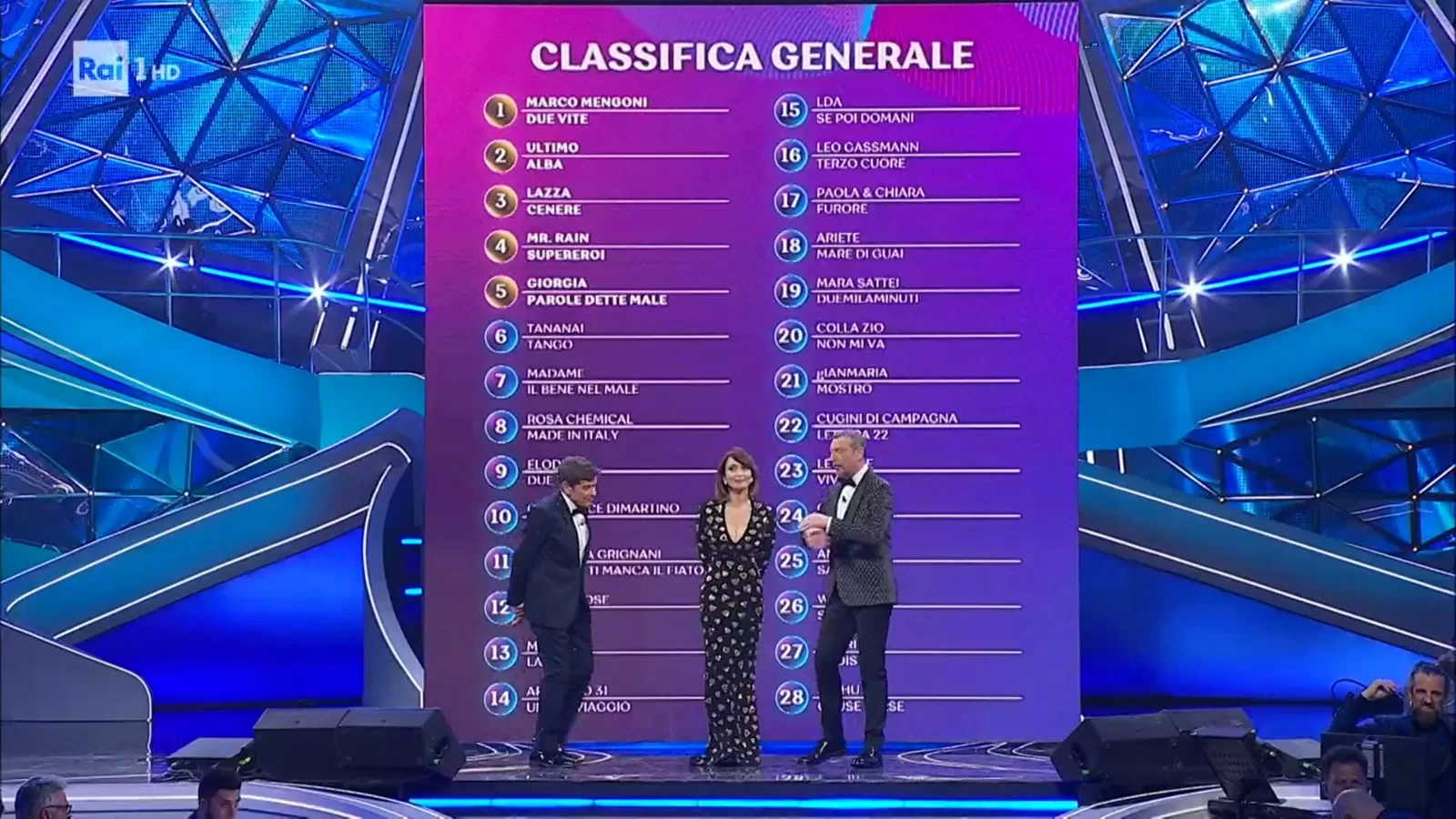Da The Sound of Silence a Seven Psalms, il lungo percorso di ricerca spirituale del cantautore newyorkese attraverso sessant’anni di canzoni
È sempre rischioso per un cantautore popolare parlare di temi esistenziali. Richiede un certo grado di comprensione e riflessione maggiori da parte del pubblico, che oggi è abituato a un tipo di produzione musicale molto più veloce, diretto, esplicito, così esplicito da lasciare ben poco spazio tra le righe del non detto. Anche la durata dei brani si è drasticamente abbassata, in linea con la riduzione dello span medio di attenzione che riusciamo a mantenere (ormai solo 8 secondisecondo gli studi più recenti). Affinché una canzone abbia quantomeno la possibilità di diventare virale, la sua durata media «deve stare sotto i 3 minuti e 15 secondi» – parola di un titano dell’industria musicale contemporanea come Mark Ronson, in un’intervista al Guardian del 2019. Eppure, c’è chi contravviene a queste tendenze. Ci sono artisti infatti che, infischiandosene delle direttive dettate dalle classifiche, e forti dello status di leggende, producono pezzi anche dieci volte più lunghi di questo standard. Nel 2020, Bob Dylan ha pubblicato Murder Most Foul, cronistoria sotto forma di canzone dell’omicidio del Presidente Kennedy, lunga quasi 17 minuti. Tre anni dopo, nel maggio del 2023, è toccato a Paul Simon, il cantautore metà dello storico duo Simon & Garfunkel, superare quel limite: con Seven Psalms, il suo ultimo album, formato da un’unica tracciadella durata di ben 33 minuti.
I Sette Salmi di Paul Simon
Veniamo dunque a Paul Simon, che proprio oggi, 13 ottobre, spegne la bellezza di ottantadue candeline, e a questa sua più recente uscita musicale così insolita, Seven Psalms. Composto da sette ‘movimenti’ che, susseguendosi senza interruzione, vanno a formare l’unica traccia presente, il disco segue il flusso mentale del cantautore mentre, quasi colto in un limbodi estasi onirica (sembra che proprio in sogno gli sia giunta l’idea per questo album) riflette sul confinelabiletra vita e morte, sulla grande incognita del ‘dopo’, passando in rassegna timori, congetture, domande che caratterizzano, dall’alba dei tempi, l’essere umano quando si trova alle soglie dell’ignoto. La morte, certo, è uno spunto di riflessione molto presente in questo album, ma, pensandoci bene, è da sempre un leitmotiv di Simon. Troppo facile descrivere quindi Seven Psalms solo come un testamento musicale, come fu per Thanks for the Dance del canadese Leonard Cohen e Blackstar del divo Bowie. Si tratta più che altro di una ‘variazione senile’ sulle tematiche esistenziali di cui la musica di Paul Simon ha sempre trattato, dai primi anni ‘60 a oggi.
Le sue, infatti, non sono mai state ‘solo canzonette’ (come invece canta il buon Edoardo Bennato): tutta la produzione di Simon – sia in coppia con Garfunkel che come solista – è attraversata da una perenne tensione verso l’Alto e verso l’Altro, una ricerca spirituale che lo ha portato a spaziare in lungo e largo nel sincretismo religioso e culturale, per trovare le parole e i suoni più adatti a dare voce alle sue idee. Una sensibilità forse troppo spiccata per un giovane cantautore che nel lontano 1964 si affacciava sulle scene mondiali dominate daBeatles e Rolling Stones ancora nella loro fase spensierata, con un brano importante come The Sound of Silence, all’inizio frainteso e snobbato, poientrato nella colonna sonora della contemporaneità, il cui testo è un primo esempio di quella che diventerà la poetica spirituale di Paul Simon, sempre votata a una ricerca di senso nell’amalgama del presente.
Ebreo, ma non troppo
Sarebbe riduttivo ricondurre la spiritualità dei testi di Paul Simonsolo al suo background semitico, cresciuto in una classica famiglia di ebrei newyorkesi di una middle class più votata all’intellettualismo laico(padre musicista e docente universitario, madre maestra elementare) che all’ortodossia ebraica. La sinagoga era un luogo frequentato, ma più per un senso di appartenenza e tradizione che per una vera vocazione religiosa. Però l’elemento musicale che accompagnava i riti avrebbe lasciato un’impronta nella creatività di Simon, tant’è che, nonostante tutta l’acrimonia che ha portato – oramai da decenni – ad allontanare sempre di più i due ex-amici, Paul ricorda ancora con affetto e stupore la celebrazione del Bar Mitzvah di un adolescente Artie Garfunkel, che con la sua voce da ‘cherubino ebreo’ avrebbe lasciato a bocca aperta lui e tutta la comunità di Kew Garden Hills.
Effettivamente, rispetto ad altri colleghi con lo stesso background come Bob Dylan e Leonard Cohen, i riferimenti diretti al mondo ebraico sono molto più limitatinella discografia di Paul Simon. Uno di questi è certamente rappresentato da Silent Eyes, traccia poco conosciuta dell’album Still Crazy After All These Years (1974), probabilmente perché mai eseguita dal vivo, in cui Simon si rivolge direttamente alla città sacra per eccellenza per gli ebrei (e non solo), Gerusalemme, che «piange da sola, brucia come una fiamma» e chiama a sé testimoni che davanti agli occhi di Dio possano parlare in sua vece di un non precisato «what was done». La critica ha poi letto in questo criptico testo – che riprende nel tono e in parte anche nel lessico quello del Libro delle Lamentazioni, una raccolta di inni poetici dedicati alla desolata Gerusalemme, distrutta nel VI secolo a.C. dai babilonesi – un richiamo agli orrori della Shoa, mai confermato però dall’autore.
Il Cristianesimo: the Ace in the Hole
Il maggior bacino religioso da cui Paul Simon ha attinto nella sua lunga carriera musicale è stato però quello cristiano: pervasivo e onnipresente nella poetica di ogni autore occidentale, sia come ispirazione positiva che bersaglio per le critiche, a prescindere poi dalla soggettiva spiritualità. Dal punto di vista prettamente formale, fin da subito il giovane Paul ha attinto a piene mani dagli stilemi musicali di provenienza cristiana. Già nel primo album con Garfunkel, Wednesday Morning 3 A.M. (1964), troviamo una versione a cappella del Benedictus, un antichissimo inno in latino che trova la sua origine nel primo capitolo del Vangelo di Luca, dove il sacerdote Zaccaria lo intona per la prima volta dopo aver ritrovato la fede e la voce (era stato reso muto da un angelo per l’incredulità mostrata davanti alla miracolosa gravidanza di sua moglie Elisabetta, oramai in età avanzata, che darà poi alla luce Giovanni il Battista) per rendere lode a Dio. Quello presente nell’album è un arrangiamento proveniente da un mottetto a due voci di Orlando de Lasso, compositore del XVI secolo, scovato da Garfunkel in uno scaffale polveroso della biblioteca della Columbia University.
Le Sacre Scritture tornano anche in Duncan, brano del ’72,in cui il protagonista viene metaforicamente salvato dalle parole di una giovane predicatrice (per poi farci l’amore poco dopo e ringraziare Dio per questo). Un Dio che viene chiamato in causa molte volte: a benedire gli assenti, i nomadi della musica come Paul e la sua band in God Bless the Absentee, o alla cui porta ci si ritrova a bussare quando tutto va a rotoli in Some Folks’ Lives Roll Easy. Ma non è solo il ‘Grande Capo’ a essere citato: Gesù Cristo in persona è definito Ace in the Hole, l’asso nella manica da sfoderare al momento meno atteso, che per un artista ebreo è alquanto ironico. Altri personaggi biblici vengono invece usati come alter ego dell’autore – il famoso Jonah dell’omonimo brano, che invece di essere ingoiato da una balena, viene fagocitato da una canzone – o che inaspettatamente prendono parola in una sorta di ‘commedia celeste’ – come lo strano Arcangelo “Fat Charlie” in Crazy Love, Vol. II, che si rifiuta di mettere il naso nella vicende turbolente di una coppia in crisi (ovvero quella dello stesso Simon con la storica compagna Carrie Fisher).

Andando avanti veloce nei secoli della cultura musicale cristiana, grandissima influenza nella carriera di Simon è da attribuire alla musica gospel, sia per i contenuti che per lo stile musicale. In primis Bridge Over Troubled Water, il capolavoro del 1969: canto del cigno della partnership con Garfunkel, non è altro che un inno gospel diluito dalla tipica malinconia ‘simoniana’, nato dopo l’ascolto intensivo di un disco dei The Swan Sileverstones, gruppo canoro maschile molto famoso negli Anni ’50. Infatti, senza nulla togliere alla performance impeccabile e leggendaria dell’ugola angelica di Artie Garfunkel, che la versione del 1973 cantata da Paul assieme alle Jesse Dixon Singers resta forse la più suggestiva, (nonostante un orribile taglio di capelli che sfoggiava all’epoca) .
A quello stesso anno risale Loves me like a Rock,chesi rifà invece alla tradizione gospel dai toni più vivaci, quella delle cantate popolari dai ritornelli anaforici e orecchiabili, che le voci calde e profonde dei Dixie Hummingbirds – altro gruppo canoro maschile del Sud – rendono alla perfezione nei cori che fanno da eco alle parole di Simon. La storia è molto semplice: un uomo che, nonostante le tentazioni che il diavolo gli ha proposto fin da bambino, ha sempre resistito soprattutto grazie all’affetto di sua madre, la quale «she loves me like the Rock of Ages», titolo di un famosissimo inno protestante composto 1775, simbolo di fede e protezione.
Il gospel come mezzo d’espressione resta uno dei più amati dal cantautore newyorkese, tanto che nel 1987 fu il fautore di A Night of Gospel Glory, un concerto evento dove Simon si esibì come accompagnatore delle più grandi voci del genere, guadagnandosi un posto d’onore nel panorama della musica black, nonostante la sua innegabile ‘bianchezza’.
La tribù dei Santi
Nella ricerca di suoni e significati nuovi, dal Gospel alla musica sudafricana il passo per Paul Simon è stato (relativamente) breve. A metà degli Anni ’80, dopo una serie di delusioni personali e lavorative, Paul è a caccia di qualcosa di nuovo che lo aiuti a uscire dallo stato di inerzia e depressione in cui è scivolato. È qui che arriva un’audiocassetta dei Ladysmith Black Mambazo, un gruppo corale sudafricano a lui sconosciuto: è amore al primo ascolto. Parte così la straordinaria esperienza fatta di viaggi, polemiche e concerti che troverà il suo compimento nel 1986 con Graceland, album dal successo planetario che segna una svolta non solo nella carriera di Simon, ma in generale per la neonata World Music di cui Simon è giustamente considerato uno dei padri fondatori.
Una tortuosa strada verso la grazia: ecco spiegato il viaggio descritto in Graceland, il brano che dà titolo all’album. Un’esperienza collettiva che assomiglia sempre più a un pellegrinaggio quasi religioso – come la ‘Great Migration’ citata all’inizio di Seven Psalms – verso una fantomatica Terra Promessa nascosta forse proprio dietro i cancelli della villa del mitico Elvis, il Re del Rock ’n Roll, metafora di un’entità superiore, idolo a cui domandare, appunto, la grazia.
Dall’esperienza sudafricana, Paul Simon prosegue sull’onda della ricerca musicale internazionale spostandosi però verso l’America meridionale e il Brasile nello specifico, dove trova nuova ispirazione per l’album del 1990, The Rhytm of the Saints. Il titolo è già una dichiarazione programmatica: ma chi sono questi santi? Non sono certo quelli di cristiana memoria; o meglio, non solo. Quegli strani nomi – Oludomare e Babalu-Aye – citati da Paul nel brano eponimo del disco sono infatti divinità del pantheon delle credenze Yoruba, vasto gruppo etno-culturale originario dell’Africa occidentale, diffusosi poi anche in Brasile, Cuba, Giamaica e dintorni durante la tratta degli schiavi. In questo mosaico compositivo non c’è solo il fascino per i ritmi sincopati e ipnotici della tradizione tribale, o il semplice gusto per un esotismo vacuo da colonizzatore bianco. Che si tratti di martiri con l’aureola, profeti barbuti o spiriti della foresta, per Paul Simon non c’è alcuna differenza: è il ritmo dei santi, le voci degli spiriti, che possono guidare anche un ateo convinto come lui verso un orizzonte di senso più ampio e inclusivo.
Quasi come casa
La vocazione spirituale che attraversa l’intera vita artistica di Paul Simon prescinde quindi da qualsiasi fede religiosa, perché, anche quando vengono citati elementi riconducibili chiaramente all’Ebraismo, al Cristianesimo, o a culti più antichi e tribali, non lo si fa con un intento differente, ma sempre nell’ottica comune della ricerca di senso, verità e consolazione, per avvicinarsi in qualche modo al nodo esistenziale che lega intotol’umanità pensante.
Questo lungo percorso ha reso Paul Simon una specie di profeta laico, un pellegrino musicale che in più di mezzo secolo di carriera ha raccolto suggestioni, immagini e storie, viaggiando da un capo all’altro del mondo – da una sinagoga del Queens, passando per le messe gospel delle Chiese nere, fino ai riti ancestrali del folklore sudafricano e brasiliano. Seven Psalms, summa del microcosmo creativo messo su da Simon, si pone quindi come preludio di un possibile punto di arrivo di questo percorso oramai familiare, perché come recita The Wait, coda finale del disco, «it’s almost like home».
Illustrazione di Giovanni Gastaldi