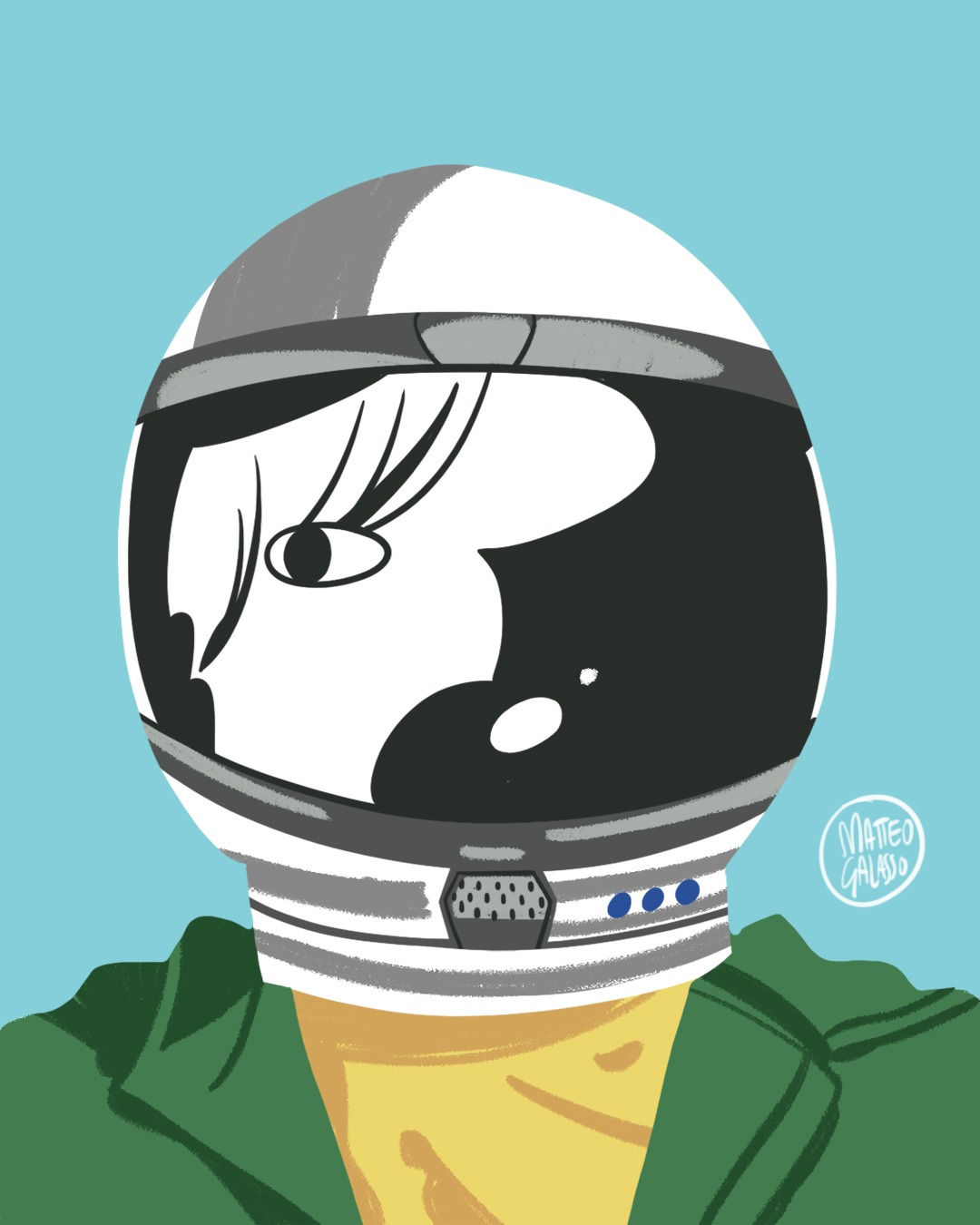Uno (s)fortunato incontro
Una coppia di italiani chiacchiera in un ascensore a Parigi. Sono in vacanza per godersi qualche giorno di svago. Salire sulla Tour Eiffel, pomeriggi di shopping e un plateau di ostriche da instagrammare alla prima occasione. Questo è quello che probabilmente hanno sognato quando programmavano il viaggio, qualche mese fa. Lei porta abiti firmati e ha delle decorazioni con i glitter sulle unghie, un iPhone le scende sul fianco legato a una corda fucsia. Lui, invece, indossa un piumino nero e lucido con la scritta Philipp Plein stampata in bianco sulla schiena, ha messo troppo profumo e nell’ascensore alcuni turisti asiatici ne sono infastiditi. Siamo nel XVI Arrondissement e il motivo che li ha spinti fino qui – fuori dai giri turistici e lontano dalle vetrine di Dior di Avenue Montaigne – è il nome di un edificio: Louis Vuitton Foundation. Lei è rimasta piuttosto delusa da ciò che vi ha trovato, infatti fa al marito: «Ma sei sicuro che siamo nel posto giusto?»
«Amore, guarda», risponde mostrandole Google Maps.
«Boh, io non capisco, da Yves c’erano tutti i vestiti, qui solo pantoni!»
Quei ‘pantoni’ sono le tele di Mark Rothko esposte alla fondazione in occasione di una retrospettiva sulla vita e sulla produzione dell’artista. L’errore dei due turisti è quello di non essersi resi conto di quello che stavano per visitare. Forse perché il nome Rothko, presente su diversi cartelloni all’ingresso, non ha suggerito loro nulla di familiare. Hanno fatto una lunga coda, hanno pagato un biglietto e sono entrati. La mostra a cui partecipano involontariamente è stata inaugurata lo scorso 18 ottobre e sarà aperta fino al 2 aprile 2024. È la prima su Mark Rothko in Francia dal 1999 e sono presenti centoquindici opere provenienti da collezioni internazionali, tra cui la National Gallery of Art di Washington e la Tate Gallery di Londra, oltre a opere della sua famiglia. L’esposizione offre una visione completa dell’intera carriera di Rothko, partendo dai suoi primi lavori figurativi degli Anni ’30, passando per le influenze surrealiste, fino ad arrivare alle sue famose opere astratte.
Quando le porte dell’ascensore si aprono e la coppia scende all’ultimo piano della Fondazione, la loro delusione arriva al culmine. Si trovano davanti grigi e neri, e così anche quei colori che attiravano, anche se in maniera distratta, l’occhio dei due, svaniscono.
È la sala numero dieci, dove assistiamo all’esplorazione di colori scuri. La serie Black on Gray, creata dall’artista durante la fine degli Anni ‘60, è l’ultima produzione che Mark Rothko realizzò prima del suicidio nel suo atelier di New York nel 1970. Questa serie di dipinti differisce sostanzialmente dalle sue opere precedenti: è composta da grandi quadri formati da massimo due campiture di colore – il nero e il grigio – e sembra influenzata sia dal movimento minimalista, sia dallo stato emotivo dell’artista. La decisione di limitarsi a due colori sembra riflettere una ricerca di essenzialità, un’eliminazione di tutto ciò che è superfluo, per concentrarsi sull’espressione cruda dell’emozione. Le tele sovrastanti e i colori cupi e magnetici sembrano distorcersi, dilatarsi; inglobare chi le osserva nel loro spazio sospeso. Rothko creò opere senza tempo, opere in cui immergerci per contemplare noi stessi e ciò che ci circonda, un atto che non per forza risulta confortante, ma che tende a smuovere, lacerare.
Questi dipinti erano parte di una commissione per l’UNESCO dedicata alla sede parigina. Avrebbero dovuto essere esposti insieme a una scultura di Alberto Giacometti, scultore e pittore svizzero. Mark Rothko non riuscì mai a consegnare le opere a causa dei suoi problemi di depressione e abuso di alcol. Più di cinquant’anni dopo, nelle sale della Fondazione, questo dialogo avviene. Infatti, ad accompagnare la serie Black on Greys ci sono due sculture di Giacometti: L’Homme qui marche e Grande Femme III.
Alberto Giacometti e Mark Rothko non sono gli unici due artisti presenti in questo spazio, il terzo – che in realtà lo ha creato – è Frank Gehry, l’architetto che ha disegnato l’edificio riprendendo in maniera astratta le forme di un veliero. Le vele della Fondazione Louis Vuitton, sotto cui si trova la sala, con la loro forma dinamica e l’uso innovativo del vetro e dell’acciaio, rappresentano una ricerca architettonica che si muove verso nuove possibilità espressive e funzionali. La ricerca di innovazione e di esplorazione dei confini tra spazio interno ed esterno, tra natura e artificio, risuona con le indagini di Giacometti e Rothko, sebbene in ambiti diversi. Le sculture e le tele sembrano lottare per la connessione tra spazio ed essere umano, un tema che nell’architettura di Gehry risuona. L’edificio stesso diventa così una scultura dinamica che interagisce con il suo ambiente. Ed è questa fusione tra architettura, scultura e pittura che evidenzia la continua ricerca dell’arte moderna di esprimere e comprendere l’intimità dell’esperienza umana di fronte all’arte.
I due turisti si fermano a guardare, come incantati dal disgusto. Potrebbero andarsene, riprendere l’ascensore, uscire dalla fondazione e fermare un taxi per farsi riportare in centro, in Avenue Montaigne. Invece restano, rubano tempo importante al loro svago, qualcosa li ha colpiti. Forse un senso di malessere condiviso, una nausea che non si riescono a spiegare in alcun modo.
I quadri a cui passano davanti sbuffando fanno parte dei colour-field painting, termine coniato a metà degli Anni ’50 dal critico americano Clement Greenberg per definire i lavori di artisti quali Rothko, Newman e Still. Contraddistinte per l’enfasi su vaste campiture di colore, sono le opere che segnano l’ultima parte dell’evoluzione artistica di Rothko.
A partire dai quadri Multiforms realizzati tra il 1946 e il 1949, Rothko eliminò completamente la figura umana, nonostante essa rimanga il suo campo d’indagine. L’artista affermò che «nessuno riusciva più a dipingere una figura così com’era e ad avere l’impressione di riuscire a produrre qualcosa che esprimesse il mondo», e, partendo da questa impressione, sviluppò il suo stile astratto classico incentrato su intense distese di colore rettangolari posate su sfondi monocromo. Rothko si allontanò così dal concetto tradizionale di rappresentazione visiva, sostenendo l’idea che l’arte possa comunicare senza dover dipendere da forme riconoscibili. In questo senso, per l’artista, la rimozione dei nessi figurativi sostituisce l’immagine di un’esperienza con l’esperienza stessa. Le opere a grandezza d’uomo, ma assenti di una figura umana, permettono infatti un’esperienzasensoriale pura, che, priva di una mediazione di oggetti riconoscibili, riporta il dialogo con lo spettatore a un linguaggio primitivo.
L’approccio di Rothko alla pittura può essere visto come un tentativo di catturare e comunicare l’essenza emotiva e spirituale attraverso la potenza del colore, che converte la tela in un territorio contemplativo in bilico tra tensione ed estensione, tra presenza e assenza, tra realtà e immaginazione. Sebbene furono le qualità formali delle sue opere a colpire in primo luogo la critica del tempo, risulta chiaro in una conversazione dell’artista con il critico americano Selden Rodman che Mark Rothko non si identificava come un astrattista, e che il fulcro delle sue opere non è riconducibile ai rapporti di colore o di forma. Quello a cui era realmente interessato erano infatti le emozioni umane: «I miei dipinti hanno a che fare con la ‘scala’ dei sentimenti umani, con il dramma umano, per quanto riesca ad esprimerlo». L’artista pensa ai suoi quadri come mezzo di comunicazione e di interscambio tra la tela e l’osservatore. Apparentemente semplici nella composizione, le opere si rivelano complesse e stratificate nella loro capacità di dialogare con lo spettatore, di farlo fluttuare nella profondità dell’esperienza umana.
Quello che rende speciale la visita dei due turisti alla fondazione è il non aver deciso consapevolmente di entrare in contatto con l’arte di Rothko – il loro errore iniziale. Non hanno seguito l’ordine delle sale, hanno buttato l’occhio in giro cercando di orientarsi, e alla fine la loro percezione è quella di aver buttato dei soldi e del tempo. Sono frastornati, e tuttavia, anche se non sanno bene per quale motivo, non riescono a uscire. Continuano la loro visita, fino ad arrivare davanti a una serie di quadri.
La storia di questi quadri inizia nel 1958 quando gli architetti Philip Johnson e Mies van der Rohe commissionarono a Rothko alcuni dipinti da appendere nel ristorante del Four Season a New York. L’artista creò una serie di grandi opere, caratterizzate da toni scuri e saturi, che sperava avrebbero creato un’atmosfera oppressiva, quasi soffocante, per i commensali. Rothko immaginò i suoi dipinti come qualcosa che avrebbe disturbato e messo in discussione l’ambiente privilegiato del ristorante. Tuttavia, dopo aver cenato anonimamente al Four Seasons, decise che il suo lavoro non avrebbe mai potuto realizzare l’intento desiderato in quel contesto. Sentì che i suoi dipinti sarebbero stati ridotti a semplici decorazioni in un ambiente così elitario. Di conseguenza ritirò la sua commissione nel 1959, prima che i dipinti fossero installati, e restituì il denaro avanzato.
Questo aneddoto spinge a una riflessione più ampia sull’intento di Mark Rothko: la sua arte prendeva vita solo in relazione all’osservatore. Il fulcro della produzione artistica di Mark Rothko risiede nel suo aspetto comunicativo, intimo, sociale. L’artista è sempre stato restio a fornire un’interpretazione alle sue tele, voleva che fossero esperienze percettive ed emozionali, difficili da spiegare a parole, ma elementari nel trasportarti nel suo mondo contemplativo. «I sensi umani raccolgono e accumulano, le emozioni e la mente convertono e ordinano e, attraverso il mezzo artistico, vengono espulse per partecipare di nuovo al flusso della vita dove, a loro volta, saranno uno stimolo all’azione di altri uomini».
Dopo tre minuti, forse anche meno, l’uomo prende in mano il cellulare e comincia a scattare delle foto, la donna lo guarda sorpresa con un’espressione del tipo: non capisco cosa ci sia da fotografare. Poi lui infila in tasca il cellulare e si ferma davanti a una tela. Ha un fondo violaceo, scuro, e in mezzo c’è un rettangolo più chiaro. Si avvicina. I colori sembrano muoversi e svelare altri strati di tonalità diverse. Il rettangolo bianco è come se pulsasse, un cuore che cerca di uscire dalle costole. Lui comincia a sentirsi male, gli manca il fiato, vorrebbe piangere. È disgustato, sente lo stomaco rivoltarsi dentro la pancia, ma non riesce a smettere di osservare il dipinto. Quando non ne può più, si volta ed esce dalla sala correndo, cerca un bagno. Entra sbattendo la porta e si lancia nel primo libero. China la testa e si inginocchia. La donna che lo ha seguito lo trova accasciato con la sua scritta Philipp Plein ben in vista sotto allo sciacquone. Così l’ultima cosa che i due turisti vedono della Fondazione Luis Vuitton è il fondo di un gabinetto.
La brutta esperienza capitata al turista era quella che Mark Rothko aveva dedicato a un ipotetico ricco avvocato newyorkese il quale, preso dalla stanchezza, sul finire di una mattinata di lavoro, o dopo aver difeso un cliente in tribunale, decide di pranzare al ristorante del Fuor Season.
Dopo più di cinquant’anni, quello che ci resta di questo artista è il potere della sua opera: un incantesimo nascosto tra le migliaia di strati di colore che compongono i suoi quadri. Qualcosa che non è percepibile né attraverso una foto, né con una semplice occhiata. Per comprenderlo e viverlo bisogna avere il coraggio o l’incoscienza di andarci vicino. A poche dita. Fino a quando il quadro riempie tutto il nostro campo visivo. Solo così è possibile conoscere l’arte di Mark Rothko. ♦︎
Di Umberto Ferrero e Viorica Pellini