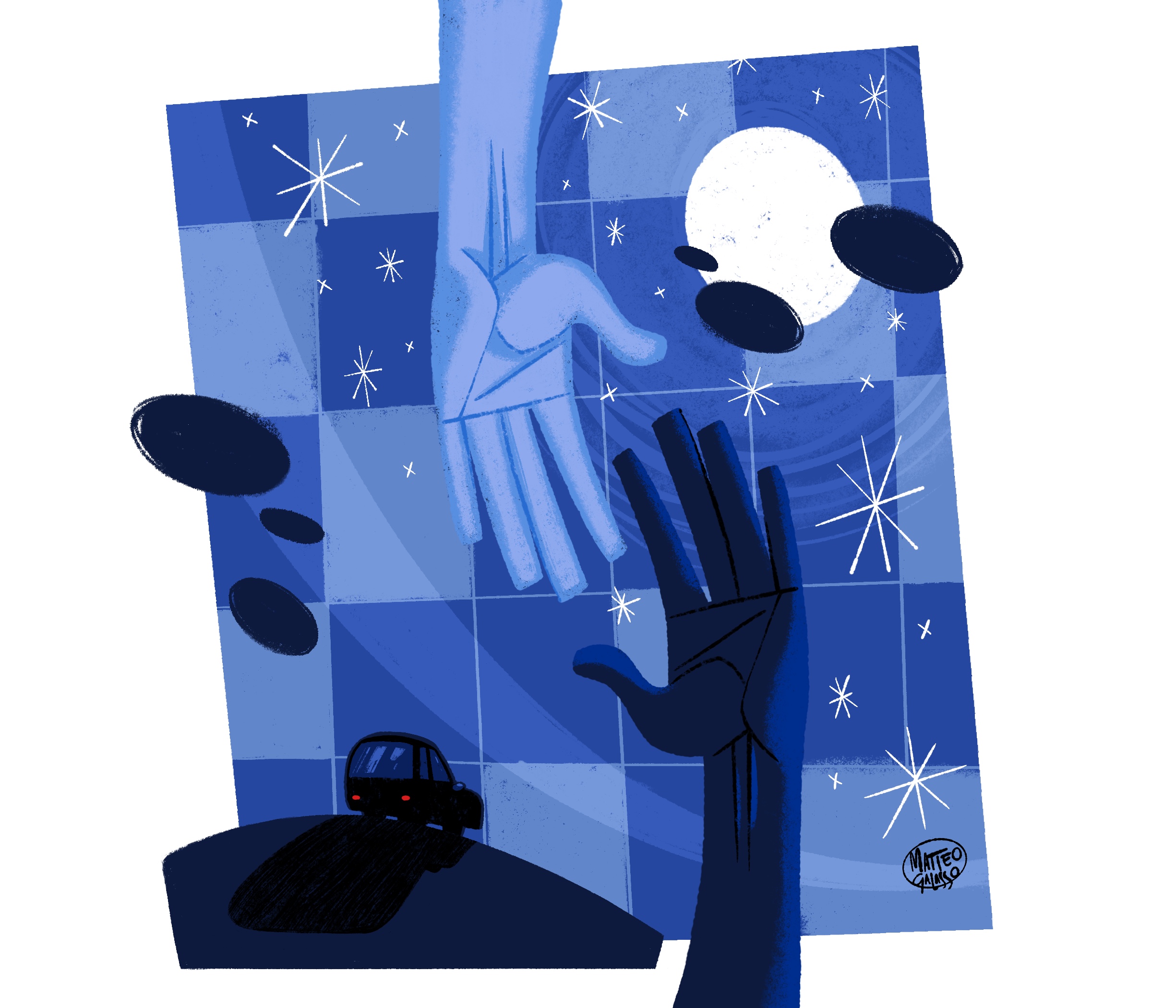L’eterogeneità dell’essere umano è minacciata dal fenomeno globalizzazione: saremo tutti uguali.
Eccoci di nuovo qui, al nostro appuntamento mensile, come di consueto pronti per accomodarci al nostro tavolino prenotato a nome «Realtà». Oggi affronteremo un argomento leggermente diverso, un fenomeno particolare legato a ciò che noi uomini moderni stiamo diventando, ma comunque distante dai temi che siamo soliti approfondire.
Non so se avete mai fatto caso a quanto usi, costumi e tradizioni delle diverse macro-regioni, delle tante culture che popolano il pianeta, stiano man mano scomparendo. Un po’ come quando, sui libri di scuola, ci veniva insegnato che una società cessa di esistere per corruzione dei costumi.
Il problema è che oggi non è solo una società a essere corrotta, aggredita e cancellata per essere sostituita da un’altra: lo sono tutte.
Divario generazionale: la religione ieri e la religione oggi
Fermiamoci per un secondo e guardiamoci intorno, basta osservare ciò che sta succedendo a noi occidentali. Il divario culturale e soprattutto tecnologico ormai divide generazioni anche abbastanza ‘vicine’; pensiamo per esempio alla religione, che fino a pochi anni fa era una sorta di dogma: tutti i bambini, volenti o nolenti, venivano cresciuti attraverso i suoi rituali e le sue festività tradizionali. Oggi essa rappresenta invece una parte decisamente marginale della vita dei ragazzi e degli adulti, quasi come se, negli ultimi anni, si fosse verificato una sorta di distacco fra ciò che la religione ha rappresentato nel passato e ciò che invece rappresenta, oggi, per le nuove generazioni. Qualcuno può pensare che tutto ciò faccia parte di quello che chiamiamo progresso; anche se preferisco chiamarlo sviluppo: il progresso, come diceva Pasolini, è un’altra cosa.
Credo che piano piano il mondo con i suoi abitanti stia diventando sempre più piccolo, sempre più legato e quindi sempre più simile. L’umanità ha intrapreso senza accorgersene un processo di uniformazione sociale e culturale, in cui in ogni angolo del pianeta si mangia e si pensa e ci si veste nello stesso, identico modo. Questo fenomeno si chiama globalizzazione. E, come tutti i processi umani, è una medaglia: ha due facce.
La prima sicuramente positiva, l’altra un po’ meno.
Tutti uguali: la faccia negativa della medaglia

Ve lo immaginate un mondo tutto uguale? In cui tutti la pensano allo stesso modo, si vestono allo stesso modo, mangiano le stesse cose e si comportano come gli altri? Un mondo in cui tutti vivono senza mai assaporare la scoperta di culture differenti dalla nostra, con diversi modi di pensare e soprattutto di vedere la vita.
Un mondo chiuso, proiettato nella frenesia tipica della società occidentale moderna. Dove viaggiare equivarrà soltanto a vedere posti diversi, perché comunque non appena ti girerai troverai una pizzeria o un fast food legato a una delle tante catene multinazionali. Un mondo che in qualunque suo angolo considererà le persone per ciò che possono offrire al mercato, ignorando ciò che invece le rende esseri umani pensanti. Dove il pensiero unico si trasforma in una dittatura della libertà, in cui ognuno di noi è portato a pensare in un’unica direzione; direzione che, quando non viene intrapresa, porta alla stigmatizzazione e all’isolamento sociale.
Ne è un esempio la continua necessità di appartenere a una categoria, a un gruppo ben preciso e delimitato che sia esso un partito politico o un agglomerato di persone uniformate. E attenzione, questa non è una prerogativa delle nuove generazioni: siamo tutti così, l’età non conta assolutamente niente. Questo ovviamente accade in maniera e modalità diverse in giro per il mondo, ma il succo è sempre lo stesso.
È lampante che almeno nel mondo occidentale tutto ciò è mera realtà: in America è così, in Europa è così, anche in Asia è così.
Il fenomeno visto più da vicino
Questo fenomeno si rispecchia perfettamente in quello che Joseph Nye, politologo statunitense, chiama soft power: il potere leggero, in cui un paese riesce ad assoggettare gli altri senza l’utilizzo della forza. In pratica succede che le regioni economicamente più potenti, quelle che tengono in mano le redini del commercio e della finanza internazionale, tendono a imporre la propria egemonia su quei paesi più deboli. Veniamo quindi plasmati, modellati, in modo da poterci rispecchiare tutti in abitudini, preferenze e gusti comuni.
D’altronde anche le stesse lingue parlate, con particolare riferimento a quelle minoritarie, stanno pian piano scomparendo. L’ UNESCO, con uno studio del 2012, ha dichiarato che circa tremila delle seimila lingue parlate in tutto il mondo stanno scomparendo. Tra queste figurano trenta lingue parlate anche qui da noi tra cui il siciliano, il sardo e il napoletano. Tutto questo fa un po’ di paura se pensiamo che le lingue siamo noi, la nostra cultura, la nostra etnia: le nostre origini. La loro scomparsa rappresenterebbe una perdita incommensurabile per l’umanità.
È veramente questo ciò vogliamo?
Credo di no. E sinceramente spero che anche voi lettori, come me seduti al nostro tavolino riservato, la vediate allo stesso modo. E non per il gusto di avere ragione, della ragione non me ne frega niente, ma perché significherebbe che c’è ancora qualcuno che crede nella bellezza della diversità. Ovvero qualcuno che ancora si ostina a non condividere la rotta che la società in cui viviamo ha deciso di intraprendere, trascinandoci controvoglia e a tutta velocità verso il tramonto del mondo che conosciamo.