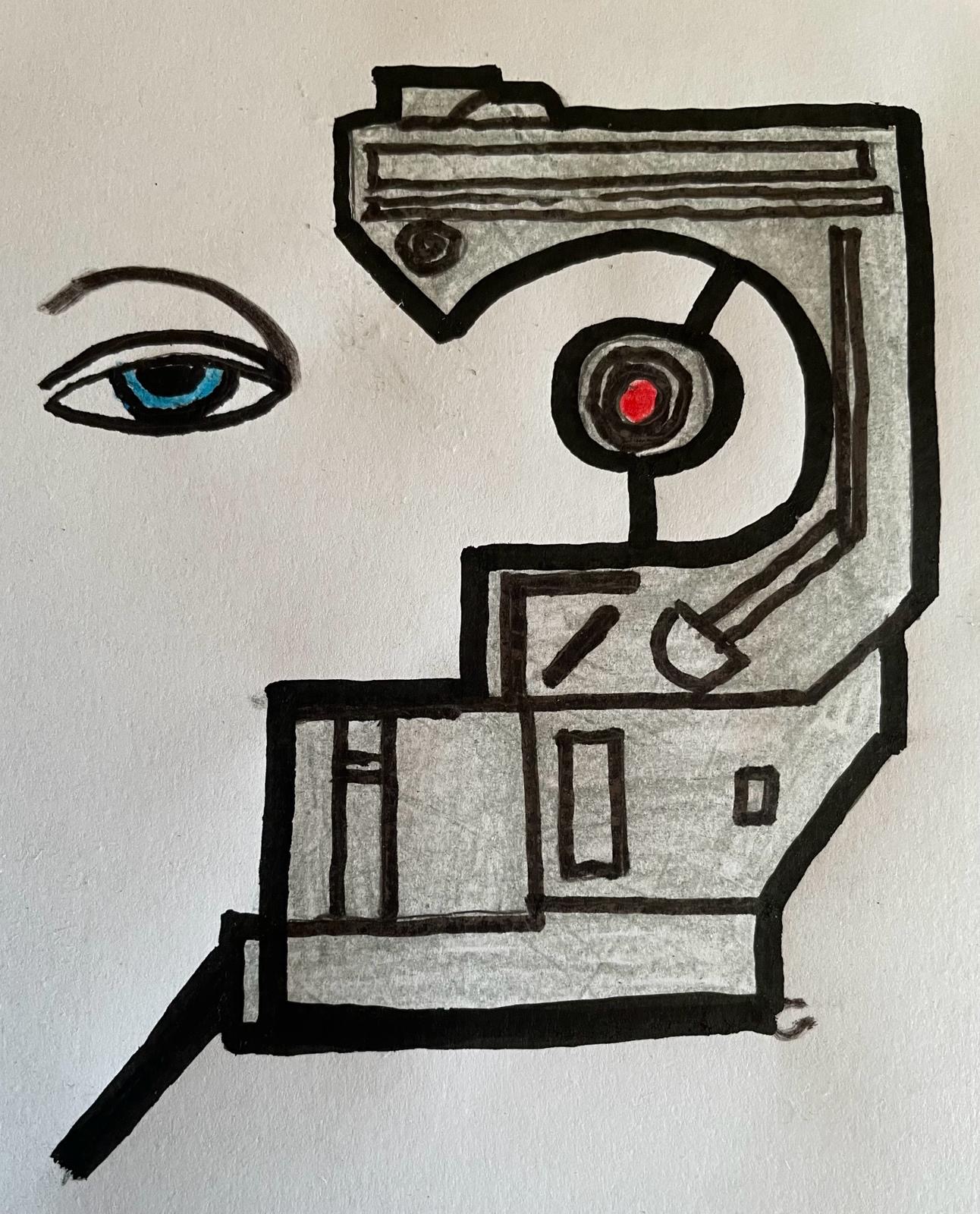La zona d’interesse di Jonathan Glazer, vincitore del Gran Prix speciale della giuria al Festival di Cannes, candidato ai prossimi Premi Oscar in cinque categorie (si contende la statuetta con Io Capitano nella categoria miglior film internazionale) è un film grazie al quale si torna a parlare di Shoah al cinema facendolo in un modo tutto particolare e riuscendoci appieno grazie a una narrazione posata (amplificando l’assurdità di certi dialoghi) e un sonoro che esalta ciò che vediamo e, soprattutto, ciò che non possiamo vedere.
Rudolf Höß la moglie Hedwig e i loro cinque figli vivono nell’area di interesse del Campo di concentramento di Auschwitz di cui Höß è il comandante. Tutta la famiglia, pur sapendo chiaramente cosa stia accadendo oltre il muro che divide i due luoghi, vive la propria vita in una molle e placida quotidianità.

La zona d’interesse è un film tutt’altro che immediato da assimilare: per quanto si possa essere ormai ‘abituati’ a film che raccontino della Shoah nelle più disparate vesti, il film di Glazer si comporta come un unicum elidendo pressoché completamente sia l’orrore di Auschwitz sia i discorsi relativi allo sterminio degli ebrei a livello visivo ma mantenendone le tracce a livello sonoro anche se ovattate dai vari dialoghi e dai suoni della natura che circonda il campo e l’Interessengebiet (l’area di interesse di 25 miglia attorno al campo polacco) abitata dalla famiglia Höß.
Il film di Glazer, infatti, più che mostrare gli orrori della Shoah, spiattella davanti agli occhi dello spettatore la tranquilla vita quotidiana della famiglia del direttore del campo di Auschwitz: le scampagnate al fiume, le uscite a cavallo, le cene in famiglia. Se non fosse per il fatto di avere a che fare con la famiglia di un criminale di guerra (che verrà impiccato in Polonia nel 1946) e nel non poter fare a meno di notare l’incombente presenza delle strutture del campo di concentramento oltre l’imponente muro di cinta ogni qual volta lo conceda la macchina da presa, si potrebbe quasi avere l’idea di assistere a un dramma familiare con protagonista una famiglia fedele seguace del nazismo.
Per seguire al meglio la famiglia Höß all’interno della residenza (ricostruita fedelmente per questa occasione dallo scenografo Chris Oddy) Glazer e Lukas Zal, il direttore della fotografia, si sono serviti di telecamere operate da remoto e con il solo utilizzo della luce naturale: l’immersione nella quotidianità di questi personaggi ha potuto così essere la più realistica possibile, quasi a livello di un documentario.
Strappare il documentario ne La zona d’interesse
Per evitare che il racconto si cristallizzi troppo in una forma vicina al taglio documentaristico, Glazer opera precise scelte estetiche che intrecciandosi in sparuti punti lungo la narrazione, già a partire dall’inizio del film, la segmentano con precisione creando piccoli ma efficaci ‘shock’ per tenere alta l’attenzione dello spettatore che potrebbe facilmente rischiare di perdersi nella assurda e straniante quiete di quest’opera. La zona d’interesse comincia, infatti, già con un piccolo ‘inganno’: lo schermo completamente nero pullula di piccoli suoni, fagocita l’attenzione, carica le aspettative dello spettatore per un tempo breve e allo stesso tempo interminabile, uno spettatore che si aspetta non si sa bene cosa ma, molto probabilmente, nulla di positivo visto il periodo storico del film e invece, quando ormai gli occhi si sono abituati al buio pressoché totale e si è già pronti ad assistere all’inenarrabile, ecco esplodere il verde luminoso della campagna polacca con il cinguettare degli uccelli e il gorgogliare placido dell’acqua di un fiume. Un ambiente tutt’altro che orrorifico.
La storia, da quel primo momento e per molto tempo ancora, prende quel percorso fra il dramma familiare e il documentario che viene bruscamente interrotto poche altre volte e sempre per fermare la narrazione in maniera violentissima ‘disincantando’ lo spettatore e riportandolo a una realtà dei fatti la cui tragicità è eufemisticamente enorme. La ‘scena’ in cui lo schermo piano, piano diventa completamente di un rosso acceso a metà della narrazione con un rumore che si fa sempre più assordante, si stacca totalmente a livello narrativo da ciò che avviene ma richiama chiaramente il sangue delle vite spezzate e il fuoco dei forni crematori: dura pochissimo e poi la narrazione riprende a svolgersi pacatamente.
Di forte impatto è anche l’aver mostrato in un flashforward, ormai alla fine del film, alcuni interni di Auschwitz nel suo essere ora un memoriale e un museo, poco prima di una probabile apertura giornaliera, mentre il personale ne prepara le sale: il silenzio è pressoché totale, come lo è quello in cui si trova immerso Höß quando, a flashforward concluso, viene preso da piccoli conati di vomito, probabilmente dovuti alla vertigine per la presa di coscienza che quello che lo spettatore ha visto per pochi minuti poco prima, è effettivamente realizzabile su larga scala.
La banalità del male rielaborato per la ‘Settima arte’
Christian Friedel nel ruolo di Rudolf Höß è una sempre più convincente Sandra Hüller nel ruolo della moglie Hedwig riportano in vita, con un affiatamento esemplare (anche con il grande aiuto dei ‘trucchi’ scenici di cui sopra) la vita quotidiana dei due personaggi principali; le gite fuori porta, le cene in famiglia, le storie della buonanotte, l’affannosa cura del grande giardino della villa e i numerosi discorsi così assurdamente banali da risultare quasi surreali, visto il luogo in cui si svolge l’azione, stridono terribilmente con ciò che sta accadendo a pochi metri da loro. il tempo passa senza che ce ne si possa effettivamente accorgere perché ciò che vediamo e ascoltiamo è così assurdo, così ‘naturalmente’ scollato da non fare effettivamente capire lo scorrere del tempo tanto lo spettatore è concentrato nel riuscire a mediare fra il poco che succede e il ‘tanto’ che si sente. Risultano perciò parossisticamente surreali quei pochi momenti descritti nel paragrafo precedente; particolarmente ‘ostici’ quelli in ‘negativo’ (fotografico) a corollario della storiai di Hansel e Gretel perché distraggono eccessivamente da una storia che, per più lungo tempo, sembra voler mostrare null’altro che la vita di una famiglia alla prese con gli alti e i bassi della quotidianità fra la casa, la scuola, il lavoro.
La zona d’interesse è La banalità del male del cinema che prova, riuscendoci quasi totalmente, a gettare uno sguardo nuovo sulla Shoah e su coloro che l’hanno permessa; una novità fatta non tanto di immagini ma, soprattutto, di parole, di toni e di suoni. ♦︎