Jon Fosse è un mistico con lo sguardo di Hannibal Lecter, un uomo che si definiva ateo e pagano, ma si converte al cattolicesimo, uno spettatore che detestava il teatro, ma diventa drammaturgo, un romanziere norvegese semisconosciuto che usa una lingua minoritaria, ma nel 2023 vince il Nobel per la letteratura perché nei silenzi della sua scrittura c’è un indicibile che è universale.
In Italia la sua produzione teatrale e letteraria non era molto conosciuta prima che gli venisse conferito il premio. Non era un nome noto neanche ai lettori forti e tuttora, sia per l’editoria che per il teatro, rimane un fenomeno di nicchia.
Nella sua inquietudine giovanile, che lo spinge a bere e fumare senza controllo e ad assumere atteggiamenti radicali e anarcoidi nel quadro della controcultura di quegli anni, passa dalle corde della chitarra alla tastiera della macchina da scrivere, portandosi dietro o dentro la musicalità delle voci e il ritmo dei sospesi. Compie studi letterari a Bergen, approfondendo argomenti di estetica e di teoria del romanzo. Presto esordisce in narrativa con Rosso, nero (1983), nel titolo un chiaro riferimento a Stendhal, e più tardi si impone alla critica, affermandosi a livello internazionale con La rimessa (1989), in cui l’originale trattamento dell’Io narrante ricorda Kafka.
Con la svolta religiosa di Fosse, la sua scrittura sperimentale, postmoderna, dallo stile inusuale e rarefatto, assume una qualità mistica. Melancholia (1995-96) è probabilmente il capolavoro narrativo di questa fase e coincide, peraltro, col debutto drammaturgico.
Per chi volesse leggere opere più recenti, segnalo che sono da poco usciti per la Nave di Teseo i primi due volumi di Settologia. Ma non aspettatevi letture da ombrellone: i romanzi di Jon Fosse sono cronaca di condizioni esistenziali più che racconto, muri di testo costituiti da frasi spezzate, flussi di coscienza che impongono un esercizio di attenzione e selezionano con ferocia i lettori. La sua prosa è chiaramente debitrice a Joyce e ha punti di contatto con quella ripetitiva, cupa e fortemente ritmica di Thomas Bernhard, del quale aveva tradotto un dramma.
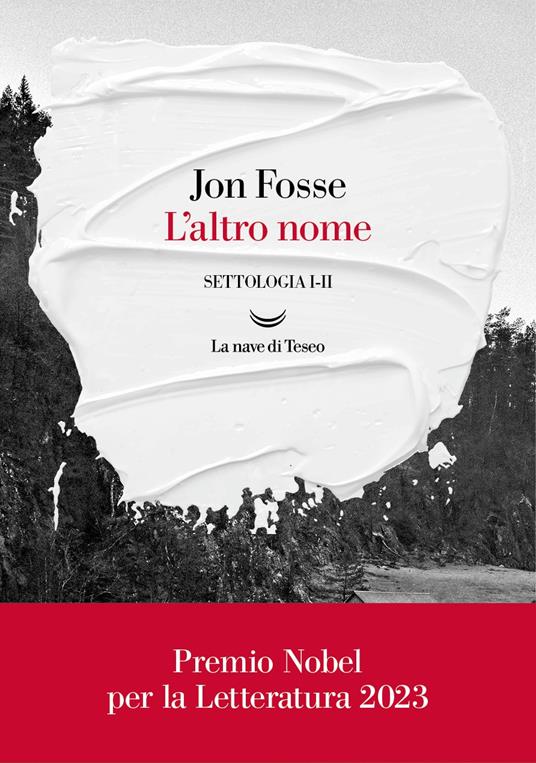
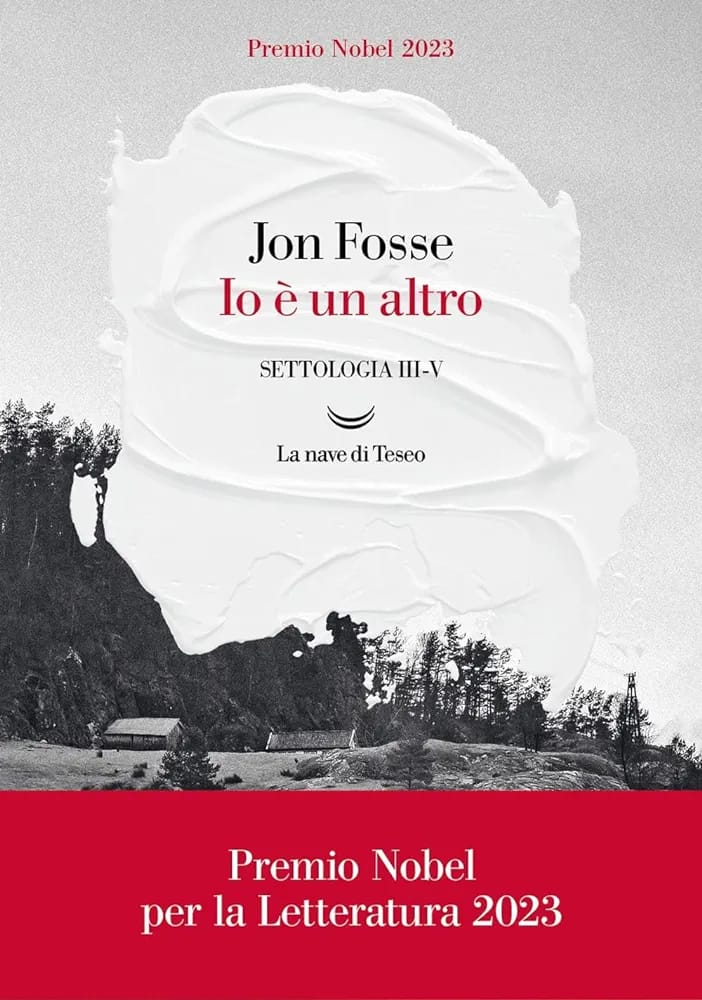
Nell’ambiente d’origine di Jon Fosse e nell’idioma neonorvegese nel quale si esprime, la scrittura drammaturgica era poco praticata. Per sua ammissione, non avrebbe mai accettato di scrivere un testo teatrale, senonché, per coincidenza, gli fu chiesto in un momento in cui aveva «maledettamente bisogno di soldi». E subito scoprì nel teatro «la più umana e […] la più intensa di tutte le forme artistiche», riscontrandovi riflessi delle espressioni creative cui si era dedicato: la musica, la pittura e la scrittura. La narrativa di Fosse è presupposto alla sua drammaturgia. L’autore descrive sintomi e non fa diagnosi. I suoi testi si sganciano dai temi centrali della nostra epoca e dalla critica sociale, nella convinzione che la letteratura debba perdere i caratteri di militanza, perché è prima di tutto struttura estetica. Si occupa di drammi minimi, di sentimenti sbriciolati su uno sfondo piatto e grigio di piccole libidini, di cucine economiche. Le sue, sovente, sono storie di famiglia che girano quasi attorno all’assenza di una storia. Non è un teatro di eroi, ma di persone qualunque, che sovente non hanno neanche un nome, come l’Everyman dei Misteri medioevali. Perché ciascuno è chiunque, ciascuno è tutti noi. E quindi gli spettatori non vanno a vedere personaggi, ma altre persone, se stessi, la vita e la non vita di ciascuno, ciò che non abbiamo realizzato, ciò che non abbiamo conquistato, ciò che abbiamo perduto. Le atmosfere sono rarefatte, cariche di una suspence senza alcun tipo di accadimento esplicito. Jon Fosse pare mettere al centro un’immagine per poi chiedere agli spettatori di guardarne solo il riflesso o l’ombra. Ne risulta un teatro minimalista, scarno, che gioca sui vuoti.
Secondo alcuni l’autore è un nuovo Ibsen, per altri è il Beckett del XXI secolo, ma nella biblioteca interiore di Jon Fosse drammaturgo incontriamo anche Čechov, Handke, Pinter e Kane. I suoi lavori teatrali sono stati apprezzati soprattutto in Germania e in Francia, mentre l’Inghilterra li ha accolti con una certa cautela critica, in quanto ritenuto troppo sovrapponibile a Pinter e a Beckett. Ma un mistico non può essere considerato autore dell’assurdo. E Fosse ha affermato di aver riscoperto il divino proprio attraverso la scrittura, che per lui diventa una sorta di religione. Anche quando scrive le sue pièces, lo fa con la speranza che, come si dice in Ungheria, «un angelo attraversi la scena», cioè che si verifichi uno di quei momenti in cui tra spettatori e attori si crea una connessione non intellettuale, ma emozionale e inspiegabile, un istante in cui estetica ed etica diventano una cosa sola. È questo ciò che distingue il buon teatro da quello cattivo. «E se una volta sola hai visto buon teatro, ti riscatta da tutto il cattivo in cui ti imbatterai», dice Fosse nei Saggi gnostici, la raccolta di scritti critici tradotta dal professor Franco Perrelli, specialista di teatro scandinavo, e pubblicata in Italia da Cue Press nel 2018. Rendere il neonorvegese dell’autore nella nostra lingua è un’operazione complessa. Il nynorsk è un’ispida rielaborazione di dialetti rurali, usata sì e no dal 10-15% dei norvegesi. Perrelli, pur conoscendo la lingua maggioritaria (bokmål), ha dovuto ricorrere all’aiuto di amici madrelingua, i quali a loro volta si sono fatti aiutare da conoscenti che vivessero in zone dove è diffuso l’idioma minoritario.

Già sette anni fa, in occasione di un incontro al Teatro Gobetti di Torino, nel quale Perrelli dialogava con il regista Valerio Binasco e con gli attori che portavano in scena Sogno d’autunno di Jon Fosse, il professore vaticinò la possibilità di un futuro Nobel. In fondo, il mistico Fosse era già nelle liste dei bookmakers da tempo.
Quel Sogno d’autunno del 2017 era il primo lavoro teatrale dell’autore norvegese a essere inserito nel cartellone dello Stabile di Torino, ma non era certamente il primo incontro tra Fosse drammaturgo e Binasco regista, attratto da un portato di pietà e tenerezza che legge in tutti i suoi testi. In precedenza aveva già curato la regia di Qualcuno arriverà, E la notte canta, Un giorno d’estate e Sonno. Oggi è riconosciuto come il suo principale interprete italiano.
La ragazza sul divano diretto da Binasco
Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile di Torino dal 2018, aveva deciso di portare in scena La ragazza sul divano già prima che a Jon Fosse venisse assegnato il Nobel. Lo spettacolo, in prima nazionale al Teatro Carignano fino a domenica 24 marzo e poi in tournée in tutta Italia fino a maggio, nasce in coproduzione col Teatro Biondo di Palermo, di cui è direttrice artistica Pamela Villoresi, che, sul palco, recita accanto a Binasco.
Il testo, scritto nel 2002 per il Festival di Edimburgo, è uno dei più acclamati e rappresentati dell’autore ed è uscito da poco nella collana teatrale di Einaudi, tradotto da Graziella Perin.

Sulla scena, in un unico ambiente che riunisce un salotto, una cucina e un atelier, ma altro non è che la sua memoria, una pittrice di mezza età rivive tutte le ferite psicologiche subite nell’adolescenza, quelle che secondo lei le hanno impedito di diventare «brava a vivere». La donna sta cercando di dipingere se stessa ragazza seduta su un divano, ma, insoddisfatta delle proprie capacità artistiche, sfoga l’ansia, la frustrazione e la rabbia sbraitando da sola, mentre i piani temporali della vita si accavallano e tanto la pittrice quanto la modella, cioè le due diverse età della stessa persona, coesistono sul palcoscenico. Una parete, per un gioco di luci e trasparenze, ora è il quadro che la donna sta dipingendo, e dal quale nel suo delirio vede uscire i colori per aggredirla, ora svanisce in un velo che apre la visuale su un’altra stanza. Il giradischi in scena diventa motivo per affiancare a tratti un discorso musicale parallelo al testo con un brano di Lesley Gore e, sul finale, uno di Lou Reed.

Entrano ed escono personaggi di un presente e di un passato che non dialogano tra loro, ma le battute si richiamano per echi, in ricorrenti ripetizioni ossessive. Stanchezza, distanza, frasi fatte o mai portate a termine si trascinano tra la protagonista, che l’autore chiama solo DONNA (Pamela Villoresi), e l’UOMO (Valerio Binasco), con il quale ha vissuto fino a quando il loro rapporto è sbiadito del tutto. Non c’è comprensione, né perdono, ma solo conflitti e ferite tra una figlia e una MADRE (Isabella Ferrari) che la donna rivede imperfetta, sfuggente, sola con la sua colpa, mentre le due figlie la interrogano e si interrogano in una condizione purgatoriale di eterna attesa d’un PADRE marinaio (Fabrizio Contri, per la terza volta diretto da Binasco in un testo di Fosse), un Ulisse che sembra non debba tornare mai. Lo ZIO (Michele Di Mauro), è un povero innamorato sbagliato, che in assenza del fratello, entra nelle vite disabitate di queste tre donne e lo sostituisce in una dinamica che, pur senza strategia né crudeltà, richiama quella amletica tra Claudio e Gertrude. Assistiamo al confronto doloroso della RAGAZZA (Giordana Faggiano) con una SORELLA maggiore (Giulia Chiaramonte) molto più disinvolta e disinibita, che lei forse invidia e non sa emulare, mentre le cresce dentro la rabbia trattenuta di chi avrebbe voglia di urlare «ci sono anche io» e non lo fa mai. Tutti si relazionano con difficoltà e uniscono le loro solitudini, condividendo uno senso di abbandono.
In un testo che dall’inizio alla fine non ha un solo segno di interpunzione – neanche i punti interrogativi – i dialoghi sono slabbrati come la vita di tutti i giorni, ma significano più di quello che viene detto. Alla rarefazione della parola corrisponde una crescente densità di emozione. Il linguaggio è trasparente e la recitazione degli attori fa sì che dietro vi si legga per intero il pensiero reale di cui è espressione, anche quando i personaggi arrivano a metà frase e la metà successiva la inghiottono, o perché le parole sarebbero insufficienti o perché manca loro la forza di verbalizzare. E allora per un’umanità che non è più in grado di comunicare in modo diretto, il silenzio diventa l’unico modo per esprimersi. L’uso delle pause riconduce a Wittgenstein, che sosteneva si debbano considerare parola anche i sospesi. E, forse, perché gli angeli passino sulla scena, bisogna lasciare loro degli spazi vuoti.

Come accostarsi a una drammaturgia così silenziosa? Un copione fatto di tanti pensieri in poche battute, sovente senza una consequenzialità logica, non aiuta la memoria degli attori, che non possono nemmeno affidarsi alle maschere trasparenti dei personaggi, ma, sotto la guida di Binasco, compensano questa rarefazione cercando punti di contatto tra il proprio vissuto e quel che portano sul palcoscenico.
Il regista nel suo adattamento rimuove parti del copione e riduce il numero dei personaggi. Nel rapportarsi a un testo che richiederebbe un’algida severità, una sorta di rarefazione nordica, si richiama all’immaginario del pittore danese Vilhelm Hammershøi quando ritrae donne di spalle in stanze vuote e silenziose, si domanda come parlerebbero i personaggi ritratti nei quadri di Edward Hopper e propone agli attori di vedere film di Ingmar Bergman e di Aki Kaurismäki perché prendano familiarità con lunghe pause, movimenti minimi e non abbiano più paura di certe staticità dilatate in scena.

Poi però non rispetta del tutto le ambientazioni indicate da Jon Fosse, rielabora le proprie suggestioni in una rivisitazione del testo, scaldandolo con un approccio che lui stesso definisce come una «via mediterranea», ma lo fa con misura, chiedendo agli attori di lasciar trasparire una sottile urgenza passionale senza indulgere in un ‘temperamento annamagnanesco’. «Io ci provo tutte le volte a trovare il Bergman che è nascosto in me, ma non c’è. Busso e il camerino è vuoto», dice Binasco, «e Bergman tutte le volte mi perdona». ♦︎
Le prossime date dello spettacolo saranno:
Parma, Teatro Due – Spazio Grande dal 27 al 28 marzo
Novi Ligure (AL), Teatro Marenco 3 aprile
Cuneo, Teatro Toselli 5 aprile
Milano, Teatro Strehler dal 9 al 14 aprile
Roma, Teatro Vascello dal 16 al 21 aprile
Palermo, Teatro Biondo dal 26 aprile al 5 maggio
Napoli, Teatro Mercadante dal 7 al 12 maggio
Fatta eccezione per le copertine dei libri, tutte le foto presenti nel testo, inclusa l’immagina in evidenza, sono di Virginia Mingolla






