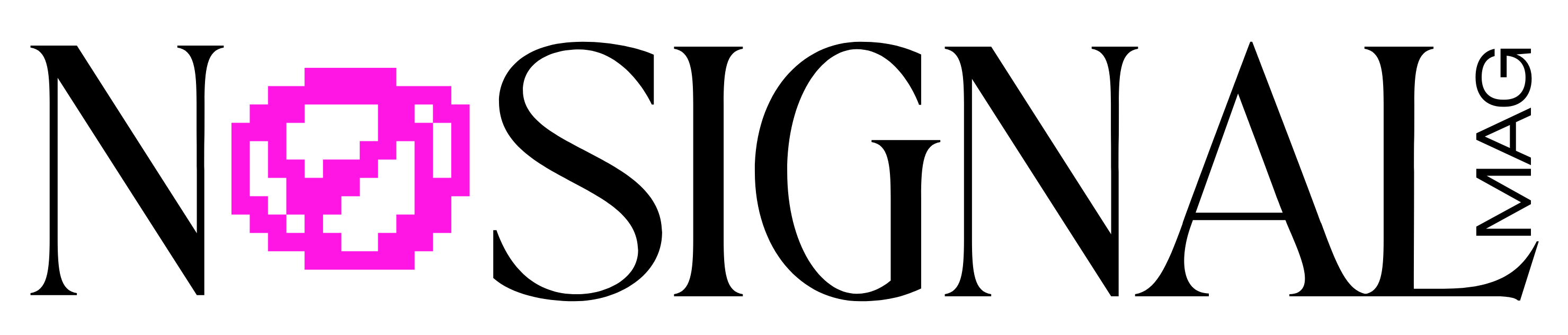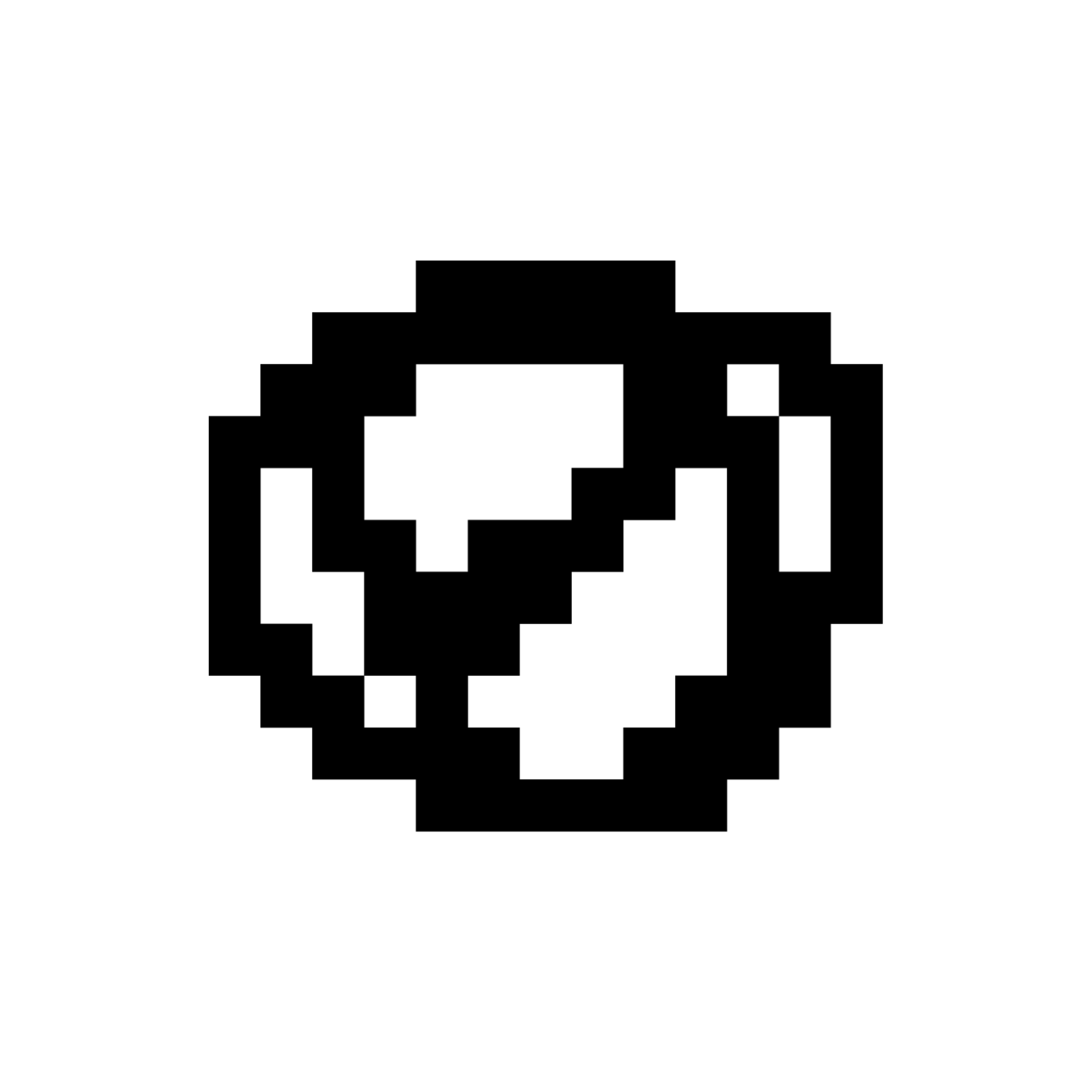Giulia D’Anca non è una nuova conoscenza delle nostre pagine: l’abbiamo già incontrata in passato per parlare della sua seconda raccolta poetica, approfondendo il suo percorso creativo e la sua visione della scrittura. Puoi leggere la nostra intervista precedente per saperne di più. Oggi, la ritroviamo in occasione della pubblicazione della sua nuova silloge Camminamento (Carabba, 2025) che esplora il movimento come metafora della vita, mescolando memoria, identità e cambiamento.
Il titolo della tua nuova silloge, Camminamento, fa pensare a un viaggio interiore. Cosa rappresenta per te il cammino nella tua vita e nella scrittura?
Il cammino è un’immagine potente che rimanda all’idea di un percorso continuo, sia esteriore che interiore. Per me, la vita stessa è un camminamento: un andare che non è mai lineare, ma fatto di fermate, deviazioni e scoperte. La scrittura è il mio modo di tracciare questo cammino, di segnare il passo, di riflettere su ciò che vedo e sento lungo il percorso. Ogni parola che scrivo è come un passo che mi avvicina a una comprensione più profonda di me stessa e del mondo che mi circonda.
A proposito, oltre a essere poetessa sei anche insegnante. In che modo la tua poesia arricchisce il tuo modo di insegnare?
Attraverso la poesia possiamo attivare delle dinamiche inclusive che appartengono a tutte le forme d’arte e alla loro capacità di veicolare i contenuti e le identità più disparate. Insegnare è un processo che apre sempre all’ascolto attivo, in questo senso trovo dei parallelismi con la funzione della poesia oggi. La poesia è uno strumento d’indagine collettiva sia per chi la crea che per chi ne fruisce; ci insegna a dialogare con gli altri, a stare al mondo e a relazionarci con una società che ci vuole sempre più connessi, ma in fondo sempre più distanti.
La terra in cui sei nata è spesso frequentemente nei tuoi versi. Cos’è per te Catania?
Catania è la mia città di origine. Città radice e città magnete che ha – volente o nolente – forgiato la mia personalità e fornito le basi per la mia crescita. Questo luogo non è mai espressamente citato, ma fa da sfondo spesso, con i suoi richiami paesaggistici, a molte delle mie liriche. Nonostante i costanti richiami, ho sempre avuto il bisogno di affacciarmi oltre i confini geografici della mia città per poter attingere anche da realtà culturali molto diverse e molto distanti.
Nella poesia Il mio stesso posto scrivi: «la mia casa era dentro». Qual è la tua casa interiore e come possiamo, oggi, custodire e nutrire questo spazio?
La casa interiore equivale alla tendenza all’auto consapevolezza; il dialogo autodiretto si pone come terreno di cura e risoluzione. E questo dialogo ha sempre un costo che è quello della trasformazione. In una società che ci spinge sempre verso l’esterno, il nutrimento arriva dall’analiticità con la quale ci approcciamo a noi stessi, e per riflesso, anche alle persone intorno a noi. La casa interiore va protetta attraverso la riflessione, la ricerca d’identità, l’elaborazione, il pensiero e la memoria.
In Sono foglia paragoni la tua esistenza a una foglia sospesa tra cielo, terra e acqua. Come vedi la precarietà della vita? La poesia per te è un modo per accoglierla o per sfidarla?
Valgono entrambe le opzioni che hai enunciato. Per certi aspetti la poesia accoglie le criticità e precarietà a cui siamo esposti nella vita e lo fa accettando le contraddizioni e le tensioni del mondo. Per altri aspetti però, attraverso la parola, rende il “precario” “sopprimibile” e stabilizza la dimensione temporale attraverso la creazione.
La foglia sospesa tra cielo, terra e acqua diventa un’immagine che abbraccia sia la fragilità che la bellezza dell’esistenza.
In Prima o poi qualcosa cambierà dici che se il mondo non cambia saremo noi a farlo. Secondo te in che modo? La scrittura è uno strumento per accogliere il cambiamento o per provocarlo?
La poesia attiva inevitabilmente introspezione e ascolto delle emozioni più sedimentate, degli elementi del sé più sopiti e conflittuali. Saperli riconoscere e saper dare loro un nome è un primo passo per accoglierli e per poterli, eventualmente, trasformare. Dunque sì, la poesia ha certamente la capacità potenziale di attivare un cambiamento, nel linguaggio e nel pensiero, accogliendoli e accompagnandoli verso un emisfero emerso. Non è per forza detto, però, che questo cambiamento si realizzi completamente; in potenza resta l’importanza della riflessione stessa sul topos del mutamento.
In Sono viva, scrivi che sei viva nel movimento e nella quiete. È un inno alla celebrazione del presente, o una riflessione più profonda sulla condizione umana?
Il significato di questi versi risiede e si aggancia al momento presente. La stasi e il movimento sono presenti come lo yin e lo yang, incarnando la dualità di ogni cosa.
La scrittura permette di porre in luce e scoprire i lati costruttivi di questo dualismo, consentendo a chi scrive di viverlo con meno affanno, accogliendo i momenti di accelerazione e quelli di quiete come parte integrante e coesistente del processo e del nostro percorso di vita.
So che può essere difficile, ma c’è una poesia di questa raccolta a cui sei particolarmente legata?
Non credo di preferire alcuni versi su altri.
Tutti i componimenti rappresentano momenti significativi della mia vita da un paio d’anni a questa parte. La bellezza è che gli stessi componimenti si mostrano come la summa di un unico grande discorso e portano con sé – ognuno a suo modo – le sfaccettature di stati d’animo profondi. Probabilmente il componimento “La vita è quella cosa oltre il desiderio” rispecchia bene sinteticamente le mie riflessioni sulla vita fino a qui. ♦︎