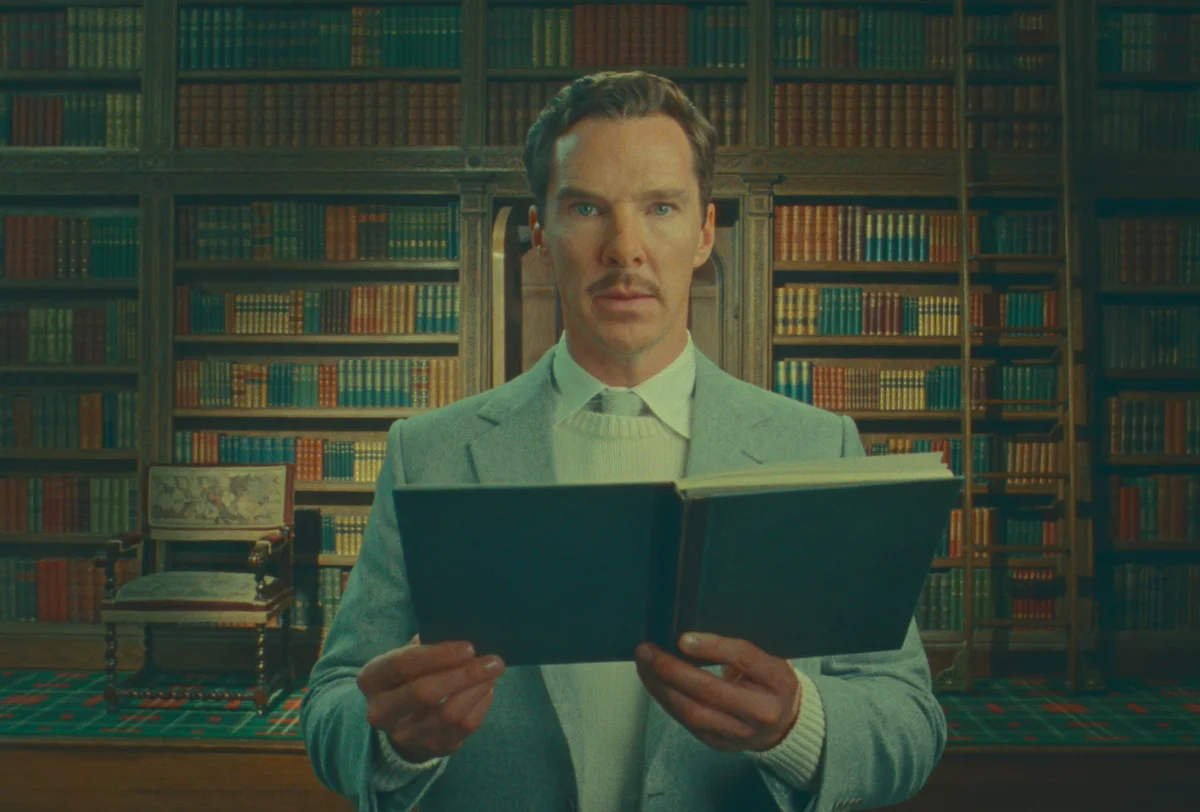È trascorso un secolo esatto dalla nascita del colosso d’animazione più famoso al mondo. Dai primi disegni di Walt in un piccolo studio di Kansas City, alla creazione di un business che vale miliardi e una multinazionale quotata in Borsa con più di centomila dipendenti. Ma quand’è che il sogno è finito ed è cominciata la realtà?
Anaheim, California. 17 luglio 1955. L’America di Eisenhower sta per entrare in guerra contro il Vietnam. Ciononostante l’attenzione mediatica è spostata altrove: non solo gli abitanti della West Coast ma quelli di tutto il mondo stanno aspettando questo giorno di luglio. Sono gli anni Cinquanta, la guerra vicina pare un ricordo lontano, il denaro ha ripreso a circolare: sono i presupposti di una società che sta cambiando, ma anche di una società che continua ad aver bisogno di sognare. Il sogno di quest’estate ha un nome, un indirizzo e un artefice. Nella zona alla periferia di Los Angeles, a solo un anno dall’inizio dei lavori, viene inaugurato il primo parco a tema del mondo: si chiama Disneyland, «Il posto più felice sulla terra». Folle di curiosi si sono accalcate ai cancelli dalla notte prima. La cerimonia d’inaugurazione è trasmessa in diretta televisiva sulla rete ABC e viene seguita da circa settanta milioni di persone. Il suo visionario creatore, Walter Elias Disney, conosciuto al grande pubblico, semplicemente, come Walt Disney, indossa giacca, cravatta e un sorriso rincuorante. I personaggi nati dai lungometraggi animati macina-successi, realizzati dagli studi che portano il suo nome, gli camminano accanto: è l’inveramento del suo sogno.
Cos’è a rendere tutto così speciale? Parate scintillanti, giostre colorate, pop-corn e noccioline. E ancora: un castello incantato, i festoni, le maschere. Non è solo lo spettacolo del boom economico e del consumismo. C’è dell’altro. Come riesce questa frenesia collettiva, a tratti sfiorante note di kitsch, a coinvolgere e attrarre la gente di tutto il mondo? Walt lo spiega chiaramente nel suo discorso inaugurale: «Disneyland è dedicato agli ideali, ai sogni e ai fatti che hanno creato l’America, con la speranza che sarà una fonte di gioia e ispirazione per tutto il mondo». In televisione va forte ed è soprannominato ‘lo zio Walt’: come si può non credergli? E infatti la gente gli crede, vuole credergli, ne ha bisogno. L’incantesimo è lanciato e i luoghi immaginati diventano realtà. È il sogno di Walt che diventa un sogno collettivo. Il punto più importante della sua carriera e della sua compagnia: la Walt Disney Company.
Adesso che anche Hollywood è dalla sua parte, è facile stendergli tappeti rossi. E pensare che non troppi anni prima, invece, ogni sua impresa era definita con l’appellativo di ‘Walt’s folly’, l’ennesima ‘follia di Walt’, perché i suoi investimenti non sempre partivano da un terreno sicuro. Ma nel 1955 è ormai risaputo che tutto ciò che tocca si trasforma in oro: qualsiasi sponsor è disposto a spendere cifre indicibili pur di accaparrarsi un posto d’onore all’inaugurazione del suo parco divertimenti. Non tutti sanno, però, che il suo primo, vero partner commerciale, prima ancora di diventare un marchio conosciuto internazionalmente e icona principale della sua azienda, esisteva solo nella sua immaginazione.
Comincia tutto con un topo
In realtà, è cominciato tutto con un coniglio, Oswald the lucky rabbit, e prima ancora con un gatto, Felix the cat. Entrambi i personaggi funzionano, ma non sfondano nel mercato cinematografico. Walt, classe 1901, serba la passione per il disegno fin dalla tenera età, ed è ossessionato da un’arte appena nata: l’animazione. Ma disegnare per altri non gli basta, vuole che i suoi lavori portino il suo nome. Come trasformare il proprio talento in un’impresa? Il giovane Walt ha già dimostrato che la caparbietà non gli manca: ha appena sedici anni quando, falsificando la data di nascita sui documenti per essere reclutato, lascia la scuola per andare in Francia a fare l’autista volontario di ambulanze nella divisione statunitense, durante la Prima Guerra Mondiale. Al ritorno sa solo una cosa: è disposto a tutto pur di trasformare il suo sogno in realtà.
La sua scalata al successo comincia con un fallimento: il Laugh-O-Gram Studio, il suo primo studio di animazione, con sede al leggendario McConahay Building di Kansas City, chiude i battenti dopo appena un anno. Le spese sono troppo alte, i fondi troppo pochi. Un’esperienza che però segnerà l’inizio del lungo sodalizio con Ub Iwerks, collaboratore e rivale cui condivide la paternità del suo personaggio più famoso.
Pochi mesi più tardi, Walt torna in California. È il 16 ottobre 1923 e insieme al fratello Roy fonda i Disney Brothers Studio, più avanti chiamati Walt Disney Animation Studios. È l’inizio di tutto. Sarà necessario un decennio di tentativi prima di arrivare al personaggio che ne decreterà la fama: Mickey Mouse, Topolino, che aveva già debuttato in due corti di fredda accoglienza, conquista il pubblico nel 1928 con Steamboat Willie, il primo cortometraggio animato sonoro della storia. Walt è costretto a vendere l’auto per sostenere i costi dell’innovativo sistema di sincronizzazione venduto dalla Pat Powers e chiamato Cinephone. «L’effetto sul nostro piccolo pubblico era nientemeno che elettrico» racconta Walt in un’intervista, «risposero quasi istintivamente a questa unione di suono e movimento». Walt Disney ha fatto centro e allo stesso tempo comprende uno dei principi chiave del successo della sua compagnia d’animazione, anche per il futuro: il sodalizio inscindibile tra tecnica e arte. È un nuovo modo di fare impresa, ed è solo l’inizio.
Lo stesso pattern si ripeterà altri dieci anni dopo, quando la nuova tecnologia del Technicolor si combina al sonoro dando origine al primo lungometraggio firmato Disney: Biancaneve e i sette nani sbanca al botteghino, il pubblico è entusiasta, così come i grandi nomi di Hollywood che siedono nelle prime file alla proiezione dell’anteprima al Carthay Circle Theatre di Los Angeles. È una standing ovation in cui figurano, fra gli altri, Charlie Chaplin, Shirley Temple, Judy Garland, Ginger Rogers, Jack Benny, Clark Gable e Marlene Dietrich. La Walt Disney Company ora fa parte del loro mondo e a comprovare il suo successo è la famosissima copertina del Times datata 27 dicembre 1937: Walt sfodera il suo sorriso rassicurante e regge in mano le statuine dei sette nani. In una didascalia figura la scritta: entrambi i fratelli Disney non hanno bisogno di tasche. Ci siamo. La Walt Disney non è più solo una fabbrica di sogni, ma di un vero e proprio capitale in azione.
L’impero mediatico
All’inizio degli anni Sessanta, dal punto di vista contabile, l’evoluzione della società è visibile: i guadagni maggiori non sono più dovuti all’animazione. Le entrate più importanti dell’azienda infatti iniziano a provenire dai prodotti derivati. Che i personaggi Disney fossero entrati nell’immaginario collettivo e in quello commerciale l’aveva intuito già Umberto Eco: «Walt Disney non esiste più, perché ha creato una serie di personaggi che hanno iniziato ad avere vita propria e sono entrati nel costume, dalle carte di caramella ai giornalini per ragazzi».
Il potere di Walt sta proprio in questo: la creazione di un immaginario e di un’estetica ben riconoscibili da adulti e bambini, che bucano lo schermo e arrivano nelle case. Linee morbide, colori accesi, la musica: il lungometraggio Cenerentola del 1950, dal grande impatto visivo, contribuisce ad affermare l’immagine degli Studios e a importare la loro visione. Così si diffonde il mantra di un’intera generazione: «I sogni son desideri».

Waking Sleeping Beauty
Ma anche dai sogni più belli bisogna svegliarsi. È il 1966 e dopo la morte del suo fondatore seguono anni durissimi in casa Disney, quasi quanto quelli conosciuti durante la guerra e i flop al botteghino di due dei più amati classici: Pinocchio e Fantasia, entrambi usciti alle soglie del conflitto. Durante gli anni Quaranta, tuttavia, gli studi erano riusciti a mantenersi, ad esempio con Bambi (che, seppur proiettato durante il periodo della guerra, riuscì a recuperare il suo costo considerevole nella riedizione del 1947), ma anche con alcuni cortometraggi a stampo propagandistico come Der Fuehrer’s face, che vedeva Donald Duck, Paperino, protagonista di una parodia a stampo nazista culminante nella lettura del Mein Kampf.
Agli albori delle proteste sessantottine, l’aria di cambiamento investe anche gli Studios, adesso passati in gestione al nipote, Roy E. Disney. Gli animatori scendono in piazza, in protesta per le paghe misere e gli spazi inadeguati. L’animazione non è più l’unico focus dell’azienda e questo sta diventando sempre più evidente. La Disney attraversa un periodo di aridità creativa. Il momento più buio di questa crisi dell’animazione, che inizialmente, anche grazie all’aiuto della televisione, è stata in grado di risollevarsi macinando successi (Gli Aristogatti, 1970, Robin Hood, 1973), arriva proprio negli anni Ottanta. Tuttavia, e la storia di Walt lo insegna, i grandi fallimenti precedono i più grandi successi. Dopo lo scarsissimo successo di Taron e la pentola magica, a fronte di un sempre più smembrato e sottopagato reparto animazione, che conta tra i suoi membri anche gli allora sconosciuti Tim Burton e John Lasseter, il gruppo di animatori rimasti guidati da Jeffrey Katzemberg, il nuovo responsabile del reparto animazione, inizia a progettare nuove storie.
Dicono che sia tempo di svegliare la Bella Addormentata. Agli albori degli anni ’90, nel periodo che fu ribattezzato «Rinascimento Disney», nascono alcuni dei capolavori d’animazione più famosi, come La bella e la bestia, che diventa il primo film d’animazione della storia a essere candidato nella più ambita cinquina Oscar: la categoria Miglior Film.
Intanto Michael Eisner, il nuovo amministratore delegato, benché supervisionato da Roy E. Disney, ha le idee chiare: la Disney è una multinazionale che deve stare al passo con i tempi. Sua l’idea di fondare la Disney Cruise Line e lanciare in formato home-video le videocassette da vedere e rivedere a casa. Navi da crociera e campagne di merchandise: anche questo è la nuova Disney. Alla famosa domanda di Diane Sawyer nel suo format 60 minutes, «Potete davvero permettervi di fare quello che state realizzando nell’animazione?», la risposta di Eisner è stata: «No, ma lo facciamo comunque, è la nostra eredità».
La nuova generazione
Quanto è rimasto del sogno di Walt nelle storie create nel nuovo millennio? La collaborazione con la Pixar iniziata nel 1995 con il lungometraggio Toy Story segna una svolta: non solo per la tecnica di produzione, che introduce l’innovativo sistema CGI, ma soprattutto per le storie narrate. È il cambiamento generazionale che dà il via a un ampliamento di temi e a un fondamentale traghettamento degli Studios nel nuovo millennio. Con il film Alla ricerca di Nemo (2003), la collaborazione Disney-Pixar riesce a conquistarsi finalmente la statuetta nella categoria più ambita fin dagli albori dell’animazione. Nuove storie e una nuova sensibilità si diffondono in Casa Disney, che dimostra ancora una volta di saper cogliere lo spirito del tempo e sapersi rinnovare. È il caso di Come d’incanto (2007), che mette in scena proprio una domanda: quanto ancora possono essere attuali gli ideali veicolati dalle storie firmate Disney, quelli per così dire più tradizionali?
A entrare in crisi con il sentire moderno è stata anche l’idea della ‘principessa’, sostenuta da un’inchiesta pubblicata sulla rivista Child Developement in cui si riscontra una correlazione tra l’engagement nei confronti delle Principesse Disney e lo sviluppo di comportamenti legati agli stereotipi femminili. La creazione di eroine nuove capaci di superare gli stereotipi e che siano raccontate con maggiore profondità è stato uno degli obiettivi principali dell’operazione di rebranding degli ultimi dieci anni, attuato con l’ausilio dei lungometraggi Frozen, Il regno di ghiaccio, Oceania, e Encanto: tutte pellicole che si impegnano a veicolare messaggi di emancipazione femminile. Un altro filone su cui gli animatori si sono concentrati è quello metafisico: si pensi al lungometraggio del 2015 Inside Out, che si concentra sul dialogo con le proprie emozioni e Soul, del 2020, che porta per la prima volta sullo schermo in un film d’animazione il tema dell’aldilà.
Accanto a questi nuovi prodotti, sintomo di una forte sensibilità per le questioni più dibattute nella società, nel 2020, dopo il lancio della piattaforma di streaming Disney+, sono stati introdotti disclaimer prima dell’inizio di alcuni film per avvertire il pubblico della presenza di ‘rappresentazioni negative e/o offese di persone o culture’. Insomma, un esempio di cancel culture, o una semplice presa di posizione da un contenuto dannoso per imparare da esso, anziché rimuoverlo?
Nel 1993, a ventisette anni dalla morte del fondatore, all’entrata del parco di Anaheim è stata posta una statua di rame: Walt e Mickey, creatore e creazione, mano nella mano. Il sognatore e il suo sogno, nello stresso mondo: non è una favola hollywoodiana ma la realtà. È la storia di due compagni indispensabili l’uno all’altro. È la storia di un’idea uscita dal cassetto di una scrivania di un piccolo studio nel Missouri e trasformatasi in realtà. I detrattori potrebbero chiedersi cosa sia la Disney, se non la più grande trovata commerciale del XX secolo, venduta come una favola. Ma anche di fronte allo sfarzo consumistico che si cela dietro ai parchi, non si può non pensare all’incredibile storia di un sogno che ha saputo rinnovarsi anno dopo anno, continuando a far sognare la gente.
Ma oggi c’è ancora voglia di sognare? E di farlo nel modo che Walt era stato tanto bravo a insegnarci a fare?
Una nuova generazione implica un nuovo punto di vista: attualmente la tendenza a raccontare storie con un forte attrito al dato reale, ha lasciato da parte la magia di storie confortanti e di happy endings in cui rifugiarsi. I lungometraggi dell’epoca d’oro della Walt Disney, portatori di quei valori novecenteschi oggi perduti, saranno per sempre testimoni di quel preciso spirito del tempo che li ha permeati e di una fiducia incondizionata nel futuro che oggi non esiste più, se non del tutto, almeno in parte. Eppure riescono ancora a esercitare un fascino nostalgico e a stimolare i ricordi, la fantasia e lo spirito dell’american dream.
Ecco che allora il celebre motto di Walt Disney, per essere attuale, andrebbe cambiato in questo: «Se puoi sognarlo, puoi farlo. E non è un male capitalizzare sul proprio sogno». Infatti, è bene dirsi la verità: la Walt Disney Company non sarebbe mai nata senza un sogno nel cassetto e un investimento in banca.
Fotografia di Kaleb Tapp