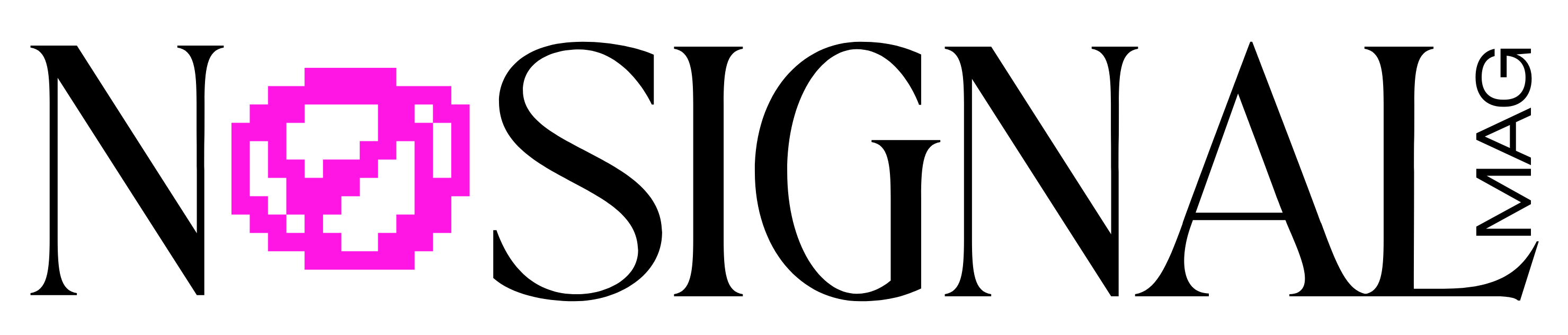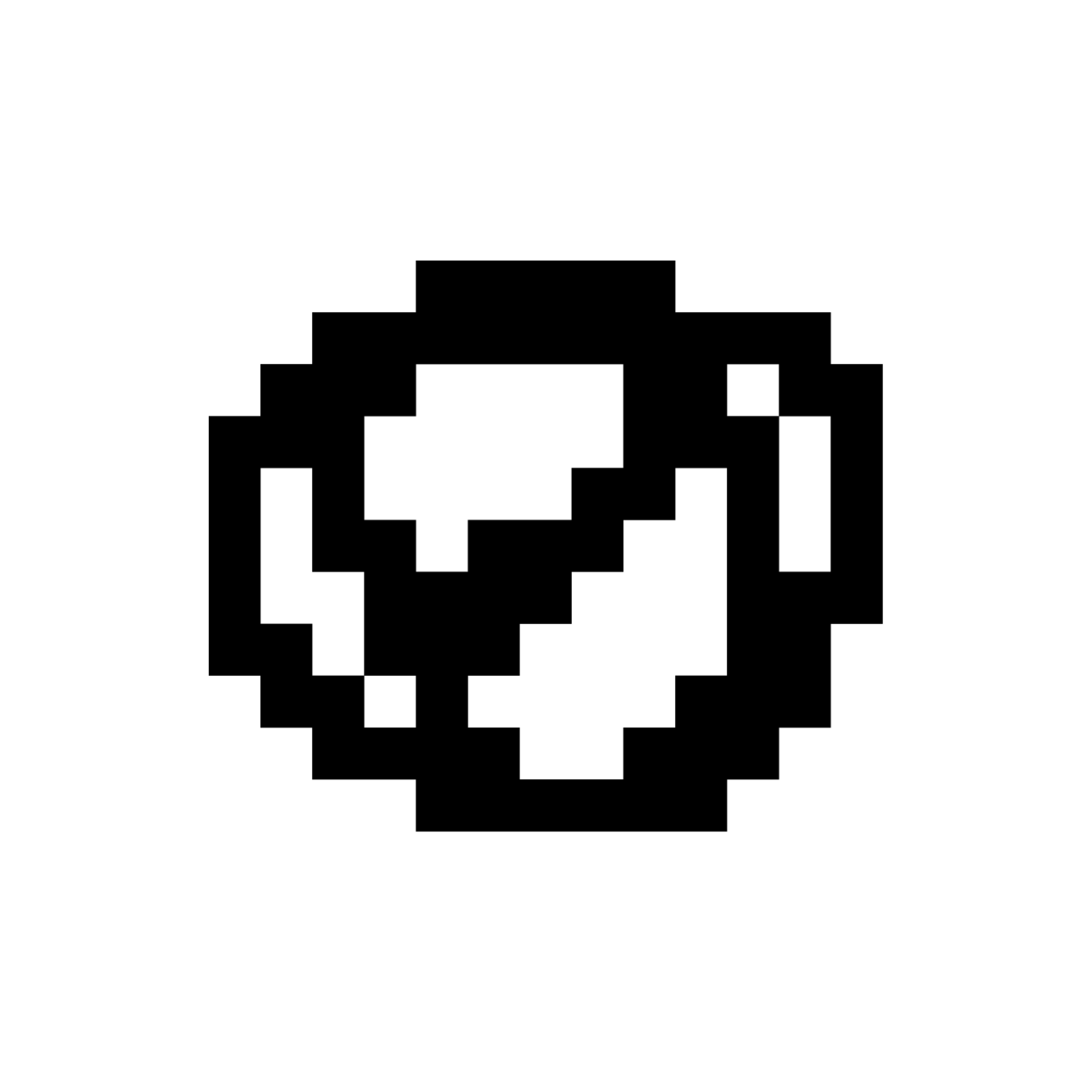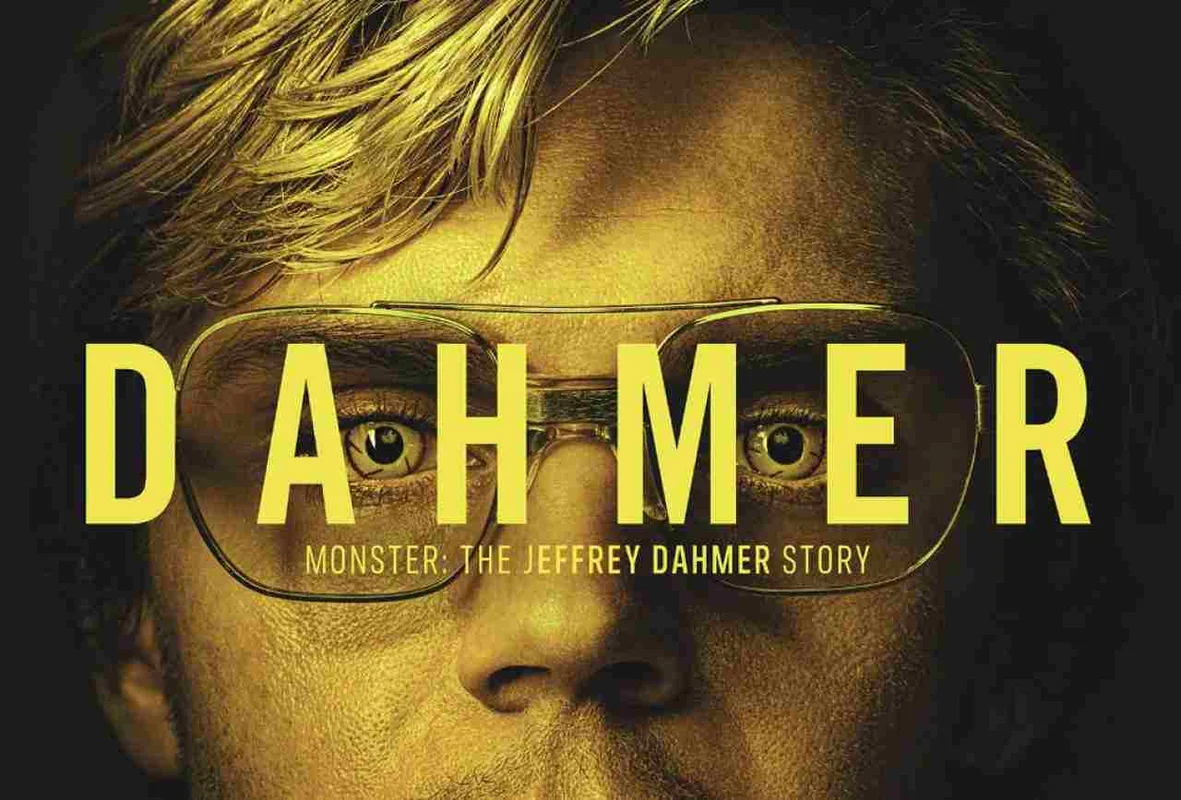La vita è una messa in scena (con amore per i film). Primo episodio
Non siamo più fatti per le relazioni solide. Tra un articolo che parla di come nel 2050 gran parte delle famiglie sarà composta da single e un altro che demonizza le app di incontro, le conclusioni a cui arrivano due autori diversi sono le medesime. Non siamo più fatti per le relazioni solide. Non ci meravigliamo più di un incontro perché ci aspettiamo che il prossimo sarà migliore. Ma, soprattutto – scusate la ripetizione – non esiste più nessuno più speciale di noi. Fatto sta che a volte bisogna lasciar sedimentare i pensieri e poi alle domande si trovano risposte casuali. Per esempio, qualche giorno dopo la lettura di questi articoli conosco una persona. Una bella persona, penso. Di quelle che glielo leggi negli occhi che le piace guardare film. Allora le faccio una proposta:
«Conosci Harold e Maude?»
«Chi conosco, scusa?»
È stata una scelta casuale – stavo cercando di trovare online una locandina originale – che mi ha portato a scrivere questo pezzo per entrare nel dibattito con gli altri articoli che ho letto. Non perché io abbia una risposta in merito alla questione. Non so se non siamo più fatti per una relazione solida. So solo che il film di Hal Ashby racconta una relazione speciale.
Chi conosco, scusa?
If you want to sing out, sing out / And if you want to be free, be free
(Cat Stevens)
Premessa: non so quanti della mia generazione, o di quelle successive, conoscano «Harold e Maude», il film di Hal Ashby con Bud Cort e Ruth Gordon che interpretano rispettivamente un diciottenne un po’ depresso con la passione per i funerali di sconosciuti e Maude, una quasi ottantenne che vive felice fuori dalle righe, libera dagli schemi. Ma spero che la mancata visione non venga presa come un limite a continuare a leggere. Semmai, una spinta a recuperare poi il film.
Anche perché non ci interessa per una volta l’evoluzione della storia. Quello su cui mi voglio soffermare sono i due caratteri, Harold e Maude, e la loro relazione. Sì, perché all’apparenza verrebbe da dire che il matrimonio non sa da fare e non perché gli si opponga un reale antagonista, quanto perché Harold sembra, anzi è, diversissimo da Maude. Harold è un ragazzo triste, che si sente incompreso. Viene poco sopportato dalla madre, non si capisce se abbia un padre, e inscena suicidi per attirare l’attenzione del suo unico genitore o per allontanare una potenziale fidanzata, proposta da un computer che funziona come le moderne app di incontro. E ama la morte. Harold è la pulsione di morte fatta a persona. Almeno fino a quando non incontra Maude, che invece è la pulsione della vita in carne e ossa. Maude probabilmente ha vissuto gli ideali del ’68, l’amore hippie, la libertà da un certo tipo di imposizioni, di regole, di strutture. Tutto ciò che Harold vive con un tale peso che lo vuole impostato dentro un completo gessato e la cravatta.
L’altro grande scarto fra di loro, la differenza d’età, non gli impedisce di stare insieme sopra una motocicletta rubata alla polizia e di vivere il loro amore come meglio credono. Perché sanno stare l’uno al fianco dell’altro. Maude è capace di passare il tempo con Harold senza costringerlo a vedere le cose in un certo modo, come invece tenta di fare la madre, che vorrebbe indicargli la strada e scegliere persino la fidanzata. No, Maude, al massimo, desidera che Harold impari a essere libero. Dalle imposizioni. Da sua madre. Dalla morte. Libero di essere se stesso. E anche Harold dimostra di sapere amare liberamente. Non fa mai sentire inadeguata Maude e impara a starle al fianco sempre, anche durante le sue piccole follie. Credo non si dovrebbe desiderare altro: trovare qualcuno che ci accolga senza prevaricare e sapere accogliere non prevaricando mai.

Esseri speciali
In my life, why do I give valuable time / To people who don’t care if I live or die?
(The Smiths, Heaven Knows I’m Miserable Now)
Ma non dobbiamo sbagliare: quello che rende speciale la relazione tra Harold e Maude non è la libertà. Almeno, non soltanto. Dove esiste l’amore, non c’è spazio per la libertà assoluta, per l’individualismo.
Tra i filosofi contemporanei, quello che mi piace di più leggere riguardo al tema dell’amore è Byung-Chul Han. Lui sostiene che l’individualismo contemporaneo, di origine capitalistica, sia ciò che sta uccidendo la possibilità dell’amore. In una società dove l’imperativo è la massima produttività, dove o sei efficiente o sei guasto, non c’è spazio per amare, solo per consumare. E in questo le app di incontri, per esempio, funzionano benissimo. Pensiamo alla quantità di profili, allo scrolling e agli effetti dell’iper-esposizione. È come andare in macelleria ed essere allo stesso tempo un pezzo di carne. Ci relazioniamo consumandoci l’un l’altro. Ma è da chiarire: la causa non sono le app d’incontro o i social. Non sono loro i demoni, il mostro è dentro di noi. Perché succede anche fuori dal digitale. Il paradosso è che reprimiamo la nostra sessualità per godere, qualsivoglia, di un’immediatezza. Godiamo in solitudine, per noi stessi, narcisisticamente.
E secondo Byung-Chul Han, siamo servi del capitalismo che vuole manipolare e addomesticare l’eros. Dato che la pulsione sessuale viene percepita come minacciosa per l’ordine costituito, è necessario reprimerla. Come? Rendendola una prestazione di produttività: le energie vengono impiegate solo nel rapporto immediato tra i corpi, cioè una relazione di pura genitalità. Una frase che ho sentito dire spesso, «avrei potuto piuttosto masturbarmi che scopare», non deve far paura per la sua banalità. Non ha nulla di banale. Le app d’incontri non ci devono spaventare: è di noi che dobbiamo cominciare ad avere paura. Dobbiamo temere il nostro narcisismo, perché la sua forma più estrema è sempre dietro l’angolo. Oggi godiamo di noi stessi per la nostra efficienza, per le nostre conquiste, godiamo nel bloccare un istante della nostra giornata perché lo percepiamo come una conquista del nostro tempo sul tempo degli altri. Ci sentiamo speciali come se avessimo la mamma che ce lo sussurra di continuo nell’orecchio. Essere speciale sembra un imperativo assai moderno. Ma se tutti noi abbiamo la possibilità di sentirci speciali per noi stessi, fin dove deve arrivare questo sentimento?
Torniamo al film. C’è Harold: un ragazzo che ama andare ai funerali degli sconosciuti, che potrebbe godere di una ricchezza sconfinata, potrebbe persino comprarsi una Porsche, e invece preferisce acquistare un’auto da cerimonia funebre. Non è da tutti, è qualcosa che non si sente spesso dire di un ragazzo. È strano. Particolare. È diverso. Ma poi c’è la società odierna, e vien da pensare che uno come Harold non sia molto efficiente se continua a inscenare suicidi e rifiutare le ragazze che il computer gli propone. Allora, o Harold si confà agli standard, oppure è inutile. Ecco, credo che solo in questo caso sia lecito sentirsi speciali: quando c’è qualcuno che prova a cambiarti. Altrimenti, perché sentirsi speciali per se stessi? Piuttosto che sentirci speciali, dovremmo coltivare la fedeltà verso noi stessi, la nostra diversità dai tentativi e dalle tentazioni dell’omologazione, e difendere anche le nostre stravaganze.
Diventare speciali
Take a woman like you / To get through to the man in me
(Bob Dylan, The Man in Me)
Dobbiamo imparare a conoscerci, così che possiamo vederci da una certa distanza, riconoscere le nostre fondamenta e ciò che invece è ancora malleabile. Ciò che dobbiamo proteggere, ciò che può cambiare. Dobbiamo cercare in tutti i modi di allontanare le forme più estreme di narcisismo. Opporci all’individualismo sfrenato di cui soffriamo, come società, per fare spazio al ritorno dell’Altro. Oggi l’Altro è eroso, sessualizzato e poi espulso. Nelle nostre vite non c’è spazio davvero per qualcun altro. Questo sostengono gli articoli che ho letto: non siamo più fatti per le relazioni solide. Perché l’unica relazione che coltiviamo senza sosta, direbbe Han, è la relazione con noi stessi. E la cosa peggiore sono le conseguenze di questa relazione. Precipitiamo nelle sabbie mobili. Diventiamo vittima della nostra ombra e quello che vantiamo come una libertà illimitata si rivela una prigione. La conseguenza è una società sempre più depressa.
E torniamo a Harold. Prima di conoscere Maude, Harold era un ragazzo depresso. Poi, sosterrebbe Han, l’amore lo salva dalla depressione. E ciò che l’incontro con Maude ha scatenato riguarda tanto la libertà personale di Harold quanto la sua negazione. Non è più lo stesso ragazzo. Qualcosa è cambiato in lui, si è modificato grazie all’incontro con un altro essere umano. Perché Harold ama ancora andare ai funerali degli sconosciuti, ma non lo fa più da solo, e non lo fa più nello stesso modo. E se anche dovesse capitargli di andare da solo, non sarebbe più lo stesso Harold di prima. Lui e Maude hanno scoperto una felicità condivisa. Hanno istituito riti. Sono diventati speciali, l’uno per l’altra.
C’è nel film una scena così bella che ogni volta mi fa saltare sulla sedia: comincia con un focus sul colore bianco, poi la telecamera si allontana e scopriamo che sono dei fiori. Allora sentiamo la voce di Maude che chiede ad Harold quale fiore gli piacerebbe essere. Harold risponde che non lo sa, forse uno di questi che sembra uguale a tutti gli altri. Ma Maude non è d’accordo: anche quei fiori non sono tutti uguali. E anzi, è il grande problema dell’essere umano: «Sai, Harold? Secondo me gran parte delle brutture di questo mondo viene dal fatto che della gente che è diversa permette che altra gente la consideri uguale». Quando Maude dice questo, si trovano sul prato in mezzo ai fiori. Poi un cambio di prospettiva rivela che sono in un cimitero. E al posto dei tantissimi fiori, si stagliano file e file di tombe. L’amore e la morte, indissolubilmente legati insieme. Oggi è spaventoso immaginarlo per sé: che nell’incontro con un altro, nel dargli spazio, sia necessario perdere qualcosa, vivere nella relazione la morte di noi in quanto passaggio, il cui ritorno (a noi stessi) ci vedrà modificati. Sì, significa essere morti un po’: di Harold è morta quella parte autodistruttiva, e la depressione è scomparsa. Non ha avuto bisogno della cantilena del «sono speciale», ma di trovare, per caso, qualcuno da amare. Ecco Maude, che ne ha di consigli da dare: «A un sacco di gente piace essere morta, però non è morta veramente. È solo che si tira indietro dalla vita, e invece bisogna… bisogna cercare, correre i rischi… soffrire anche, magari, ma giocare la partita con decisione!».

Allegra serata cinema
Resta poco tempo per capire / Il significato dell’amore
(Baustelle, Il Vangelo di Giovanni)
Lo schermo si annerisce. Il film è finito. La persona che ho invitato a guardare Harold e Maude mi sorride. Dagli occhi si capisce che le è piaciuto. Ma non ci è solo piaciuto. Credo che ci abbia portato ad avere una conversazione che altrimenti non avremmo avuto. Di queste parole, su due pensieri in particolare che ha espresso, ho continuato a riflettere. Nel primo, sosteneva di non gradire l’essere associato a qualcun altro. Nel secondo, rispetto al suo passato di rapporti effimeri, manifestava il desiderio di avere una bella relazione, che potesse durare a lungo.
Non sono stato spaventato dal fatto che sono due pensieri apparentemente contraddittori. Piuttosto, ho sentito che c’era in quella contraddizione il seme che ha fatto germogliare in me questo pezzo. Ho capito che l’essere associato a qualcuno oggi per noi significa perdere qualcosa in identità. E qui torniamo alla società capitalista e al suo dogma di trattarci come macchine, di essere produttivi, di essere per noi stessi. Di godere di una, cento, mille immediatezze. Eppure c’era quella sera, sono convinto ci sia ancora, in quella persona un desiderio uguale e contrario. Trovare un legame come quello tra Harold e Maude. Solo che sembrava stanca di cercare. Parlava di trovarlo piuttosto nelle persone più vicine perché era stufa di entrare nell’iter che le conoscenze prevedono, come per altro la nostra.
Eppure, si trovava lì, e si è sentita predisposta ad avere una conversazione che altrimenti non avremmo mai avuto. Nessuno ha cercato di prevaricare con le proprie idee tanto che non siamo arrivati a una reale conclusione. Perché una conclusione non esiste (ancora), e per fortuna. Noi, tutti noi, abbiamo (ancora) un piccolo spiraglio per salvarci. E non è uno di quei discorsi cristiani, se l’unica cosa che può salvarci è l’amore. Non vi dirò amate l’altro come amate voi stessi, cercate semmai di amarlo di più. Amate più il mondo di voi stessi, tutto quello che non siete.
Vorrei gridare adesso di mettervi per davvero alla ricerca dell’amore, ma smettiamo mai di cercare? E a che serve farlo come un cane che cerca l’osso? L’unica cosa che possiamo fare, forse, è metterci nella posizione di essere pronti quando accade, di avere tempismo. Non credo che l’amore nasca cercando lontano né cercando vicino. L’amore nasce per caso, per il caso d’un incontro che non era affatto necessario.
Viva il cinema! ♦︎
La vita è una messa in scena (con amore per i film) è una rubrica che racconta le relazioni odierne attraverso film iconici. Le illustrazioni sono di Gianni Pucci.