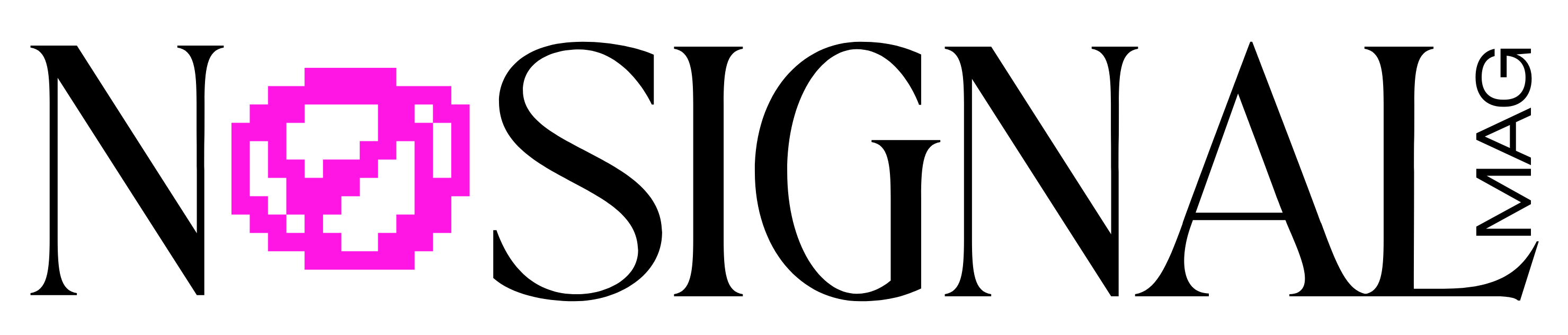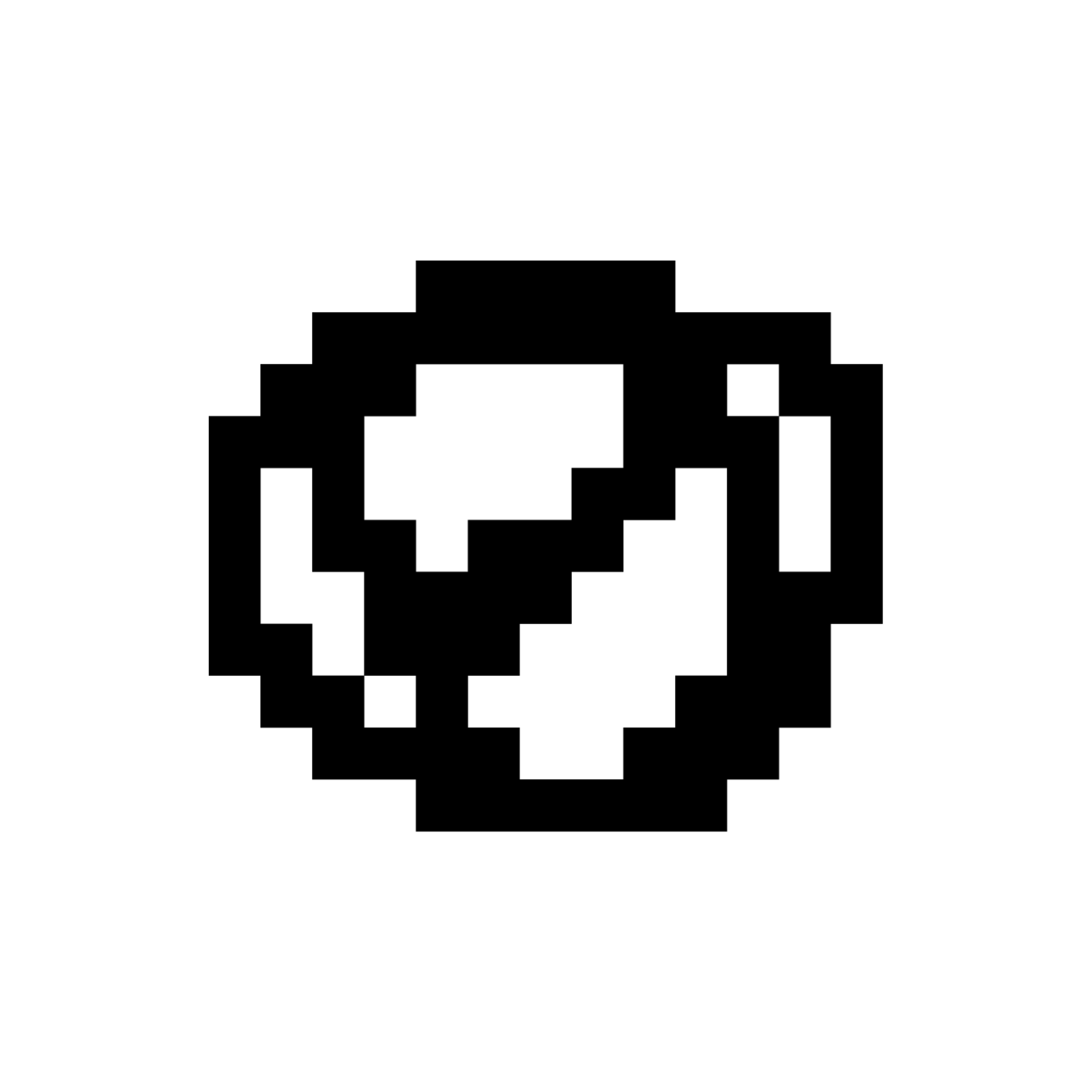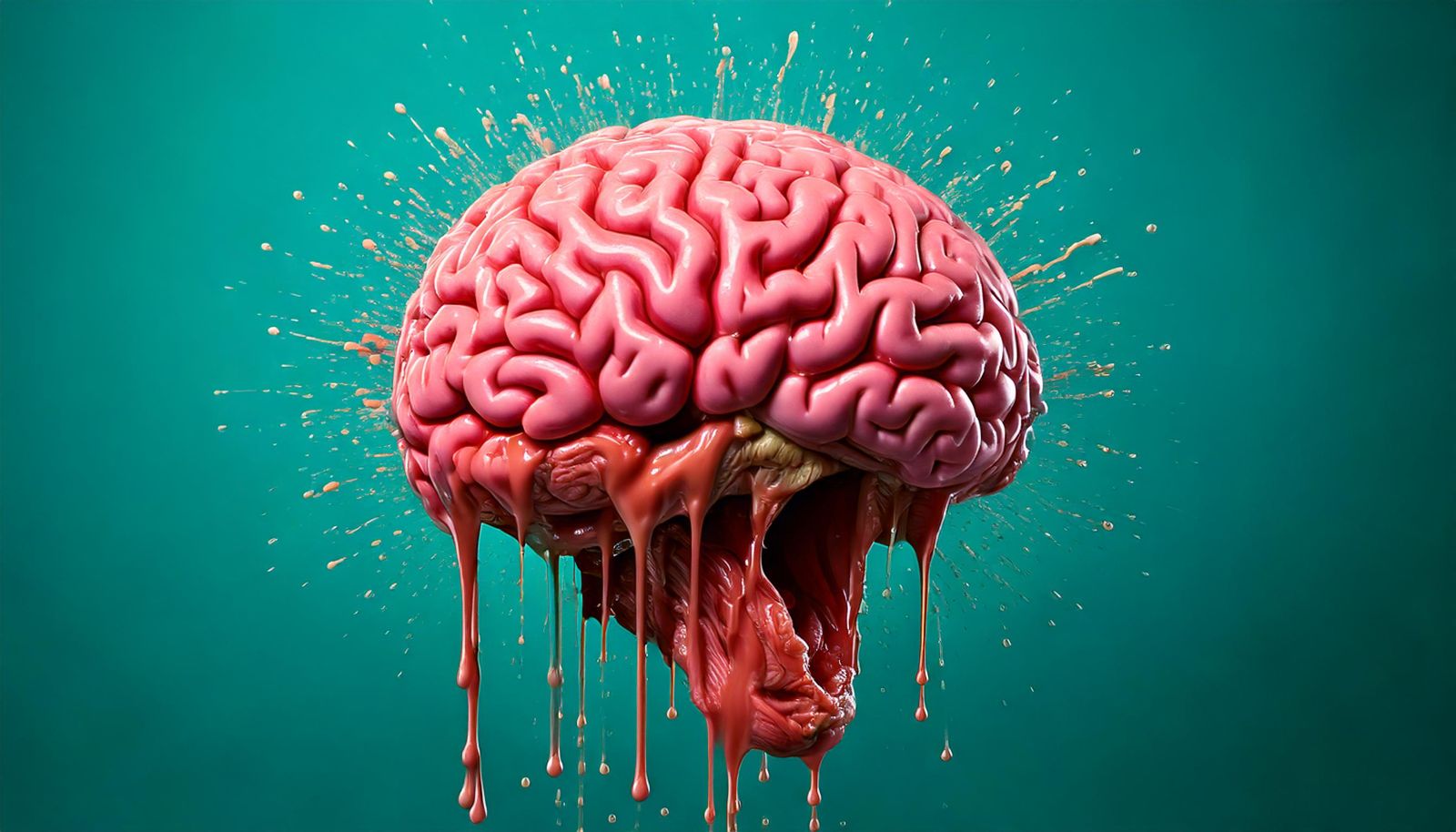Stiamo vivendo il periodo storico più avanzato tecnologicamente, con accesso a database accademici direttamente a portata di pollice, o risoluzione di dubbi amletici ponendo domande ad alta voce al proprio smartphone. La comunicazione è diventata telegrafica, i feed dei nostri social network straboccano di brevi consigli, notizie tempestive, ma soprattutto di informazioni contrastanti. Sommersi dalle fonti in antitesi, annaspiamo cercando quattro righe che confermino quello che speravamo, la risposta che si avvicina di più alla nostra comfort zone, da screenshottare e portare come manifesto della nostra verità. Ma non sempre l’esito è così chiaro: e chi ha il tempo di leggere gli approfondimenti per capire la complessità dietro la domanda cercata?
Nonostante i risultati scientifici, spesso semplificati in grafici o schemi, la disinformazione dilaga, riempie i vuoti incerti e i commenti dei post a favore dell’ambiente, dove solitamente si danno appuntamento negazionisti inferociti. Eppure si era parecchio festeggiato il consenso globale firmato dieci anni fa con gli Accordi di Parigi, sulla necessità di non superare i 1,5°C di aumento della temperatura del pianeta, vidimando l’impegno dei Paesi ad agire affinché questo non succedesse. Tuttavia, secondo l’ultimo Report delle Nazioni Unite di fine 2024, la direzione presa negli ultimi anni punta dritta a minimo + 3°C, ed è cruciale l’impegno collettivo per arrivare a un taglio del 42% delle emissioni climalteranti entro il 2030. Cioè tra 5 anni. Come dovrebbe reagire il cittadino medio leggendo questa notizia?
A novembre, alla Cop29 a Baku, Guterres ha detto ai giovani: «You have every right to be angry. I am angry too». Emozionante sapere di condividere gli stessi sentimenti del Segretario dell’ONU, ma ora come la gestiamo questa rabbia? Perché è spesso questo che porta un’incertezza così dilagante: l’inazione. Lo sconforto per una prospettiva nefasta genera sentimenti di resa. Mentre i governi globali sono sempre più i burattini degli interessi economici industriali, sui social i continui allarmismi sono diventati un antifurto che continua a suonare tutta la notte. Prima ti svegliava, ti infastidiva pure, ma adesso ti ci sei abituato e ti riaddormenti.
Dati, studi e avvertimenti si susseguono a una varietà di contenuti smisurata. Vediamo migliaia di visi nuovi ogni giorno, audio in tendenza, balletti e pubblicità di prodotti ormai direttamente sul profilo del nostro comico preferito, che improvvisamente, tra una battuta e l’altra, consiglia l’ultimo modello di aspirapolvere. Dall’inizio dell’anno le notizie dei neonati morti per il freddo a Gaza si alternano alle foto di panettoni e alle centinaia di consigli nutrizionali su come rimettersi in forma dopo le feste. Non a caso, il 2024 si è concluso con l’Oxford University Press che ha scelto come parola dell’anno «brain rot» (letteralmente «putrefazione del cervello»), contendendosela con «demure» e «dynamic pricing». Si tratta del «presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, soprattutto come conseguenza di un consumo eccessivo di materiale (in particolare di contenuti online) considerato banale o poco impegnativo».
Negli stessi giorni in cui la parola veniva annunciata, mi ha colpita un virgolettato di Domenico Quirico, rilanciato su un carosello Instagram: «Qual è il limite? Griderà qualcuno davanti ai corpi dei bambini palestinesi del campo di Nuseirat uccisi da un bombardamento israeliano mentre erano con le madri in coda a un fornaio». In questo preciso istante, su questo pianeta, in coda al fornaio puoi trovarti il cervello spappolato perché stai guardando dei video demenziali di Tik Tok, oppure perché ti bombardano. Nello stesso preciso istante, sullo stesso pianeta. Dipende solo da dove sei nato. Come faremo a scegliere, nella prossima vita, se metterci in coda dal panificio che usa solo grani antichi, acquistati da piccoli produttori rigenerativi, o da quello dove rischiamo di essere dilaniati da una bomba mentre speriamo in una razione di pane? E noi, che godiamo del privilegio di vivere nella parte del mondo in cui ci troviamo, possiamo davvero accettare che la parola dell’anno sia «brain rot»? Senza bombe che ci uccidono davanti al fornaio, possiamo accettare che il nostro cervello sia in putrefazione mediatica? ♦︎