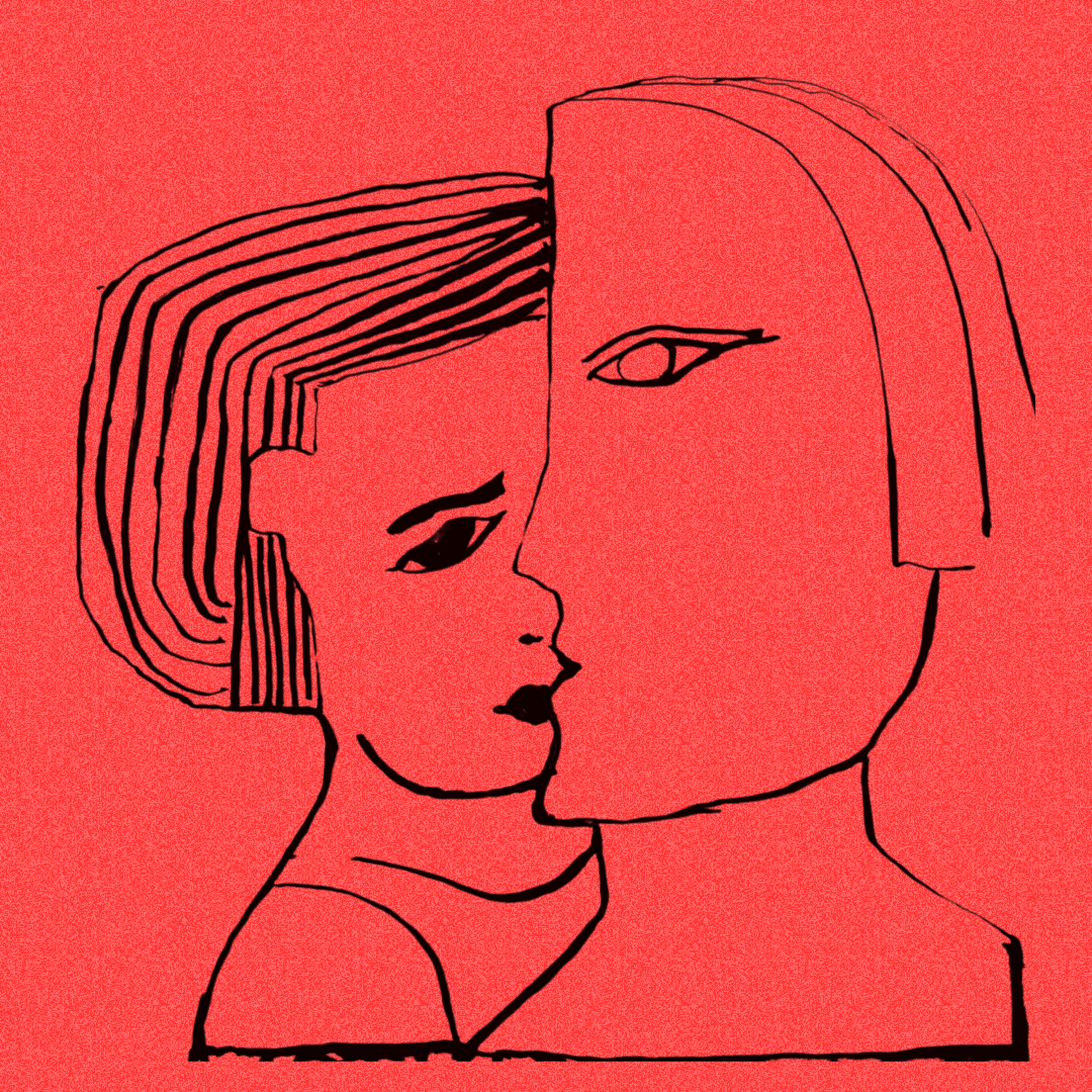Ovvero una riflessione sulla narrazione della violenza di genere
Se l’informazione è il mattone e il cemento è la nostra mente, il muro che ne viene fuori è la narrazione, su cui poggiano le nostre unicità e l’eredità culturale collettiva. In questi giorni l’attenzione dei media e dell’informazione in Italia è tornata sul femminicidio. Nel dibattito pubblico sul tema, la prassi del nostro Paese prevede un picco di interesse in prossimità di un episodio rilevante, salvo poi tornare in tempi brevi alla quiete disinteressata, lasciando tutto l’onere della questione alla parte direttamente coinvolta.
Dal femminicidio di Giulia Cecchettin si sono mostrati scenari diversi. La sensazione è infatti che mai come ora vi sia stata una simile risposta sociale. L’episodio potrebbe segnare il superamento della soglia di sopportazione e l’avvio del tempo dell’azione. In pochi giorni si sono moltiplicate le iniziative spontanee dal basso: attivismo, manifestazioni, progetti, articoli, divulgazione e denuncia sui social, campagne e proteste di massa. Che si stia assistendo alla nascita di una rivoluzione sociale è presto per dirlo. Un auspicio, certo, è che la risposta sia approfondita dal mondo intellettuale. Non limitarsi quindi a sposare la causa, ma andare oltre, fornire ulteriori contributi. La chiamata è ad affiancare l’azione spontanea con la riflessione, ponendo quelle questioni profonde capaci di riempire lo spazio lasciato aperto dalla reazione emotiva a caldo.
Un’urgenza si avverte: analizzare la narrazione di una «società umana in cui nulla è naturale e la donna, come molto altro, è un prodotto elaborato dalla civiltà». Nelle parole di Simone de Beauvoir si delinea il percorso di comprensione di un fenomeno affrontabile solo in relazione a un contesto che non riguardi il singolo, ma la società e le sue narrazioni dominanti. Continuare a raccontare il femminicidio come un problema estraneo a una parte di collettività – vedi componente maschile ‘innocente’ – significa rifiutare un’analisi dell’etica individuale, e poi familiare, cittadina e umana, a proposito dei perché di alcuni comportamenti, pensieri o emozioni. Il risultato non può che essere il mantenimento di un ciclo di inconsapevolezze da cui germoglia la violenza.
Un modo per interpretare la narrazione del femminicidio è a partire dalle componenti culturali e percettive di massa: il cinema, in questo senso, è considerato da molti antropologi uno specchio del reale, in grado, più di qualsiasi altro strumento, di far luce sulla proiezione di elementi collettivi. Ecco dunque che, per quanto possa apparire bizzarro, per comprendere alcune dinamiche narrative della violenza di genere abbiamo riguardato Blue Velvet di David Lynch.
Oltre i drappi di velluto
Blue Velvet è un film complesso e ricco di simboli che esplora diversi lati oscuri della psiche umana e del subconscio. Qui la premessa: la tematica principale del film non è la violenza di genere. Tuttavia, è evidente che numerose linee narrative presentino dinamiche relazionali interpretabili in tal senso. In particolare, il triangolo tra i personaggi ha come vertici tre posizioni emotive ed etiche – chiamiamole ruoli – archetipiche di un episodio di violenza di genere nella società odierna.
Le vicende si svolgono in una cittadina serena e armoniosa il cui idillio viene a poco a poco smascherato. Jeffrey Beaumont, giovane studente del college di Oak Lake, fa ritorno in città per assistere il padre colpito da un ictus. Attraversando un prato verso casa, si imbatte nel macabro ritrovamento di un orecchio mozzato. Il lavoro della polizia è superficiale, così il ragazzo decide di investigare insieme a Sandy Williams, figlia del detective incaricato. La ricerca lo porterà all’incontro con Dorothy Vallens, cantante in un night club, e Frank Booth, l’uomo che sfrutta Dorothy ricattandola attraverso le minacce al figlio e al marito.
L’intero film si muove sul tema del ‘velluto blu’, colonna sonora cantata da Dorothy – con riferimento all’originale di Bobby Vinton negli anni 50’ –, e tessuto del vestito che Frank le strappa. Proprio con la melodia morbida della canzone, Lynch proietta lo spettatore in un mondo ‘da cartolina’: la società borghese tipicamente dipinta dai media, discreta e dedita alle apparenze, sotto cui nascondere la polvere. L’orecchio mozzato è per il regista la rottura dell’illusione.
«Non so perché doveva essere un orecchio. Doveva essere un punto aperto del corpo, un buco che porta in qualcos’altro… L’orecchio si trova sulla testa e finisce direttamente nel cervello, era perfetto». Un buco che rompe l’idillio, ma anche un’apertura verso l’oscurità della psiche umana. Jeffrey vuole guardarci dentro e lo spettatore con lui. In questo scenario, si forma il triangolo relazionale tra Dorothy, Frank e Jeffrey, i tre personaggi intorno a cui ruota la vicenda: la vittima, il carnefice, il contesto.
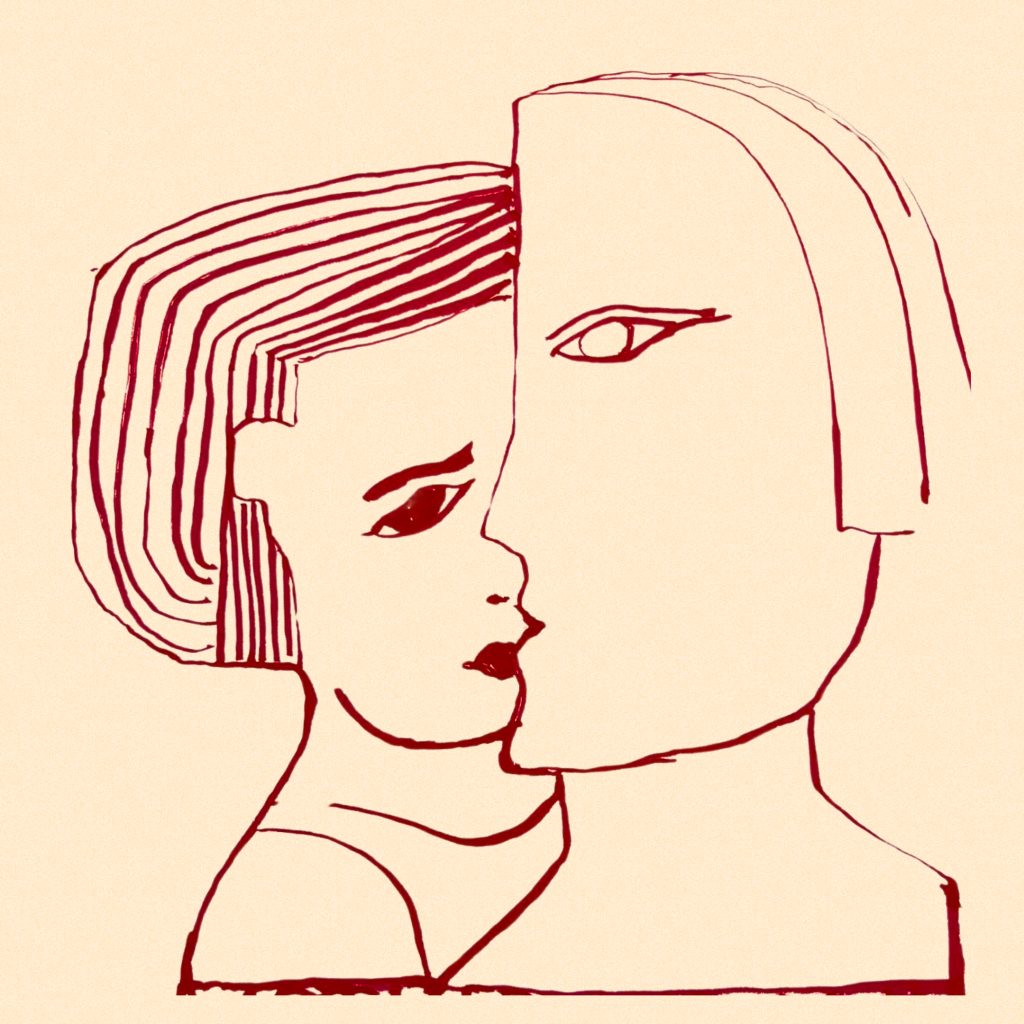
Dorothy è la vittima, un raccordo di violenza fisica, sessuale e psicologica, non solo succube di aggressioni, percosse e stupri, ma anche soggiogata ai ricatti e alle perversioni di Frank. Alla ricerca di una propria umanità, del proprio spessore e della propria dignità di donna, ne è costantemente privata dal carnefice-Frank con dimostrazioni fisiche e verbali, ma anche dal contesto-Jeffrey con lo sguardo. Le conseguenze si riflettono sul suo corpo e la sua figura rimane disumanizzata e martoriata nel profondo.
Frank Booth è il carneficeche vuole Dorothy a completa disposizione per ogni suo desiderio. La figura estrema di Frank mostra ovunque i segni di traumi infantili. La sua vulnerabilità malamente mascherata riaffiora nei momenti con lei. «Baby vuole il velluto blu» o «papà torna a casa», cantilena ossessivamente con voce da fanciullo durante i brutali rapporti sessuali con la donna, di cui sempre fugge gli occhi. Lo sguardo in questo caso smaschera: la risposta di Frank è inevitabilmente la violenza, nel tentativo di ristabilire la sua apparente invulnerabilità. Così, ogni possibile manifestazione di un’emotività distante da quella del maschio dominante viene considerata una debolezza da nascondere, ed è affrontata con reazioni violente verso il sesso femminile.
Mentre le posizioni di vittima e carnefice ci risultano familiari, quella di Jeffrey richiede una riflessione ulteriore. Apparentemente inorridito dalle gesta dei malviventi che osserva, risulta tuttavia scisso nei suoi sentimenti per Dorothy. Dominato ora da un impulso sessuale ora da un sentimento di protezione, sfoga il conflitto in rapporti intimi violenti con un conseguente senso di colpa. Eppure, l’aspetto più interessante del personaggio sono i frequenti episodi di voyeurismo.
Nascosto dentro l’armadio nel salotto di Dorothy, osserva le violenze di Frank sulla donna. La telecamera salta dentro e fuori, senza mai avvicinarsi troppo ai personaggi, precludendo l’intimità con la loro realtà. Il buio è complice. Ci tiene lì, sulla soglia, proprio come Jeffrey. Così guardiamo Frank stabilire la narrazione, Dorothy piegarsi a renderla realtà, Jeffrey lasciare che accada.
Spiamo la scena con Jeffrey. Lo sguardo con cui osserva lo psicotico gangster violentare la cantante è il nostrosguardo. Al contempo, siamo anche un altro sguardo, che osserva Jeffrey nella sua incapacità di attraversare l’armadio e rompere la distanza tra la propria innocenza e la colpevole violenza davanti a lui. In poche parole: affrontare il male esterno incarnato da Frank e fare i conti con la parte di sé che vi somiglia.
Così, l’osservazione voyeuristica conduce Jeffrey a operare un distacco emotivo dalla scena – con l’armadio che è la soglia che lo separa dal male – e a trasformare Dorothy in semplice immagine, un corpo spoglio non solo degli abiti ma anche del proprio significato umano, degradato a spettacolo erotico confinato in uno schermo.
In questo senso il personaggio di Jeffrey svolge il ruolo di contesto: ci chiama in causa in quanto spettatori. Faccia a faccia con la violenza della realtà, è forte l’impulso a prendere rapidamente le distanze dal male e dal suo artefice, consolidando la sicurezza di non essere parte del problema. «Not all men», «Io non sono così»: un distanziamento spaziale ed emotivo che fugge il confronto etico. Non solo: all’interno della narrazione, il contesto è composto da Jeffrey ma anche da Sally, sua compagna di indagini e futura fidanzata. Insieme rappresentano le componenti della società oggi ancora non allineate: Sally agisce, mentre Jeffrey è passivo, legato a un’emotività fragile che gli impedisce la responsabilizzazione. Proprio qui si esplicita il concetto: la responsabilità sociale presuppone un’unità di intenti che renda superflui schieramenti di genere di qualsiasi tipo. È alla parte maschile che è chiesto un movimento, non per colpevolizzarsi, ma per rendersi partecipe nel processo di narrazione.
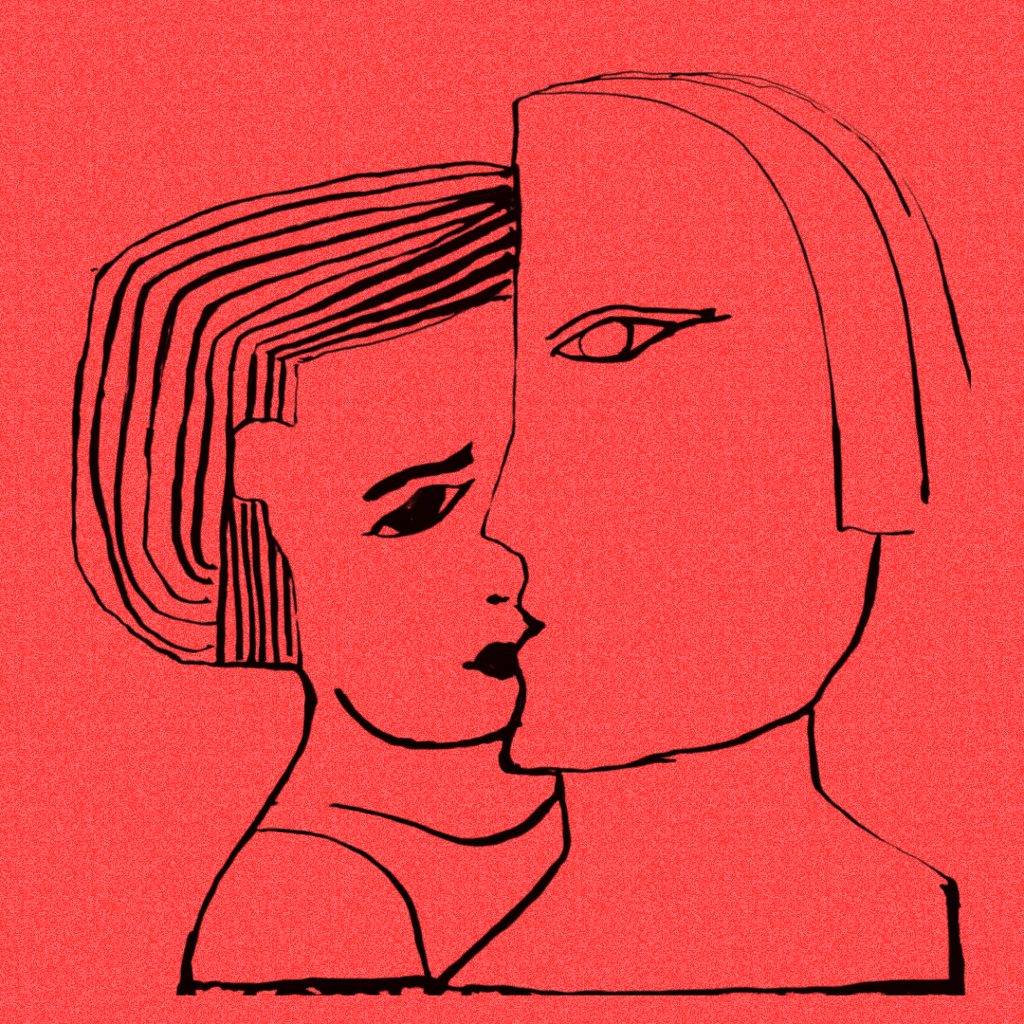
L’approccio collettivo parte dalla società, in cui l’informazione non è mai neutra: non esistono dati oggettivi, ma rielaborazioni più o meno consapevoli da parte degli individui. Rielaborazioni che compongono narrazioni, e narrazioni che a loro volta trasmettono valori e ideali, coinvolgono emotivamente, motivano nelle azioni, determinano cambiamenti. La narrativa che decidiamo di abbracciare plasma il mondo che abitiamo, perché plasma noi e di conseguenza il nostro agire. La narrazione consente di riconoscere e imporre un nome alle emozioni vissute, costruisce un vocabolario dei sentimenti e delle forme d’azione in cui questi si traducono.
Noi narriamo ogni giorno. Di continuo scegliamo che aspetto dare alla realtà legando le informazioni con le parole. Se l’informazione è il mattone e il cemento è la nostra mente, il muro che ne viene fuori è la narrazione. I muri dividono, separano, tagliano, feriscono. Con gli stessi mattoni, la narrazione ha il potere di costruire barriere o aprire piazze, di creare divisioni o unificare direzioni. Indagare le narrazioni a cui apparteniamo e individuarne il retaggio ci permette di prenderne distanza laddove necessario. Una narrazione inconsapevole, invece, è sempre una narrazione pericolosa. Blue Velvet lo mette in scena: la narrativa scelta da Frank, a cui Dorothy si sottomette e che Jeffrey tollera, diventa realtà. E in questo caso, realtà violenta.
Per questo motivo è più urgente che mai parlare di responsabilità non solo nei confronti dell’informazione, ma anche e soprattutto della narrazione. Responsabilità del narratore, sia nella veste di individuo, sia in quella collettiva. Troppo spesso infatti, il singolo si sente chiamato in causa in quanto mero spettatore, percependo un dovere alla partecipazione solo nella misura per cui deve, per così dire, essere al corrente. Guardare muti è diventata la prassi. Il voyeurismo ne è il risultato. Non trovando spazio per processare le proprie emozioni in merito ai fatti, l’individuo fugge il contatto con gli stessi e mette distanza tra sé e gli eventi. Rimane nell’armadio.
Blue Velvet potrebbe essere sintetizzato dalle parole di Laura Segato, intellettuale e scrittrice argentina. «Può esserci l’aggressione di uno psicopatico, ma il maggior numero di stupri e aggressioni sessuali sulle donne non sono fatte da psicopatici, ma da persone che sono in una società che pratica l’aggressione di genere in mille modi, che non possono mai essere riconosciuti come crimini».
La società attuale è terreno fertile per lo sbocciare della violenza come manifestazione di fenomeni ben più radicati. Una società in cui esistono mille modi di praticare un’aggressione e altrettanti per percepirla. In cui, ancora una volta, lavorare sulle dinamiche narrative significa creare realtà e creare la consapevolezza necessaria a colmare dei vuoti.
Dal vuoto ci allontaniamo, ci nascondiamo. Il finale di Blue Velvet, in cui la violenza è affrontata solo con altra violenza, riporta proprio all’apparenza beffarda dell’inizio. Le turbe e gli sfoghi di Jeffrey vengono repressi nell’amore tradizionale e ipocrita con Sandy. Uno scenario che mostra ancora una volta la necessità di un cambiamento, per non mantenere un sistema di narrazioni e gesti che alimenti costantemente il male. ♦︎