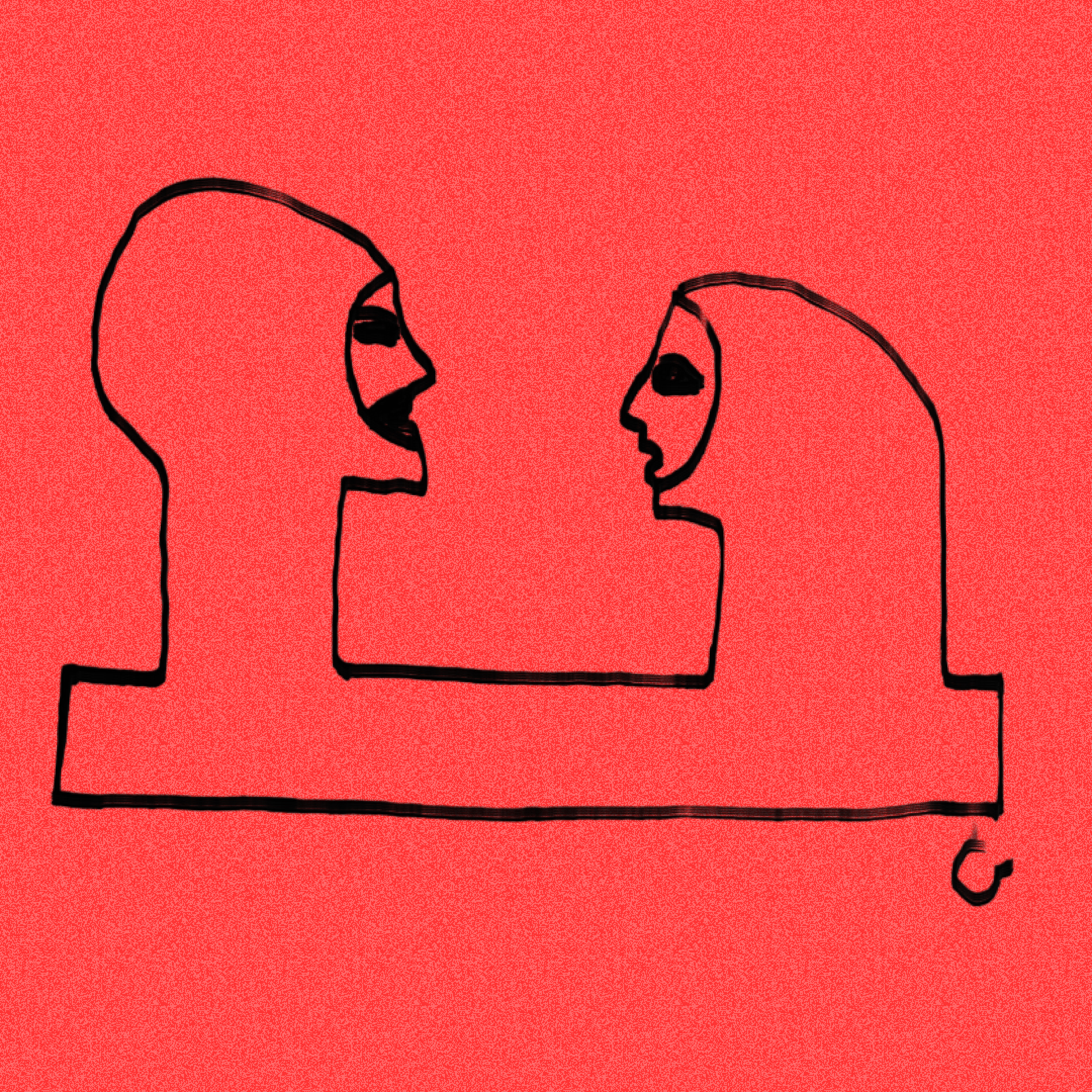La présence, diceva mia madre stringendo le scapole e allargando le braccia come nel movimento finale di una danza. I palmi rivolti all’insù e così anche il mento. La schiena drittissima. In un solo movimento apriva il petto e in qualche modo mi sembrava che, al mondo, stesse donando il cuore. Poi mi guardava negli occhi: «Hélène, la présence». Sorrideva. E io che volevo risponderle che non era quello il punto. Davanti a quel corpo, riportavo le vertebre in fila e prima che potessi parlare tutto era già cambiato. La présence lei non la nominava, la evocava. E come uno spirito aveva il potere di farla scendere sulla terra ogni volta che la sentiva mancare. E lei arrivava. Noi, che stavamo seduti attorno al tavolo, ormai con le spalle dritte, ci guardavamo – e ora che facciamo?
Era iniziato, per me, a dodici o tredici anni, quando mi sembrava che le spalle un po’ incurvate e il cappuccio avessero uno spazio da offrirmi. Mia madre arrivava da dietro e quattro dita sotto al collo mi toccava: stai dritta con le spalle. Con un tocco mi buttava fuori dal nascondiglio. Lì fuori certo faceva più freddo, ma c’era molta più vita. Il vento mi passava tra le giunture ma gli occhi si trovavano a guardare l’orizzonte e non il pavimento. C’è da dire che questa risposta non arrivava solo a me, ma a chiunque andasse da lei in cerca di un consiglio – non riesco in quello, sbaglio questo, chissà perché – la risposta era sempre una: la presenza.
La postura
C’è un esercizio che si fa a teatro: una persona del gruppo inizia a camminare per la stanza e uno a uno gli altri devono accodarsi assumendo la stessa andatura, senza estremizzarla, solamente cercando di riprodurla. Con sorpresa e in alcuni casi imbarazzo, ci si rende conto di rivelare molto di sé soltanto camminando. Nel teatro per creare un personaggio si parte sempre dalla postura e dalla camminata. L’interpretazione di un’identità passa prima di tutto dalla gestione del corpo. La consapevolezza della propria postura è condizione fondamentale per una buona presenza.
Innanzitutto la presenza ha a che fare con il corpo. Ha pochissimo di metafisico e moltissimo di corporeo. La si può trovare più facilmente in ‘come cammini’ rispetto a ‘quanto leggi’. La postura è comunicazione, prima di tutto verso di sé, poi verso gli altri. Qui sta la differenza della presenza. Essere nelle cose che si fanno. Abbracciarle con il proprio intento. Accettare che avere un corpo presuppone due elementi sempre più difficili da accettare oggi: occupare uno spazio e avere un peso.
Occupare uno spazio
Esistere implica occupare uno spazio. Si tratta di una vera e propria appropriazione, perché uno spazio viene sottratto al resto della realtà. Là dove sta il nostro corpo, nient’altro può esserci. Non è un caso che parlando di esistenza si dica ‘essere al mondo’. Non siamo in grado di pensarci senza inserirci in un mondo, in una realtà spazio-temporale che implica dell’Altro.
Etimologicamente, presenza viene dall’unione dei latini prae, davanti o innanzi,e ens, ente. Un ente che sta innanzi. Stare innanzi, stare davanti a qualcosa, ci riporta alla dimensione di io-nel-mondo, in mezzo ad Altro. C’è una differenza sostanziale tra pensare la presenza come un ‘essere lì’e concepirla come un ‘esserci’. Martin Heidegger, filosofo tedesco, ha condotto un’avventura esistenziale su questa distinzione. Non tutto ciò che ci sta innanzi, che è presente, si limita a occupare uno spazio. Occupare uno spazio significa esistere. Eppure c’è un modo d’essere che va oltre: parla di un rapporto con il mondo e rompe il concetto di occupazione in virtù di quello di relazione.
Esserci. Essere che ci-è, che è radicalmente un essere-con. La presenza richiama relazione, coscienza di un proprio io che dialoga con il mondo. È difficile capire lo scarto tra la ‘semplice’ presenza e la presenza dell’esserci senza aggiungere un’altra parola. Heidegger la colloca come parola originaria in virtù della quale è possibile pensare una reale presenza: cura.
In Essere e Tempo, sua opera principale, fa riferimento al saggio di K. Burdach, Faust e la Cura. Si tratta di una favola antica:
‘La Cura’, mentre stava attraversando il fiume scorse del fango cretoso; pensierosa ne raccolse un po’e incominciò a dargli forma. Mentre era intenta a stabilire che cosa avesse fatto, intervenne Giove. La ‘Cura’ lo pregò di infondere lo spirito a quello che aveva formato, Giove glielo proibì e pretese che fosse imposto il proprio. Mentre la ‘Cura’ e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che era stato formato fosse imposto il proprio nome, perché gli aveva dato una parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò loro la seguente equa decisione: Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito; tu, Terra, poiché hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fintanto che esso vivrà, lo possieda la Cura. Poiché la controversia riguarda il suo nome, si chiami homo poiché è fatto di humus (Terra).
Il tempo, Saturno, stabilisce che l’arco della vita appartiene alla cura, cura che chiede aiuto allo Spirito e alla Terra per mantenerel’uomo. E il mantenimento dell’uomo parla di una relazione con il mondo, di una dimensionalità relazionale che non può fare a meno dell’altro. L’essere-nel-mondo ha la sua struttura d’essere nella ‘Cura’. Prenderci cura della nostra presenza è una responsabilità verso noi stessi e verso l’alterità. È in quella relazione tra il nostro corpo e il corpo dell’Altro che scopriamo il nostro essere più proprio. Quell’essere per il quale ne va di noi, ed è dell’autenticità di quel contatto, della presenza vera di quella relazione, che si nutre il mondo.
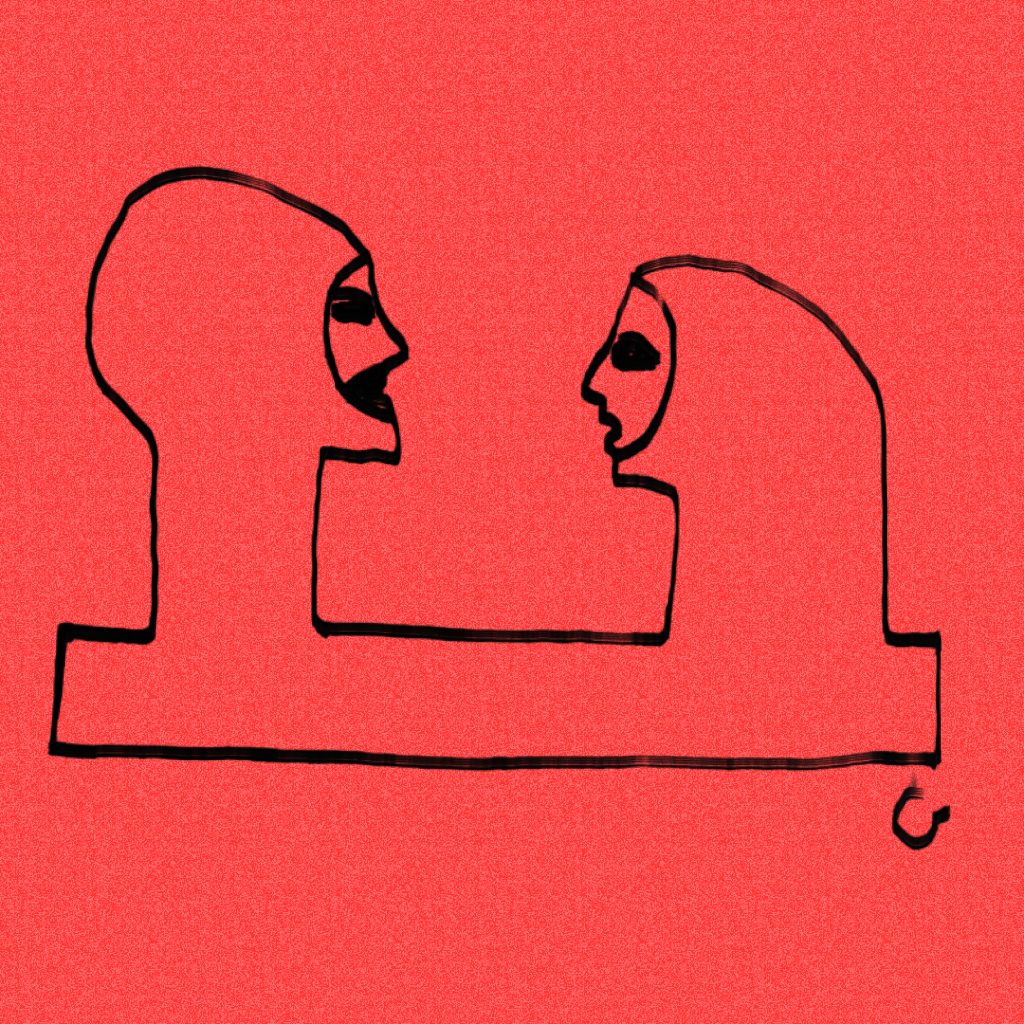
Avere un peso
Occupare uno spazio significa sottrarre una porzione della realtà. La consapevolezza di avere una fisicità, di esserci, però, non è soltanto un’esperienza individuale. Occupare uno spazio significa anche essere in relazione con un altro che occupa a sua volta una porzione. Diventa perciò importante prendere consapevolezza dello spazio che occupiamo e assumersi la responsabilità dell’apertura di quel possibile spazio. La questione è se possiamo restituire ciò che in un primo momento siamo costretti a sottrarre. Se vogliamo farlo, quando ci sentiamo di farlo.
Nell’osservazione della società di oggi si potrebbe ipotizzare che il corpo sia addirittura sacralizzato. Le prove ci circondano ogni giorno: dall’inevitabile abbonamento in palestra ai prodotti di cura del corpo, passando ovviamente per i social, che testimoniano l’importanza dell’attenzione e dell’ostentazione del proprio corpo. Sembra evidente quanto il corpo sia centrale per la nostra cultura e che la sua cura e la sua esaltazione siano elementi basilari della nostra società. Eppure, indagando questo rapporto, emerge una contraddizione: l’era della maggiore espressione del corpo è anche l’era del digitale, in cui la presenza è esclusa. La nostra società si costruisce su una virtualizzazione degli individui e dei rapporti, e quindi sull’abbandono del corpo fisico in favore di quello rappresentato, del corpo apparente.
Quelle odierne sono generazioni che vivono in maniera distaccata il corpo, che spesso lo percepiscono come un disagio o un motivo di vergogna, ma al contempo lo esigono perfetto. Sembra che mostrare il proprio corpo sia divenuto centrale, ma viverlo è ancor più sconosciuto. In sintesi: vogliamo che i nostri corpi siano visti, ma non vogliamo abitarli.
Come è possibile una simile frattura? Come si può predicare il corpo come massima aspirazione e al contempo praticarne l’abbandono? La risposta è proprio nella presenza, o in un apparente nonsense: l’assenza di presenza. Smettere di abitare il corpo significa relegarlo a simbolo. La dimensione simbolica del corpo sopravvive, poiché capace di collocarsi nel sistema di consumo, apparenza e mercificazione: rimane del corpo la sua rappresentazione. Abbandonare il corpo significa escludere il pensiero e la consapevolezza di occupare uno spazio, di avere un peso e una maturazione, dei cambiamenti, della malattia, persino della morte. La dimensione del corpo in quanto presenza è esclusa dal nostro quotidiano. Il motivo è proprio nel valore della presenza, per cui il corpo assume una dimensione politica.
In questo senso risuona il pensiero di Pier Paolo Pasolini, talmente attuale da suggerire che forse la nostra sia l’epoca in cui i suoi timori si sono realizzati. Per Pasolini, il corpo è una forma di poesia, la più immediata delle arti, la più diretta espressione della nostra umanità, ma anche il mezzo attraverso il quale possiamo entrare in contatto con il resto del mondo. In questa visione il corpo e la presenza diventano perciò strumenti politici fortissimi: la storia, in ogni suo capitolo, ha mostrato come l’autorità viva l’appropriazione della dimensione corporea da parte della collettività come un pericolo, una minaccia. La conseguenza immediata è la nascita di pratiche di sottomissione del corpo, che ne limitino la libertà e la personalità, definendo una ristretta gamma di comportamenti e proprietà concesse. Nel caso dei regimi, il controllo sul corpo era contraddistinto da sottomissioni dirette e impositive, sia nella gestione interna, con un sistema di punizioni e divieti attivo tra i propri membri, sia nei confronti del nemico e del dissidente, con l’aggiunta in questo caso della repressione violenta e la prigionia. Il presente invece ricalca ancora di più le profezie pasoliniane, con una sottomissione del corpo che, diventata invisibile, ha preso la forma di educazione.
In ogni momento, il condizionamento è al distaccamento dal proprio corpo: il corpo è immagine da rafforzare, da curare e perfezionare, da fotografare e diffondere sui social, ma è alieno dall’identità collettiva e individuale. Il risultato è un essere umano disarmato, che non può ribellarsi perché non si accorge della trappola: glorifica il corpo e intanto se ne imbarazza, lo disprezza, lo abbandona. L’autorità ha svuotato il corpo da ogni significato e l’ha reso mero simbolo da produrre e diffondere nei propri canali. Un corpo docile, secondo Pasolini, innocuo, perché solo involucro svuotato della sua presenza. ♦︎
Non conosciamo mai la nostra altezza
finché non siamo chiamati ad alzarci.
E se siamo fedeli al nostro compito
arriva al cielo la nostra statura.
L’eroismo che allora recitiamo
sarebbe quotidiano, se noi stessi
non c’incurvassimo di cubiti
per la paura di essere dei re.
Emily Dickinson
Moth è un collettivo di artisti nato a Torino nella primavera del 2023 ispirato alla poetica della falena. Attraverso la produzione artistica e l’organizzazione di eventi, Moth si pone l’intento di riportare l’arte e la bellezza a una dimensione quotidiana.