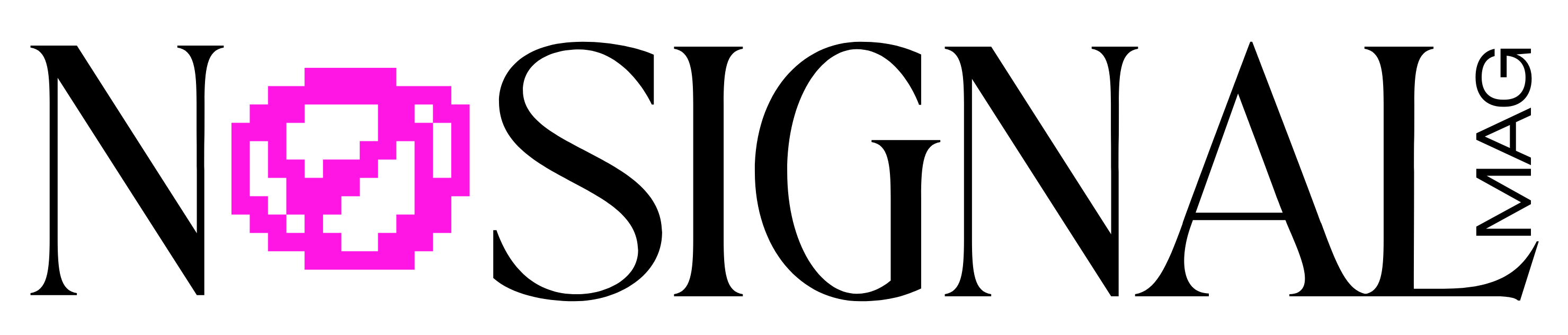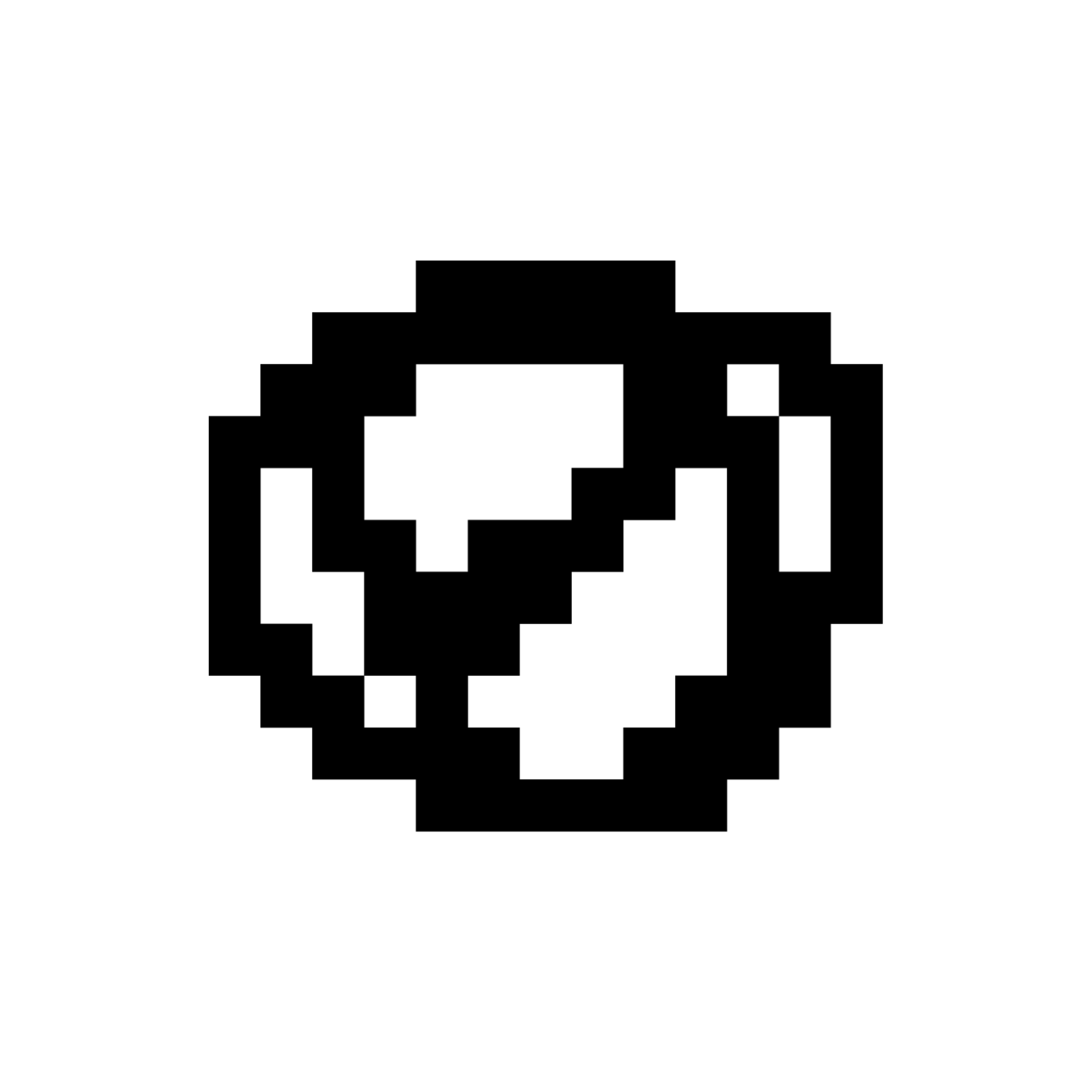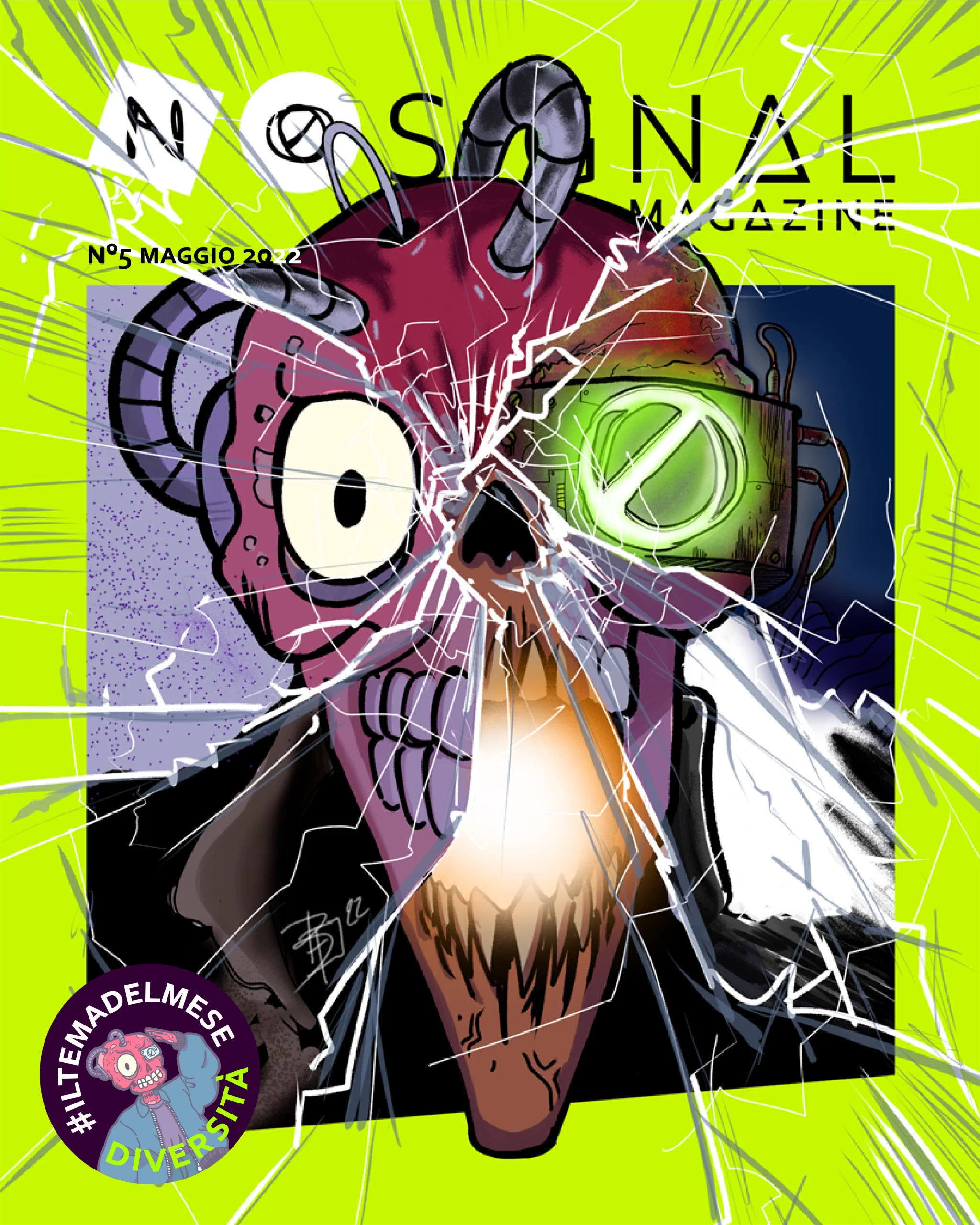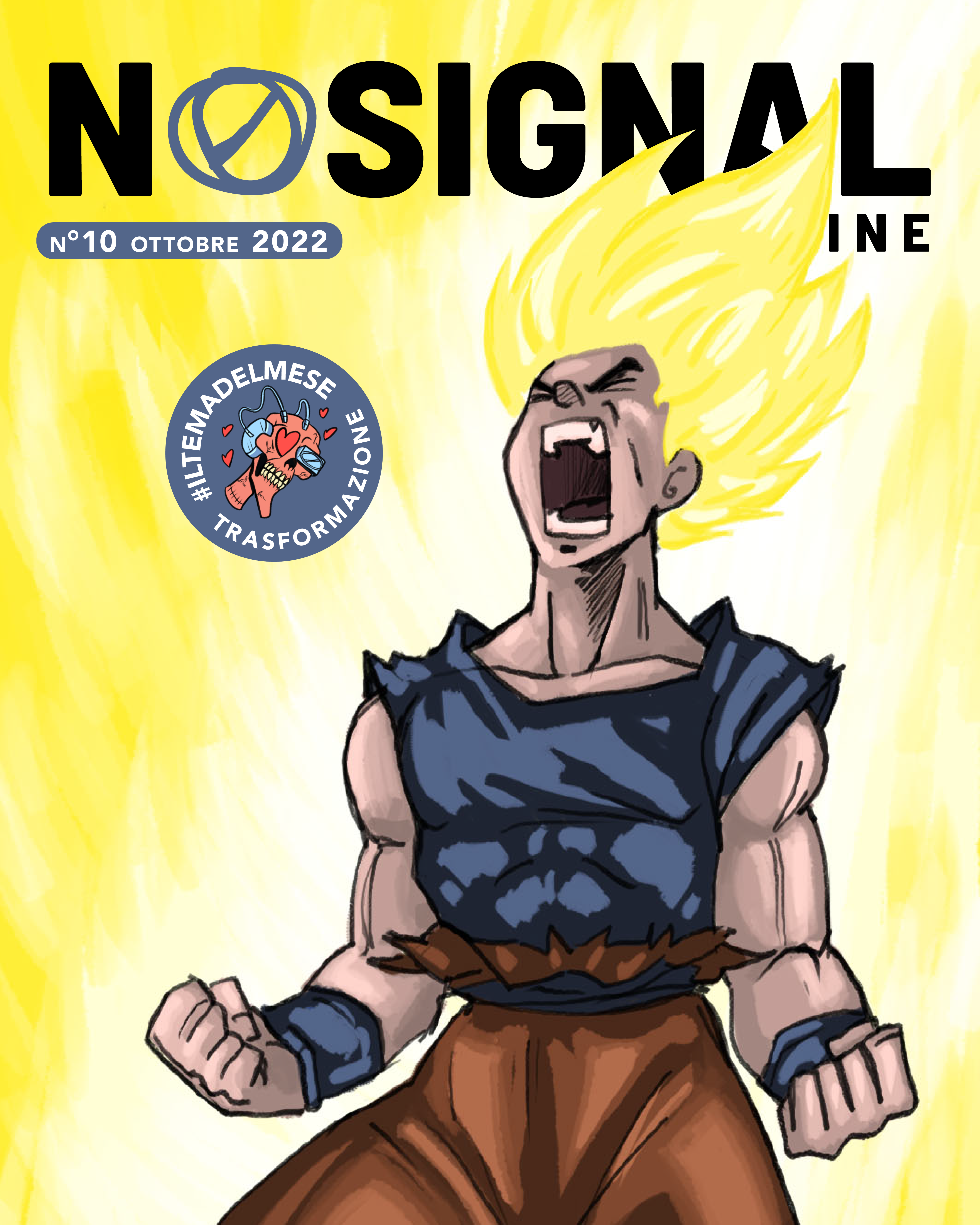Secondo Carl Gustav Jung, padre della psicologia analitica, ciascuno di noi ha dentro di sé un lato d’ombra nel quale relegare gli aspetti della propria personalità che detesta, che vuole nascondere al mondo esterno, nel tentativo, vano, di sopprimerli una volta per tutte. Ma proprio perché parte di noi, anche le caratteristiche che più odiamo sono impossibili da estirpare. Restano lì, latenti, in qualche angolo remoto del nostro essere. Col rischio che emergano quando meno ce lo aspettiamo, cogliendoci di sorpresa e finendo per costringerci a mostrare il lato peggiore di noi stessi.
Il pensiero di Jung si contrappone a quello freudiano, che teorizza il concetto di doppia personalità, dimostrando come luci e ombre siano indissolubilmente legate. L’ombra, del resto, esiste solo laddove c’è una luce che la proietta. Sempre Jung sosteneva inoltre che tendiamo a proiettare le nostre ombre sugli altri altri, ritenendo noi stessi pura luce, immacolati. In questo modo siamo spinti a odiare l’altro e a ignorare ancora di più l’ombra che risiede in noi, con la spiacevole conseguenza che quando si manifesta siamo incapaci di controllarla e ne veniamo doppiamente traumatizzati. Solo riconoscendo che in ognuno di noi esiste e persiste un lato negativo, diceva Jung, solo imparando a conoscere le nostre ombre possiamo controllarle, impedendo loro di palesarsi all’improvviso.
L’evoluzione del concetto di linea d’ombra
La linea d’ombra, teorizzata da Conrad e cantata da Jovanotti, rappresenta un momento cruciale dell’esistenza umana, un limite ben preciso in cui l’adolescenza sfuma nella maturità, l’illusione lascia spazio alla consapevolezza. Sebbene il passaggio dipenda inevitabilmente da esperienze individuali, questa soglia appare come un obiettivo definito, un confine chiaro che ci consente di comprendere quando lo abbiamo finalmente attraversato.
Eppure, nella società contemporanea, questa linea d’ombra sembra essersi dissolta in una meta evanescente, mutevole e sfuggente. Accade così che, nel momento in cui crediamo di averla superata definitivamente, ci scopriamo inaspettatamente indietro, nuovamente oltre quel confine che pensavamo ormai lontano alle nostre spalle. Viviamo infatti in un mondo che corre a una velocità inaudita rispetto al passato, costringendo le persone a confrontarsi con esperienze che diventano rapidamente obsolete e generano ansia, incertezza e instabilità. Siamo bombardati quotidianamente da una valanga incessante di notizie, incapaci di distinguere con chiarezza ciò che conta davvero, travolti da una frenesia che ci lascia sempre più disorientati.
I giovani di oggi vivono i passaggi cruciali dell’esistenza, quelli che tradizionalmente segnano l’ingresso nell’età adulta, molto prima dei loro genitori e nonni, spesso privi della maturità necessaria per comprenderne pienamente il significato. Il risultato è che, superando soltanto in apparenza la linea d’ombra, questi ragazzi rischiano di sentirsi adulti solo esteriormente, restando invece fragili bambini al loro interno, sempre più smarriti e vulnerabili davanti alle sfide della vita. Persino da adulti si continua a vivere con una perenne sensazione di inadeguatezza, come bambini alle prese con qualcosa di più grande di loro. Specialmente in ambito lavorativo, dove in passato la crescita professionale poteva essere scandita da tappe precise e ben definite, oggi si è costretti a convivere con un senso perenne di instabilità, schiacciati dalla pressione costante del cambiamento tecnologico che rende rapidamente obsolete conoscenze appena acquisite. La linea d’ombra appare così continuamente irraggiungibile, sempre lontana, sempre al di là della nostra portata.
Anche sul lavoro dominano ormai velocità e frenesia, in un eterno passaggio da un’attività all’altra che lascia l’individuo in balìa della paura di non riuscire a tenere il passo, di essere inadeguato, incapace di soddisfare le richieste, fino a cadere nel burn-out o perdere improvvisamente tutto ciò che si è costruito con tanta fatica. Così, la linea d’ombra resta sospesa, indefinita, a ricordarci costantemente che forse non smettiamo mai davvero di inseguirla.
La FOMO
Un’altra sindrome, insidiosa e sempre più diffusa, si è insinuata lentamente nel tessuto della società contemporanea: la paura angosciante di non essere sufficientemente aggiornati, di non stare al passo con ciò che accade intorno a noi, di perderci pezzi fondamentali della realtà vissuta dagli altri.
Questa fobia, meglio nota come FOMO (Fear of Missing Out), non rappresenta in fondo una novità assoluta dei nostri giorni: da sempre l’uomo teme di restare escluso dagli eventi sociali, dai momenti di divertimento, dalle esperienze condivise. Tuttavia, l’avvento dei social media ha amplificato enormemente tale paura, trasformandola in una vera e propria ossessione. Oggi non si tratta soltanto del timore di perdere un evento a cui tutti partecipano, ma si è allargata fino a diventare una continua ansia di lasciarsi sfuggire anche la più insignificante notizia riguardante persone e profili che seguiamo, fino a degenerare nel terrore di rimanere esclusi persino dai principali eventi globali.
Si finisce così per consumare compulsivamente notizie, scorrendo senza sosta gli schermi dei nostri smartphone in quello che è ormai tristemente noto come scrolling: una pratica frenetica, superficiale, che ci porta a saltare da una fonte all’altra senza approfondire realmente nulla. Il risultato paradossale di questo comportamento è che, anziché sentirci più informati, finiamo per accettare passivamente la prima versione che ci capita sotto gli occhi, vittime inconsapevoli delle fake news. E proprio così, nel tentativo disperato di essere onniscienti, ci ritroviamo ancora più frustrati e confusi, costretti infine a prendere atto della nostra profonda e inevitabile ignoranza.
L’ombra nella cultura orientale
Volgendo lo sguardo verso Oriente e alla sua cultura millenaria, da sempre incline alla meditazione e all’introspezione, possiamo scoprire un approccio differente, più affine al pensiero di Jung, nella maniera di considerare il lato oscuro, quell’ombra che si cela in ciascuno di noi.
In Oriente, infatti, la coesistenza di luce e ombra è un concetto fondamentale, radicato profondamente nella filosofia e incarnato alla perfezione dal principio dello Yin e dello Yang: due energie opposte e complementari, separate eppure inseparabili, ciascuna indispensabile all’esistenza dell’altra. E se lo Yang è rappresentato dalla luce, dal bianco, e lo Yin dall’oscurità, dal nero, quest’ultimo non è percepito come male assoluto, ma semplicemente come una parte integrante e irrinunciabile della realtà. Tale principio attraversa trasversalmente non solo il taoismo e la religione cinese, ma influenza profondamente anche le arti marziali, la medicina tradizionale e persino alcune discipline scientifiche orientali.
In Oriente le persone sono abituate da secoli a muoversi con un ritmo più pacato, a fermarsi per riflettere, a cercare una perfezione fatta di piccoli gesti e consapevolezza. Da questa lentezza meditativa deriva la naturale propensione verso uno sguardo interiore, capace di esplorare in profondità il proprio io, riconoscendone virtù e limiti, luci e ombre. Una cultura che insegna a conoscere, accogliere e convivere serenamente con il lato oscuro presente in ognuno di noi.
Shadow work e Jomo: quando l’ombra può esserci d’aiuto
Malgrado le premesse e le difficoltà fin qui evidenziate, la stessa società contemporanea è in grado di offrire alcune strategie utili affinché la linea d’ombra non diventi inevitabilmente fonte di ansie, fobie e insicurezze.
Una di queste è rappresentata dallo Shadow Work — letteralmente “lavoro sull’ombra” — una pratica introspettiva profondamente ispirata alle tecniche meditative proprie della cultura orientale. Tecniche che, grazie a una crescente apertura dell’Occidente verso filosofie, costumi e tradizioni di altre società, hanno trovato terreno fertile anche nelle nostre realtà. Attraverso lo Shadow Work, la persona è invitata a scavare nel proprio inconscio, esplorando con attenzione quelle caratteristiche che abitualmente relega nel buio, considerate difetti o debolezze, al fine di conoscerle, comprenderle e infine accettarle sotto la guida attenta di insegnanti esperti. L’obiettivo finale di questo percorso introspettivo non è soltanto l’accettazione pacifica del proprio lato oscuro, ma la consapevolezza del suo potenziale nascosto. Spesso, infatti, proprio nella nostra ombra interiore risiedono talenti creativi inespressi, impulsi artistici, istinti intuitivi e competitivi che la società considera eccessivi o poco accettabili, ma che rappresentano in realtà risorse preziose, capaci di arricchire profondamente la nostra esistenza.
Un altro rimedio interessante si presenta invece sotto forma di JOMO — la Joy of Missing Out — fenomeno nato proprio in risposta alla dilagante FOMO e in aperta contrapposizione ad essa. La JOMO rappresenta una riscoperta gioiosa della propria vita, una serena accettazione del quotidiano che si è scelto, senza struggersi costantemente confrontandosi con le vite degli altri. Consiste, dunque, nella capacità liberatoria di allontanarsi periodicamente dai social, di staccarsi dal vortice di informazioni per vivere autenticamente il presente, recuperando l’importanza del ‘qui e ora’. Rispetto alla FOMO, la JOMO appare infatti più direttamente connessa al fenomeno contemporaneo dell’iperconnessione, a quella pioggia incessante di notifiche, messaggi e notizie che ci travolge quotidianamente. Si manifesta nel momento in cui sentiamo il bisogno profondo di disconnetterci momentaneamente dal rumore esterno, per ritrovare spazi di silenzio e momenti di calma dedicati esclusivamente a noi stessi. Non si tratta, naturalmente, di un totale distacco dal mondo circostante, ma piuttosto di un utilizzo più consapevole e moderato dei social, volto a ristabilire equilibrio e serenità.
Pur non rappresentando cure scientificamente validate, sia lo Shadow Work che la JOMO costituiscono senza dubbio due approcci efficaci per riflettere più attentamente su se stessi, conoscersi con maggiore profondità e consapevolezza, riscoprendo che, indipendentemente da quale lato della linea d’ombra ci troviamo, ci sono momenti in cui è fondamentale fermarsi, riprendere fiato e lasciare spazio alla riflessione. ♦︎