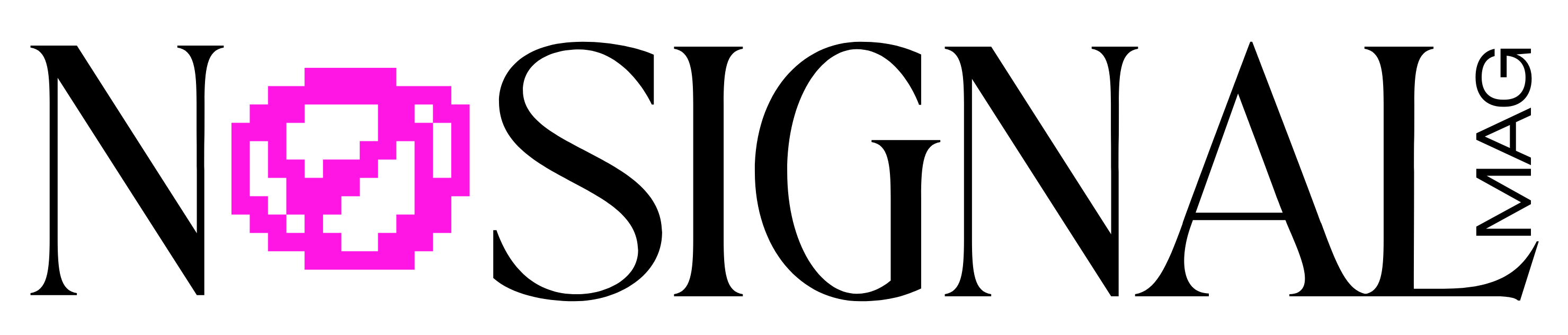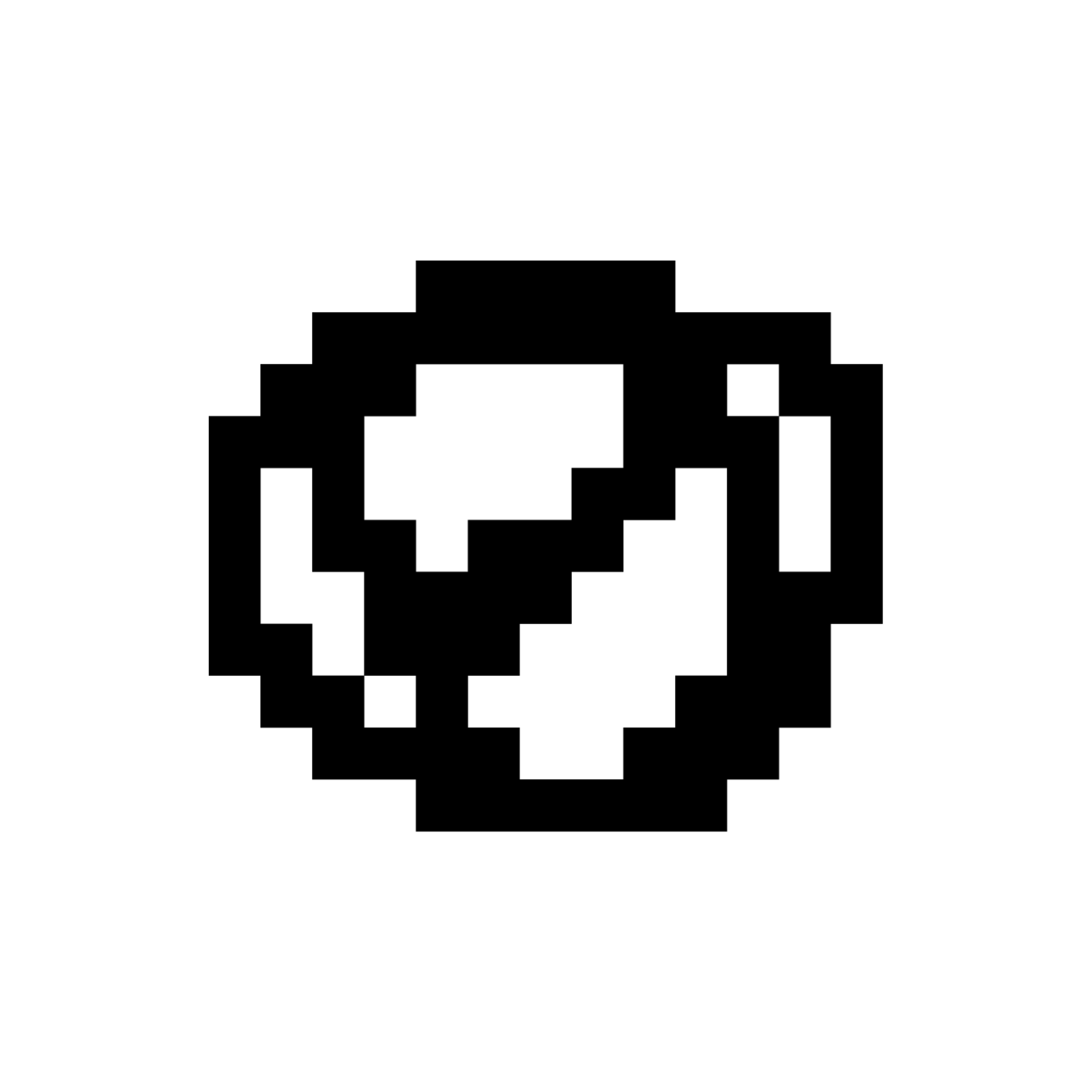Dalla biodiversità minacciata ai lavoratori intossicati: il prezzo nascosto delle nostre primavere silenziose.
“Parallelamente all’eventualità della totale estinzione del genere umano in una guerra atomica, l’altro fondamentale problema della nostra epoca consiste, dunque, nella contaminazione dell’ambiente in cui viviamo ad opera di sostanze con un potenziale di devastazione – sostanze che si accumulano nei tessuti delle piante e degli animali e penetrano anche nelle cellule germinali per distruggere o alterare i fattori dai quali dipende l’eredità e, in ultima istanza, la sorte stessa dell’umanità.”
Scriveva queste parole Rachel Carson, biologa e zoologa statunitense, nel 1962, descrivendo nel suo libro in modo diretto e preciso l’impatto dei pesticidi, già così dannosi da aver decimato gran parte degli uccelli locali, cancellando quindi il caratteristico suono che annunciava la primavera.
Leggere le sue parole nel 2025 fa impressione: la denuncia di oltre 60 anni fa è ancora drammaticamente attuale. Oggi molte regolamentazioni sono state attuate e alcuni pesticidi banditi, ma il suono delle nostre primavere risente ancora dell’uso smodato di questi input chimici. Il termine “pesticidi” fa riferimento alle sostanze chimiche “impiegate per combattere o controllare (etimologicamente, ‘per uccidere’) gli organismi nocivi (pests), che non debbono necessariamente essere parassiti, ma che possono essere vettori di malattie, organismi dannosi alle derrate, infestanti, ecc.”. Questa parola include, ad esempio, gli erbicidi e i diserbanti, gli insetticidi, i rodenticidi, gli anticrittogamici (soprattutto fungicidi), i nematocidi e gli acaricidi. Molti di questi sono entrati nell’uso agricolo in seguito allo sviluppo di armi belliche come i gas nervini, composti altamente tossici che inibiscono un enzima cruciale per la trasmissione dei segnali nervosi.
“L’uomo, a mano mano che procede verso i suoi conclamati obiettivi di conquista della natura, lascia dietro di sé una spaventosa scia di distruzioni dirette non soltanto verso la terra, ma anche verso gli esseri viventi che vi abitano assieme a lui.”
Rachel Carson continua così, evidenziando un tassello che spesso manca oppure è marginale nella narrazione sull’impatto dei pesticidi: il problema non è legato al potenziale effetto sulla salute attraverso il consumo di un frutto colto da un albero irrorato di insetticidi o di un ortaggio nato in un campo trattato con erbicidi. Infatti, se da un lato l’EFSA (l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare) nel suo ultimo Rapporto Annuale ha confermato l’ottima notizia che il 98% degli alimenti che ha campionato è nei limiti dei livelli massimi di residui di pesticidi in conformità con la legislazione europea, dall’altro possiamo comunque essere esposti agli effetti dell’uso diffuso di questi prodotti. Conseguenze che non si limitano all’insetto target o alla pianta infestante, ma rimangono intrappolate nel suolo anche per decine di anni, penetrano nelle falde acquifere e avvelenano i corsi d’acqua, silenziando anche gli animali marini. Inoltre, un eccessivo utilizzo di input di nutrienti nei campi, una volta raggiunti i corsi d’acqua, può causare ad esempio una crescita eccessiva di piante e alghe, riducendo l’ossigeno e con conseguente mortalità per la fauna ittica.
Decine e decine di studi testimoniano gli effetti dei pesticidi sulla biodiversità del suolo severamente ridotta, compromettendo la vita di migliaia di organismi che ne garantiscono fertilità. Hanno un grave impatto anche sui volatili: quasi la metà delle specie di uccelli è in declino, e le popolazioni sono diminuite di tre miliardi di individui nel corso degli ultimi 50 anni solo in Nord America ed Europa, dove negli ambienti agricoli sono diminuite del 57%. Alcuni prodotti chimici sono stati vietati nel corso degli anni, ma sono stati sostituiti da generazioni successive di nuovi composti, molti dei quali ancora più tossici per gli insetti. Un esempio su tutti sono gli insetticidi neonicotinoidi, introdotti negli anni ‘90 e ora tra i più utilizzati, con comprovate conseguenze fatali sugli insetti impollinatori, come le api.
Le primavere non hanno solo perso i suoni della fauna locale: i pesticidi silenziano anche l’essere umano, spesso succube di distorsioni delle filiere alimentari che lo costringono a condizioni lavorative precarie, sprovvisto di corrette precauzioni. Come riportato dal Pesticide Atlas, molteplici studi dimostrano un incremento nell’avvelenamento causato da pesticidi, la cui maggior parte si concentra in Africa, nell’Asia Nord Occidentale e in Sud America. L’avvelenamento colpisce il 44% dei braccianti agricoli in tutto il mondo, arrivando a picchi come l’83% dei lavoratori agricoli in Burkina Faso.
A questo riguardo, un’inchiesta di Sara Manisera per Irpimedia denuncia il gusto amaro della frutta esotica importata in Europa: in Costa Rica (terzo paese esportatore di banane, dove sono coltivati due ananas su tre venduti al mondo) la coltivazione avviene con pratiche agricole intensive e l’utilizzo di pesticidi proibiti in Europa. La loro nebulizzazione su campi vicini alla popolazione ha causato gravi episodi di intossicazione, e studi epidemiologici evidenziano come l’esposizione a pesticidi sia causa di alterazione degli ormoni tiroidei e potenziali danni al sistema nervoso e allo sviluppo fetale. La stessa situazione è testimoniata in Brasile, dove 7 dei 10 pesticidi più venduti sono banditi in Unione Europea, sede delle principali aziende agrochimiche che li producono. Gran parte dei pesticidi utilizzati in Brasile è destinato ad immense aree coltivate a foraggio per gli animali e per la produzione di etanolo, trainati dalla domanda dell’Europa.
Per questo l’utilizzo smodato di pesticidi è considerato una manifestazione di chemical colonialism, come racconta Larissa Bombardi nel libro “Agrotóxicos e Colonialismo Químico”, che perpetua violenza e ingiustizia, avvelenando comunità, scuole e famiglie, e silenziando anche chi cerca di opporsi a queste pratiche. La Permanent Campaign Against Pesticides and For Life ha infatti denunciato che i pesticidi sono delle armi chimiche che l’agribusiness usa contro la popolazione contadina e le comunità indigene.
“Se un grosso teschio ed un paio di ossa incrociate venissero appesi nel reparto in cui si vendono gli insetticidi, l’eventuale acquirente proverebbe almeno quella naturale circospezione che desta ogni pozione apportatrice di morte; invece troviamo questi prodotti disposti familiarmente e allegramente in file sopra file, tra vasetti di olive o di sottaceti, in mezzo a saponette da bagno o a sapone da bucato.”
Quando Rachel Carson scriveva, uno dei best-selling pesticide negli Stati Uniti non era ancora commercializzato: il glifosato, un erbicida brevettato dalla Bayer nel 1971 e dichiarato probabilmente cancerogeno dall’OMS nel 2015. La Bayer (che nel 2018 ha acquisto anche la multinazionale Monsanto) sta fronteggiando oltre 100.000 cause legali per i danni che il suo “round-up”, l’erbicida a base di glifosato in vendita anche nei supermercati, ha causato in migliaia di persone, come il linfoma non-Hodgkin, dichiarato direttamente correlato alla contaminazione da round-up.
Ricerche dimostrano che il glifosato può anche essere trasmesso dal foraggio al letame degli animali che lo consumano, che può a sua volta compromettere la crescita del campo fertilizzato per l’anno seguente. E non si tratta solo di cibo: un’indagine del Pesticide Action Network UK ha rilevato livelli di glifosato negli assorbenti interni in cotone 40 volte maggiori dei livelli permessi nell’acqua potabile, e uno studio pubblicato a Maggio ha riscontrato il ruolo dei pesticidi applicati ai campi da golf nell’incidenza del Morbo di Parkinson’s per i residenti nelle vicinanze.
“si tratta di stabilire se una civiltà può muovere una guerra incessante alla vita senza distruggere sé stessa e senza perdere il diritto di chiamarsi civile. Questi insetticidi non sono veleni selettivi, e non colpiscono soltanto le singole specie a cui li destiniamo. Ciascuno di essi viene usato per la semplice ragione che ha un potere mortale, e perciò avvelena tutti i viventi con cui viene in contatto: il vezzeggiato gattino domestico, i buoi dell’allevatore, il coniglio nei campi e l’allodola che volteggia nel cielo. (…) Chi di noi, messo a conoscenza di azioni che possono causare tali sofferenze ad una creatura vivente, non sente diminuita la propria dignità di uomo?”
Rachel Carson poneva questa domanda nel 1962, ma è ancora attuale quanto allora. Risulta difficile immaginare una primavera silenziosa oggi, nel privilegio di un cielo senza bombe: immersi in un costante ronzio tecnologico o nel rombo del traffico urbano, con un flusso di canzoni trend del momento come colonna sonora e video che ci tengono compagnia, non ci fermiamo a chiederci quali suoni della natura abbiamo sacrificato. Cosa penserebbe Rachel Carson della nostra primavera rumorosa? ♦︎