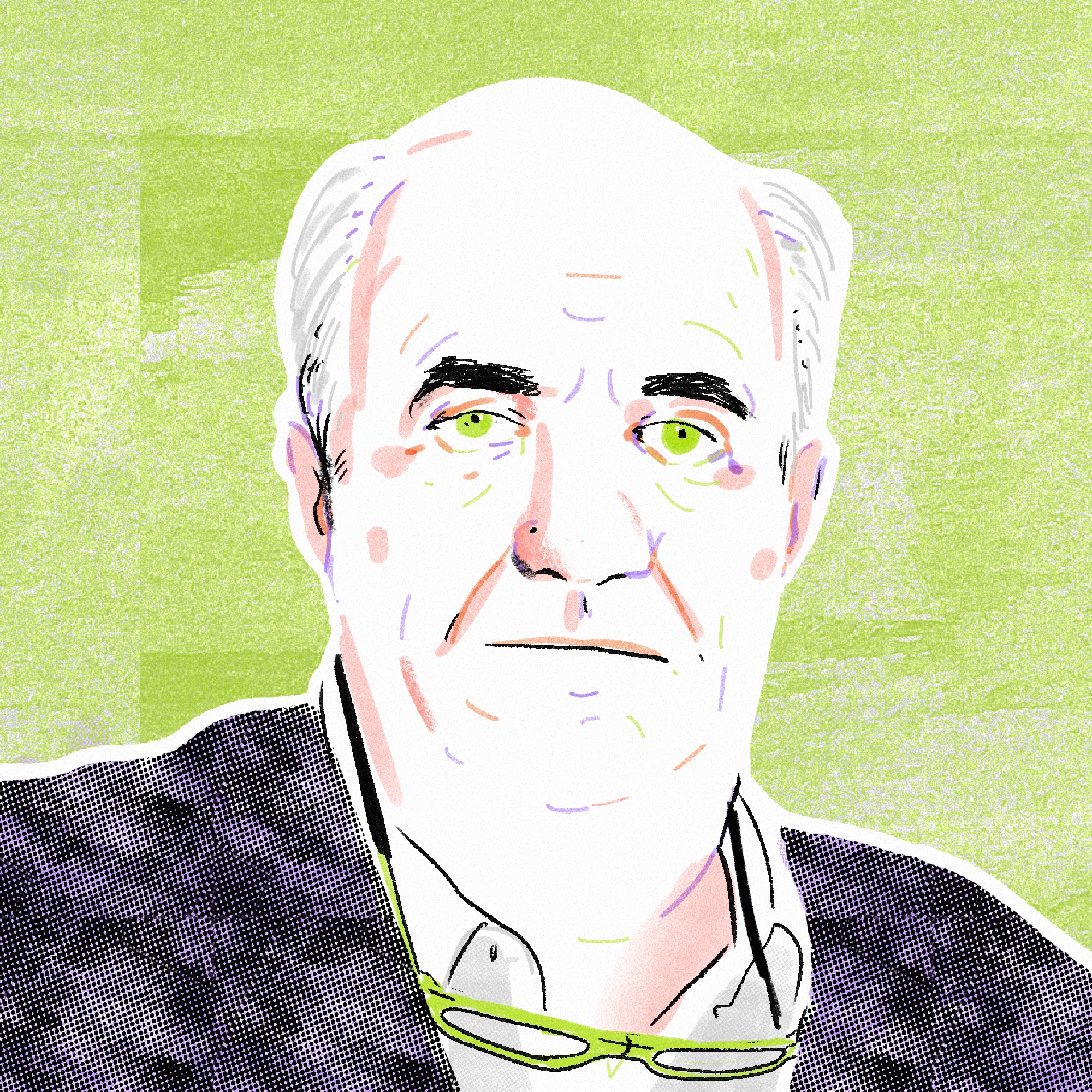Ritratto di Colm Tóibín
Appena arriviamo gli passiamo accanto. È all’ingresso di Palazzo Castiglioni, la spalla destra appoggiata allo stipite del portale, lo sguardo fisso di fronte a sé e le braccia incrociate al petto. In un inglese masticato, il fotografo gli sta chiedendo di spostarsi un po’ più in là, because of the light. Lui esegue gli ordini, ma prima ancora di aver mosso un passo l’uomo ha ricominciato a scattare come un pistolero impazzito. Lui non sembra scocciato, ma la linea piatta e fine delle sue labbra mi intimorisce. C’è chi pensa ancora che i sorrisi siano sinonimo di buonumore. Non io, nemmeno il fotografo, che sembra entusiasta di quello sguardo serio e integerrimo, di quella posa statuaria da copertina.
Io e Alessandro siamo in anticipo, dobbiamo scegliere il punto migliore per riprendere l’intervista. For the light, anche noi. Sbuchiamo in una piccola corte dall’erba rasata, disseminata di tavolini e sedie bianche ombreggiati da ampi ombrelloni. Qui gli autori ospiti a Festivaletteratura vengono a ritirare gli accrediti e a prendere un caffè, ristorarsi, lontani dalla calca di visitatori. Ispezioniamo il cortile, scegliamo un tavolo a ridosso di una siepe di lauro. «Lo mettiamo qui», dico mentre lo immagino parlare su quello sfondo di foglie scure. Lui riappare, il fotografo-pistolero alle calcagna. Gli sta indicando un muro, poi cambia idea, prende una sedia e gli fa cenno di accomodarsi. Lui obbedisce, si siede con calma, accavalla la gamba, ci ripensa, la inverte.
Intanto abbiamo provato il microfono. È a posto, anche the light is good, non rimane che aspettare. Da noi lo scorta il suo ufficio stampa italiano, just few questions, abbiamo mezz’ora. A ognuno stringe la mano, noi ne usiamo una, lui entrambe. Una presa salda ma che non stritola, diversa da chi fa a gara a spezzarti le ossa della mano per ostentare sicurezza. La sua me ne infonde più di molte altre che mi hanno lasciato le dita indolenzite. Continua a non sorridere, ma il suo tono di voce è cordiale, aspetta indicazioni anche da noi.
Il suo nome si pronuncia Collum, si scrive Colm. Saprebbe leggerlo correttamente solo chi a scuola ha studiato il gaelico, e io quel poco che sapevo ormai l’ho dimenticato. Ha gli occhi grigi striati di un verde antico, rimasuglio di anni più giovani. Sono loro, assieme alla testa che reclina leggermente quando ascolta le domande, gli occhiali rossi e squadrati incastrati al colletto della camicia azzurra, le sopracciglia brizzolate e ispide come i capelli radi, le orecchie dai lobi carnosi, a ricordarmi un bracco anziano. Placido e solido, cammina lento e coglie ogni rumore, guardandosi attorno per vegliare su chi lo circonda. Il suo accento mi è familiare, lo capisco senza difficoltà. Undici anni fa aveva contaminato anche il mio, parlavo as a pot of boiling beans.
Quando la Scuola Holden mi ha chiesto di leggere uno dei romanzi per il book club di Festivaletteratura, trovare l’ultimo libro di Colm Tóibín è stata una sorpresa. «Lui è mio», ho detto. Adesso che è qui di fronte a me, in lui rivedo la terra dove ho vissuto. Gli uomini seduti sul lungomare di Dingle, con stivali di gomma e giacche a vento marroni e rosso borgogna, pelli chiare come schiuma di mare, i bastoni ricurvi che battono sull’asfalto. Le auto che si sorpassano senza regole su statali strette, la pioggia grigia e fina durante le partite di gaelic football, il rumore della forchetta che amalgama il burro alle mashed potatoes.
Ha gli occhi grigi striati di un verde antico, rimasuglio di anni più giovani. Sono loro, assieme alla testa che reclina leggermente quando ascolta le domande, gli occhiali rossi e squadrati incastrati al colletto della camicia azzurra, le sopracciglia brizzolate e ispide come i capelli radi, le orecchie dai lobi carnosi, a ricordarmi un bracco anziano.
Al liceo il programma del corso di inglese prevedeva la lettura di un romanzo irlandese contemporaneo; quell’anno era proprio Brooklyn, uno dei bestseller di Colm Tóibín e da cui è stato tratto l’omonimo film. La mia copia, piena di sottolineature e parole tradotte a bordo pagina, è rimasta nella casa della mia host family. Ho rimpianto spesso di non essermi impegnata abbastanza per trovarle un buco in valigia, di non averla portata via con me. Brooklyn è in parte ambientato a Enniscorthy, una cittadina in County Wexford, nel sud est dell’Irlanda, la stessa in cui Tóibín è nato nel 1955. Come Eilis, a un certo punto se ne va, ma l’America per lui deve ancora aspettare. Prima ci sarà Dublino per frequentare l’università e poi, il giorno dopo la laurea, Barcellona. È lì che trarrà ispirazione per il suo romanzo d’esordio The South, ambientato durante la dittatura di Francisco Franco. Protagonista è Katherine, che per inseguire il sogno di diventare pittrice abbandona marito e figlio in Irlanda e si trasferisce in Spagna, dove si innamora dell’anarchico Miguel. Ma non è Tóibín il bambino lasciato solo con il padre, e quella donna non è sua madre. Nei suoi romanzi di autobiografico c’è poco, ma «se ogni romanzo è in qualche modo la metafora di una parte di te stesso che spesso maschera ciò che si vuole rivelare, non puoi mai essere sicuro se sia finzione o autobiografia». La sua vita non è interessante, così sostiene, «le persone si chiederebbero perché leggere un libro su quanto sono noioso».
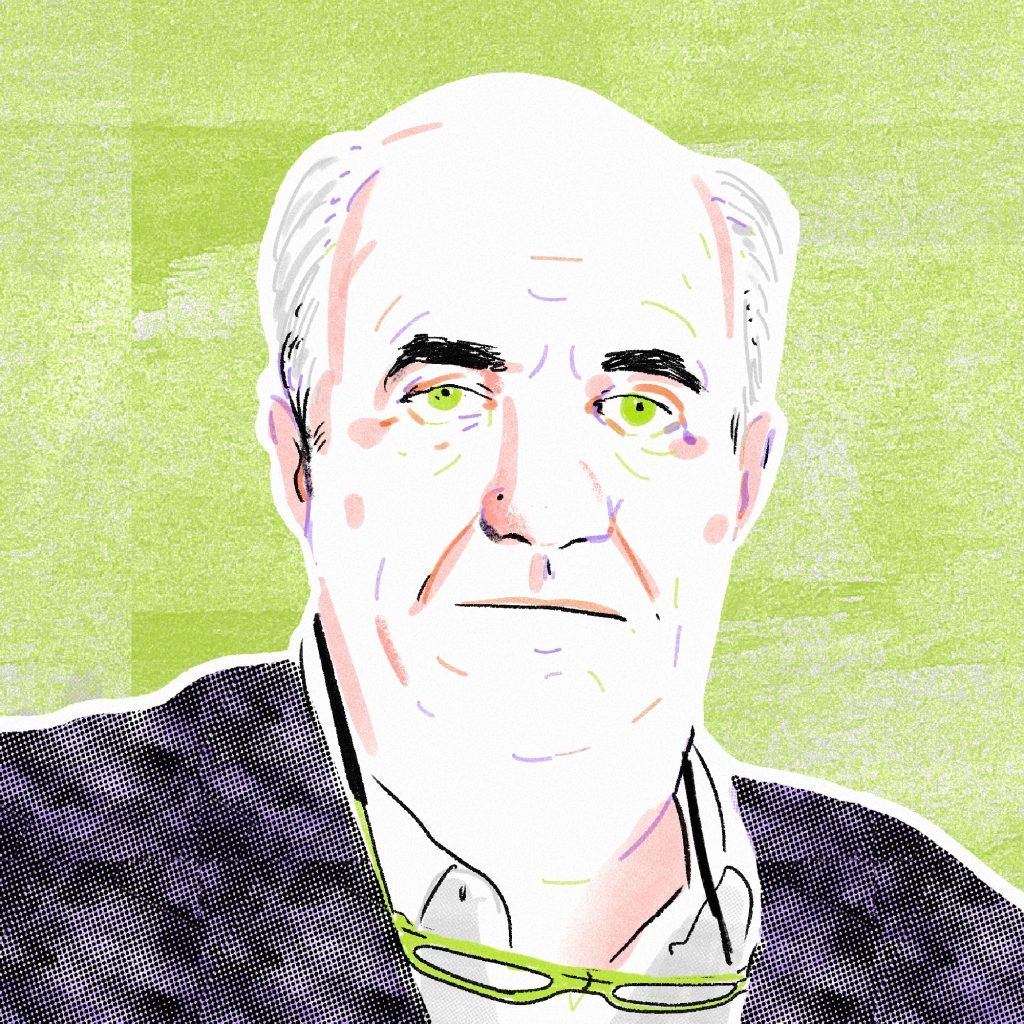
Dopo Barcellona tornerà in Irlanda e lavorerà come giornalista per la rivista Magill, occupandosi prima di politica, poi di letteratura. Si licenzierà quasi dieci anni dopo. Per poter scrivere, e basta. Perché la scrittura è un mestiere che richiede una dedizione assoluta, insegnamento che, secondo lui, dovrebbero impartire le scuole di scrittura. «Scrivere è un lavoro. Non è solo espressione di sé, del proprio dolore e delle emozioni che si sentono, prima di tutto è un lavoro a cui bisogna dedicarsi. L’ispirazione può dettarti la prima frase ma dopo devi lavorare, e quando finisci di lavorare devi lavorare ancora». Lo ripete tre volte di seguito, e se prima le sue braccia erano inerti sul tavolo adesso si è animato, è attento, accompagna e scandisce ogni parola con gesti frenetici. Sembra stia ripercorrendo la sua carriera, tutto il work enfatizzato dai must che deve aver perseguito con costanza negli ultimi cinquant’anni. «Non si deve bere, non si devono assumere droghe, non si deve andare ballare nel weekend quando dovresti essere rimasto a lavorare. Se stai scrivendo un romanzo, è lui ad avere il controllo sul tuo fine settimana. Le persone pensano: Oh, ma se hai talento, non c’entra, tu devi lavorarci anche in quei momenti, se ti ubriachi il sabato o la domenica subirai i postumi il lunedì e il martedì, e non riuscirai a lavorare». A ogni you mi indica, mi sento redarguita a nome di tutti gli aspiranti scrittori. È capace di incatenare, Colm Tóibín, e di incantare, un ponte di pietra grigia marezzata di muschio verde che attraversa lo Slaney, il fiume del suo angolo d’Irlanda, di casa sua.
Lui è il secondo di cinque figli e quando si è secondi figli, dice, è dura riuscire a finire una frase senza essere interrotti dai propri fratelli. Qualsiasi cosa tu voglia dire deve risultare subito interessante e divertente, anche se si tratta della zuffa di un cane e di un gatto nel cortile. Per non farsi rubare la parola, bisogna saper raccontare. È questo che lo accomuna a Henry James e Thomas Mann, altri secondi figli di cinque. Li ha letti entrambi a vent’anni, l’età in cui alcuni autori si appostano su un ramo, si fermano. Non migrano più, nidificano. Anni dopo, su di loro ha scritto due romanzi: James ha preso il nome di The Master, Mann è diventato The Magician. Forse l’abilità nel narrare è un dono che viene concesso solo ai secondi figli. Se è davvero così, penso, la mia carriera è finita ancor prima di iniziare, prima figlia e con un fratello solo.
Se stai scrivendo un romanzo, è lui ad avere il controllo sul tuo fine settimana.
Per capire che Colm Tóibín il dono dei secondi figli lo padroneggia mi è bastato leggere le prime pagine de Il Mago. Al lettore smette presto di interessare se ciò che viene raccontato appartenga alla realtà o alla finzione, se sia la verità. Tóibín è riuscito a spogliare Thomas Mann dai panni dell’autore trasformandolo in personaggio puro, ma quando gli ho chiesto se questa operazione implicasse qualche deep connection, mi ha risposto che non ne sentiva alcuna: «Ho solo capito che riuscivo a immaginarlo, che potevo far credere al lettore di essere con lui nella stessa stanza, di poter ricreare una totale immersione ma sempre mantenendo una grande distanza».
L’aura di serietà, autorevolezza e potere che gli era stata attribuita dalla società dell’epoca franò quando, venticinque anni dopo la sua morte, furono ritrovati i suoi diari. Aveva ingannato tutti, Thomas Mann, era riuscito a nascondere le incertezze e le insicurezze che non lo fecero mai sentire al proprio posto. Non è nemmeno un personaggio, dice Tóibín, ma un fantasma, rimane immobile a guardare le vite che gli scorrono accanto. È stata questa dicotomia tra realtà e finzione, ciò che si vede da ciò che realmente è, a renderlo so dramatic. Lo ha scelto perché è narrativo, e per raccontarlo Tóibín deve e riesce a prenderne le distanze con chirurgia. È forse questo un altro potere dei secondi figli. Cogliere, raccogliere il senso del dramatic e farlo fiorire. Per descrivere la propria scrittura usa le parole di Henry James, «Dramatize, dramatize, dramatize». Abbassa il tono di voce, spalanca le pupille, batte il dito sul tavolo, rintocchi di un pendolo e finalmente sorride.
Il tempo è finito, ma Colm Tóibín sorride ancora, ci stringe di nuovo la mano, è ammirato da Alessandro che da trenta minuti, braccio marmoreo, ci ha ripreso mantenendo il telefono immobile. Ringrazia per la chiacchierata, lo guardiamo allontanarsi mentre raccogliamo le nostre cose. Prima mi ha detto che Il Mago è un titolo ironico. Thomas Mann inganna i suoi figli con un semplice trucco delle mani. «Io sono un mago», dice, e tutti gli credono. Ma durante il romanzo Mann si rivela tutto tranne che mago, non riesce a mantenere la promessa di salvare la sua famiglia dai brutti sogni, il soprannome sì. Non lo sappiamo, dove si nasconda il trucco. Forse perché, tra i due, il vero mago è stato Colm Tóibín.
Illustrazione di Giovanni Gastaldi