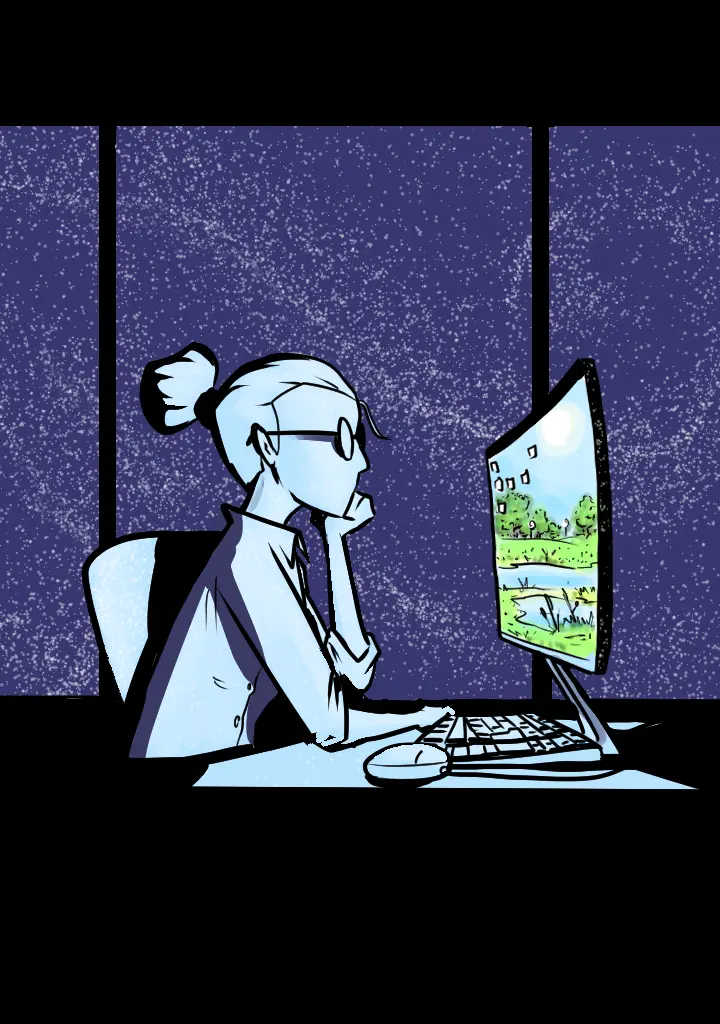Ormai l’aveva capito: quella strada non conduceva da nessuna parte. Era un pomeriggio d’inizio autunno ma l’asfalto era bollente. Camminavano da molto, tuttavia non avrebbe saputo dire, con esattezza, da quanto. Si sforzò di immaginare quella scena dall’esterno. Lo faceva spesso, perché quello era il suo lavoro.
«Un ragazzo e una ragazza camminano in fila», sillabò nella sua mente, «sul ciglio di una strada di campagna. Si conoscono da poco, quindi non si conoscono affatto, eppure abbastanza da…».
S’interruppe. Ripensò all’incredulità dell’avvocato quando li aveva visti arrivare, prima, al cancello della tenuta: lei, i sandali immacolati color panna sulle scale erbose del vialetto d’ingresso; lui, il berretto da baseball con la visiera abbassata a coprirgli fronte e occhiaie. Che curiosa accoppiata, doveva aver pensato. Pur non conoscendo l’avvocato prima di quel momento, lei conosceva le persone del suo stampo: ci aveva a che fare tutti i giorni. Più eri conforme alle norme sociali più gli piacevi, ecco perché, da quando si erano seduti sulle sedie di vimini del patio, non l’aveva mollata un attimo («Come si trova al dottorato?», «Conosce Gualtieri? Insegnava da voi, quando frequentavo l’università io»). Al contrario, non era stato difficile intuire l’opinione che serbava nei confronti del figlio del suo socio in affari, a cui rivolse un misero «Non hai ancora finito gli studi, mi ha detto tuo padre» e, con tono cortese, «Se ti serve un cavalletto, lo trovi nella veranda». S’imbarazzò a domandarsi cosa avesse pensato quando si era presentata con il suo nome e basta, senza essere introdotta come ‘la mia ragazza’ o altre sciocchezze del genere. E poi, doveva di sicuro aver notato che i due giovani non si erano sfiorati per tutto il tempo della visita, eccetto che in un momento soltanto, quando aveva intravisto il ragazzo passarle un braccio attorno a un fianco, mentre lei gli camminava vicino, intenta a non immergere i sandali nella fanghiglia che attorniava i filari. Lei si era girata e lui le aveva sorriso.
Ora, quel ragazzo le camminava davanti, le mani così strette sugli spallacci dello zaino da avere le nocche tutte bianche. Lo sapevano entrambi, ancor prima che lei lo dicesse ad alta voce: «Credo che ci siamo persi». Lui non rispose, si sistemò la visiera e continuò a camminare.
Con quel ragazzo, non aveva nulla in comune eccetto queste tre cose: la strada di campagna, il sole di ottobre che intagliava le loro schiene con lame di luce, la polvere sottile che si levava in aria a ogni soffio di vento.
Per di più, lui non era della razza di quelli che fanno le cose per poterle raccontare, come lei: parlava come nessuno parla, diceva solo i noccioli delle cose. Stava tutto nelle azioni e, finite quelle, di lui non restava nulla: nulla, se non le parole.
«Sei molto più brava tu con le parole, voglio ascoltarti io», le aveva detto a bordo dell’autobus pieno di adolescenti foruncolosi di ritorno da scuola su cui si erano seduti anche loro, due ragazzi sulla ventina, in una delle ultime file. Dove stavano andando? Lei non lo sapeva, lui nemmeno: dipendeva tutto dal navigatore. Non voleva ammetterlo, ma il non sapere la seduceva molto. Non era stato quello, infatti, lo stesso motivo che l’aveva portata a parlare con lui, quella sera di due settimane prima? Lo stava percependo di nuovo, lo stesso tremito sottile che aveva provato la volta in cui si erano incontrati, per caso, al cinema. Era bastato uno starnuto e la richiesta di un fazzoletto che stavano già sussurrandosi nelle orecchie commenti sul brutto film che avevano scelto di andare a vedere. Si trattava di una situazione dal grande potenziale narrativo, lo sapeva: due posti vicini e due sconosciuti che aveva messo insieme, grazie a una scelta accidentale, la signora della biglietteria. Due settimane dopo tra di loro, in fondo, non era cambiato niente ed era questo che la attirava: erano gli stessi sconosciuti di quella sera, solo che si trovavano seduti sui sedili di un bus invece che sulle poltrone di un cinema.
Quando l’autobus si era fermato in aperta campagna, erano scesi e si erano messi a cercare l’indirizzo preciso. Era stato semplice trovare la villa, una macchia di mattoni rossi in mezzo alla campagna brulla, puntellata qua e là da alcuni cipressi smagriti. Una volta arrivati, lo stesso ragazzo che poco prima si torceva le mani, lo sguardo fuori dal finestrino, mentre le confessava quanto detestasse le occasioni formali, aveva preso a disquisire del più e del meno insieme a un adulto pomposo e altero, con una disinvoltura tale da non far trasparire il senso di inadeguatezza che provava. Lui non aveva paura di essere quello che era: un ventisettenne, fuori corso da tre anni, regista a tempo perso, reo di alcune risposte sgarbate («ma memorabili», aveva aggiunto), durante il pranzo di Natale di qualche anno prima, a dei soci dello studio legale del padre.
«Io mi sono accettato», le spiegava. Anche quando la sera prima, seduti sulle spallette del Lungarno di fronte a due birre, le aveva raccontato del sé bambino che tirava i sassi alle anatre dello stagno dietro casa. All’epoca, aveva ammesso rabbuiandosi, lo faceva divertire. Voleva vederle agitarsi, volar via, voleva addirittura ferirle. Era la paura della morte, diceva lui. A ripensarci adesso si sentiva in colpa.
«Per me sei tutto matto» gli aveva risposto lei, perché matto era un buon aggettivo per argomenti da murare. Ma i muri che si era costruita erano di cartapesta e ci voleva poco a far sì che cadessero. Ecco perché avrebbe voluto dirgli che le dispiaceva (forse avrebbe dovuto dispiacersi più per le anatre e invece si dispiaceva per lui), e dirgli che non era solo, che anche lei aveva avuto e tuttora aveva paura e da bambina lo aveva manifestato soffocandosi di pensieri oscuri che ancora adesso, di tanto in tanto, le affollavano la testa. Odiava dover dipendere da quei modi così impersonali: i ‘per favore, per piacere, come stai’ erano parte di un linguaggio che non le apparteneva, non più ormai. Voleva iniziare a vivere in soggettiva, come le aveva detto lui: «Sei tu che devi muovere la cinepresa».

No, lei non si era accettata. E camminando per quella strada di campagna, il sudore che incominciava a impregnarle la camicetta, la collana di perle che la strozzava, le era sempre più chiaro. Non aveva ancora capito chi era. Cosa ci faceva lì? Chi era quel ragazzo? Chi era lei, o meglio, chi era diventata? Mentre tentava di non insozzare i sandali eleganti tra le pozzanghere di fango che traboccavano dai fossi ai margini della strada, si domandava come fosse possibile tornare in sé. Ma si accorse che nelle sue vecchie spoglie o nelle sue nuove spoglie, non aveva importanza, voleva inverarsi in qualcuno che non c’era più.
A volte ripensava ai movimenti accorti, come se si trovasse in un museo, del ragazzo quando aveva visitato la sua stanza per la prima volta. Non si era soffermato sulle foto che la vedevano felicemente abbracciata ad un uomo, lo stesso che, presumeva lo avesse capito, le aveva lasciato quei post-it con su scritto frasi zuccherose. Aveva esaminato, invece, la scrivania con i libri impilati in ordine, un paio di camicie stirate e riposte sulle grucce, qualche locandina appesa alla bell’e meglio, il letto fatto e il comodino sgombro. Alla fine dell’ispezione le aveva chiesto, piccato: «Sicura di essere una scrittrice?». Ripensò a come era stato averlo quella prima notte, e all’odore di alcool e sigarette che aveva impiastricciato le lenzuola. Era finita sul rullino della sua analogica, che si portava dietro sempre, e che amava chiamare la sua estensione fallica. La mattina dopo, lei alla scrivania a leggere il Clemente per l’esame di Storia Romana, lui sul letto a finire di scrivere l’ultima parte della sua nuova sceneggiatura, lo aveva sorpreso guardarsi intorno con aria divertita: sul comodino, accanto a due posaceneri, erano stati accatastati dei dischi di De André e dei Cure che avevano messo la sera prima, sulla scrivania erano stati abbandonati una vaschetta di gelato e numerosi piattini sporchi, sul davanzale giaceva una bottiglia di prosecco vuota. Il pavimento era intralciato: i fascicoli delle mostre di Hopper erano stati sparsi qua e là, la videocassetta di un film di Polanski giaceva in un angolo, un reggiseno era aggrovigliato a una coperta. «Questa è la stanza di una scrittrice».
Più camminava più quella frase insisteva a martellarle, a ritmo dei suoi passi, nei timpani.
I passi si susseguivano sempre più veloci. Tutta quella fretta non sapeva da dove venisse, dato che non c’era nessuno che li aspettava. Lui davanti e lei dietro, il frinire delle cicale in lontananza. Erano nel mezzo del nulla. L’avvocato gli aveva detto che la prossima fermata sarebbe dovuta essere a poco più di due chilometri dalla tenuta. Ormai dovevano quasi esserci. Eppure attorno c’erano solo cipressi e qualche cespuglio incolto. Per un attimo pensò di chiamare un taxi, ma si era dimenticata che non stavano usando il navigatore, perché non c’era rete.
«Quale sarebbe per te la più grande disgrazia?», «Smettere di amare»: era vero, di quel ragazzo conosceva solo le risposte ma nessuna delle domande che, lo sentiva, gli si affastellavano nella mente anche adesso, mentre incedeva a passo lento e sicuro davanti a lei. In fondo, glielo aveva detto lui stesso: «Tu non mi conosci».
Sembrava avesse potuto continuare a camminare per sempre, invece all’improvviso lui si fermò. Si accese una sigaretta e, del tutto a suo agio, prese due boccate, come se fosse in coda per un locale notturno.
«Grazie per avermi accompagnato qui», le disse.
«Intendi nel mezzo del nulla?»
«Anche».
È un’operazione complicata, capire cosa, di volta in volta, è vero o è inventato ed è una negoziazione che chi scrive fa con chi legge. E riprendendo a camminare per quella strada, osservando i suoi passi farsi sempre più incerti ed i sandali imbrattarsi completamente di terra scura e detriti limacciosi (ormai nulla poteva importarle di meno), si accorse che la storia di sé che aveva scritto non coincideva più con la versione di sé che voleva fosse letta. Aveva aderito al patto ambiguo che c’è tra scrittore e lettore e aveva scoperto di essersi sempre raccontata male. Chi era lei? Quella che si curava che i suoi sandaletti candidi non si infangassero lungo i filari o quella che li lasciava immergere nella melma? Quella che discuteva con l’avvocato per buona educazione o per un intrinseco bisogno di sentirsi lodata, mal celando l’insidiosa insicurezza di chi ha bisogno dell’appoggio esterno per credere davvero in quello che fa? Chi era mai stata? Quella che tradiva il suo fidanzato con un ragazzo conosciuto in un cinema, o la ragazza fedele e innamorata, che, come nei film, non cambia mai idea?
Anche lui, quel ragazzo con la sigaretta tra le dita, alla fine non aveva capito nulla di lei: «Aspetta un amore più fidato» le aveva detto fissando il soffitto, la sera prima. Ma non le interessava trovare un amore. Era il modo in cui lui (del tutto involontariamente, ne era certa) l’aveva fatta sentire: non più lei ma mille altre. Come uno scrittore quando sa cosa vuole raccontare ma non sa come, e gli si parano davanti una quantità innumerevole di possibilità infinte e tutto ciò che deve fare, che è anche la cosa più difficile, è scegliere cosa voler essere. Aveva capito che non sapeva scegliere. Non ancora. Voleva essere tutte le possibilità, ma si sentiva di non essere ancora niente.
Una volta finita la sigaretta, buttò il mozzicone a terra.
«Sta passando una macchina, guarda» le disse.
Effettivamente una macchina stava per approcciarsi a loro. Ne udiva il rombo in lontananza. Lei gli chiese cosa intendesse fare.
«Se non vuoi rimanere qui fino a stasera non abbiamo scelta, ci facciamo dare un passaggio in paese».
«Vuoi fare l’autostop?»
Lui non rispose e come il vecchio furgone li costeggiò, allungò il braccio, la mano con il pollice all’ingiù. Per un attimo ci credettero entrambi. Ma il furgone li sorpassò.
«Dannazione!»
Ripresero a camminare. Sentiva che era tutto vero, come il sole del tardo pomeriggio che li accompagnava e si sorprese a non sentire il bisogno di pensare a come l’avrebbe raccontato.
Il rumore di un’altra auto li raggiunse di nuovo.
Le ricordò il clamore improvviso che aveva udito aprendo la finestra a casa del ragazzo, e gli aveva appena chiesto come facesse a dormire con quel chiasso che ogni notte saliva su fino al soffitto affrescato della sua camera: universitari che l’alcool rendeva euforici e rumorosi si radunavano in capannelli sparsi attorno alla piazza quadrata e sotto ai portici.
«Quanti amori avrai visto nascere da quassù» gli aveva sussurrato.
«Bastano due negroni e tutti si innamorano»
L’aveva letta ma non aveva fatto commenti. Stava chiudendo le persiane, quando, quella sera, a riguardo del suo ultimo scritto, le chiese soltanto: «Ma quand’è che la gioventù si tradirà da sé?».
L’auto stava per arrivare, era sempre più vicina.
Lei si sporse e lo imitò, il braccio ben teso e il pollice all’ingiù, come aveva fatto lui poco prima.
Entrambi fissarono il mezzo (un’utilitaria rossa) continuare imperterrito la sua corsa. Ma dopo pochi metri, nonostante li avesse superati, con loro grande stupore si fermò di colpo. Lui la sollevò in piedi abbracciandola, poi passata l’euforia iniziale, si incamminarono verso la macchina.
Al volante c’era una donna, a cui lui disse qualcosa. Si era già seduto davanti quando si girò e disse alla ragazza che era rimasta fuori:
«Agata, non sali?»
«Sì».
Si chiuse la porta alle spalle e la vettura partì. ♦︎
Illustrazione di Lara Milani