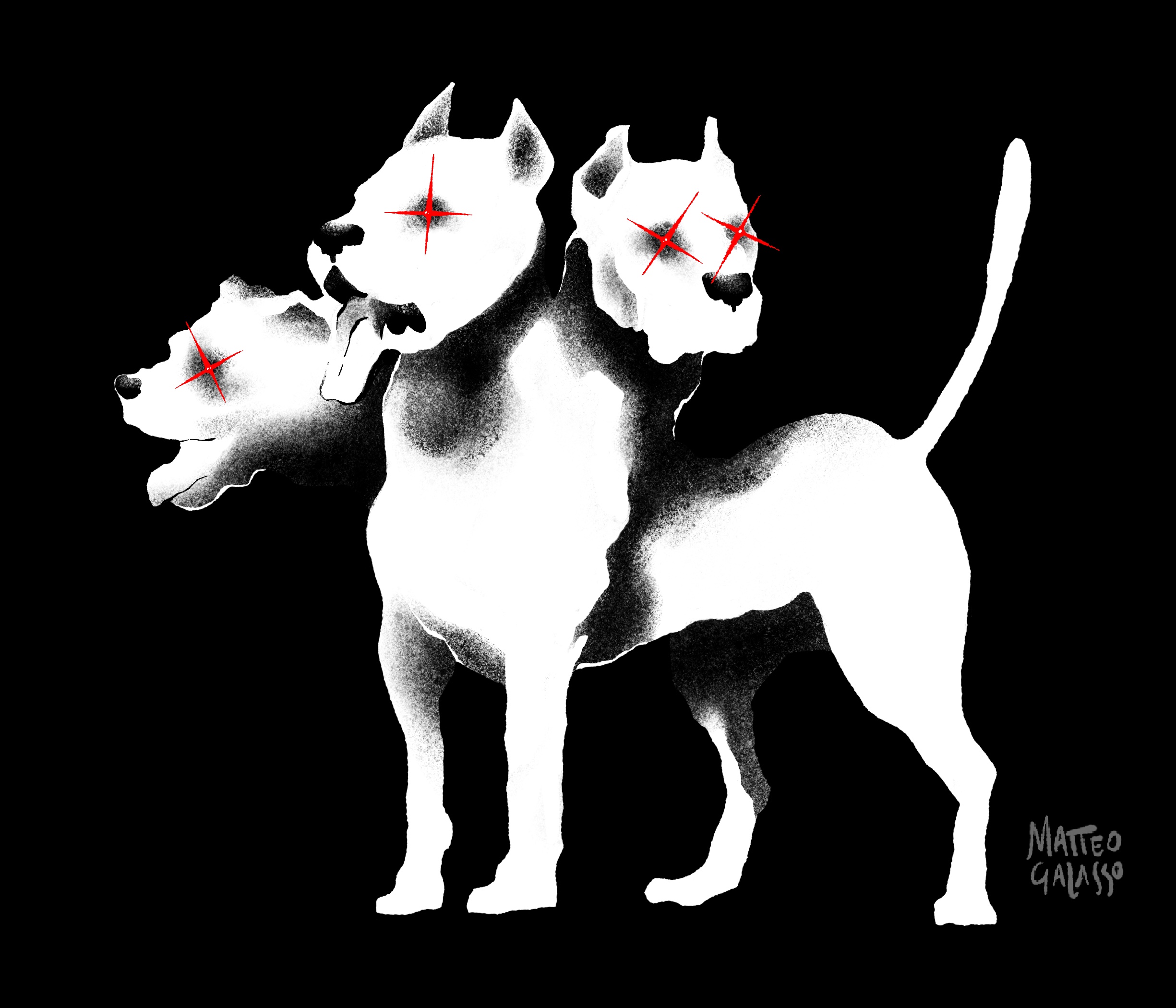Era il 2014. Dieci anni fa.
I primi tempi è un pensiero fisso, un discorso da affrontare con gli amici ogni giorno finita scuola, appoggiati al muretto. C’è quello che lo esclude e sostiene sia solo uno scherzo, quello più dubbioso che dice che potrebbe essere, e tu che non puoi neanche accettare il pensiero e allora lo prendi in giro e Ma va, ti pare, impossibile. Poi il tempo passa e i timori diventano concreti, non si può far finta di nulla, sta succedendo davvero. Sono giornate difficili, in cui ci si sostiene a vicende, ci si dice Va bene, è un periodo, ma finirà presto. Invece no, non finisce, e «presto» è una parola dal suono strano se pronunciata al confine ultimo dell’adolescenza, quando la vita inizia a correre. Finisce il liceo, inizia il tempo delle scelte, per tutti noi, ma stavolta ognuno per sé. Ti trasferisci, le cose cambiano, cerchi una direzione verso cui lanciarti: nuova città, nuovi giri, nuovi ambienti, e l’università e tutto il resto, che va avanti. Capita a volte ancora di parlarne, con una consapevolezza nuova, con un sorriso e la nostalgia: Dai che succederà prima o poi. La vita non da tregue, porta ogni giorno questioni nuove e pensieri, trascina altrove, come se rivelasse all’improvviso che tanti dettagli, tanti frammenti che credevi intoccabili, non fossero in realtà così importanti. E un passo alla volta, accetti la sua legge, e ti convinci che ha ragione, che anche quello non è che un residuo di gioventù che ha perso importanza con l’esperienza. D’altronde, c’è altro a cui pensare: il diploma, il lavoro, i progetti, gli studi, le donne, gli amici che vanno, quelli che entrano, ognuno cammina la sua strada e la cammina meglio che può: cambi ancora città e con lei le abitudini e le priorità. Sono passati ormai quasi dieci anni, ora vivi in un bilocale con la tua compagna, ti dedichi a te stesso, alla tua relazione, ai tuoi progetti, alla socialità. Giorno e notte pianifichi un futuro, dentro la legge di una vita che ha vinto sul superfluo, che ha cancellato burle e frivolezze. A loro, semplicemente, non pensi più.
Poi succede qualcosa e quel qualcosa arriva un venerdì qualsiasi di ottobre: il telefono vibra, senza sosta, lo sblocchi e vedi decine di notifiche, chiamate perse e messaggi. Amici che non sentivi da tempo, quelli dell’università, quelli del muretto fuori da scuola, tutti dicono la stessa cosa: «Hai visto?».
La tua fidanzata ti sente gridare, accorre per vedere che succede e ti trova immobile, con gli occhi lucidi, perso chissà dove oltre lo schermo del telefono. «È successo», le dici, eppure continua a non capire. «È successo», ripeti. Lei ti fissa, è perplessa, forse preoccupata. Sai che non bastano le parole, non ne hai di abbastanza grandi, e allora le porgi il piccolo schermo che reggi tra le mani, lei fa ripartire il video e la magia ricomincia.
C’è Milano, in una veste nera e sporca, una Milano criminale dai cui tetti non si vede che fumo e cemento: è lì si incontrano i due uomini, vestiti da noir americano, a guardare la città dall’alto: l’attore Claudio Santamaria e il sindaco di Milano, Beppe Sala. «L’ultima volta sono andati fuori controllo», dice Claudio Santamaria, «ma non abbiamo altra scelta». Beppe Sala non risponde, nel suo silenzio c’è complicità: Santamaria con uno slancio del braccio solleva il telo accanto a lui e scopre un grande faro polveroso. Lo riguardi, adesso ci credi. È il momento di riaccendere il segnale. Una luce, tra le nuvole, un simbolo: maestoso, inequivocabile.
«Cosa vedi amore», chiedi alla tua fidanzata, con la voce più dolce che hai.
«È un cane, un cane a tre teste, un Cerbero» ti risponde, con una leggera esitazione.
Le sfili il telefono dalle mani, sorridi e scuoti la testa.
«È un dogo amore, è il Dogo».
Il 20 ottobre, con un video postato direttamente sulla pagina Instagram del gruppo, l’annuncio ufficiale: nel 2024, dieci anni dopo, la riunione dei Club Dogo. E all’improvviso, quel sentimento che eravamo tutti sicuri fosse estinto, torna prepotente a prendersi il suo spazio nella mente, a essere qualcosa di più. Ma non sei più al liceo, non è qualcosa di accettabile: un momento di debolezza, di cui nessuno deve parlare. Fai finta di niente, ci scherzi su, «da ragazzini nel mio gruppo li ascoltavamo», e tutti ridono intorno, come si ride ripensando alla cotta per la compagna di banco della materna.
La tua faccia allo specchio ti guarda, perplessa. Ha delle domande, che cerchi di soffocare. Io sono Alessandro e non sono mai stato un b-boy. Scrivo d’arte, leggo i russi e frequento cinema d’essai. Lo ripeti a te stesso, ti illudi di crederci, di avercela fatta, di aver riportato il passato al suo posto, che sia finita. Non lo è.
Dalla mattina seguente ti senti strano: hai un gran male alle meningi e vampate di calore, come una febbre improvvisa, che il termometro non sembra registrare. La testa gira, fai pensieri strani, incomprensibili. La testa gira, la testa gira. Prendi una pastiglia, la butti giù a memoria, in un sorso d’acqua, speri che faccia effetto, che sia solo un fastidio di inizio giornata. Lasci passare il tempo, che siano ore, che siano giorni, passerà senz’altro. E invece il calore non scende e la testa gira e un passo per volta ti accorgi di nuovi sintomi.
Il primo viene fuori prima di andare al lavoro, quando passi più tempo del solito davanti all’armadio: le camicie, i cardigan, i maglioncini, hanno tutti qualcosa di sbagliato. Un giorno prendi da un cassetto una felpa col cappuccio, un po’ larga, ma sta bene con i vecchi jeans e le Air Jordan alte. Riflesso allo specchio, pensi che dovresti abbinarci anche un berretto con la visiera, al rovescio, o i brillanti nell’orecchio. Lo stile che non si compra, commenti a voce alta, in un ghigno.
Poi arrivi al lavoro e la situazione si fa difficile: senti di perdere tempo col computer, senti di non essere nel posto giusto; e i colleghi che ti guardano strano, che sembrano infastiditi da te. Dal tuo stile, dal successo, dai tuoi soldi. L’invidia è l’erba del diavolo, ti ripeti in testa, l’invidia uccide l’anima. Capisci che per tutto questo tempo sono stati solo degli odiatori. D’istinto vorresti fargli brutto, ma cambi idea, non devi dargliela vinta. Ti alzi in piedi, guardandoli negli occhi, e ridi, sguaiato. Che sappiano tutti, che tu non li odi, ma solo perché non hai tempo.
La testa gira, il calore sale, neanche nei momenti di svago hai tregua: con gli amici dici io venti volte al minuto e per un semplice aperitivo spendi tutti i soldi che hai incassato ordinando ai camerieri bocce di shampo a oltranza.
È stress, ti dici che hai bisogno di una pausa. Vai fuori città, in cerca d’aria, eppure gli sbatti non dormono mai e neanche passeggiare aiuta a distendere: ogni volta che senti un motore rombare per strada salti in aria, strepiti e urli. Ti rendi conto di provare una onesta e incontrollabile attrazione per la città e i suoi miti, per i booster specchiati e i Tmax opachi neri, e che fare le impennate lungo i viali e i controviali di Torino sia per te una sorta di vocazione. La tua cura per stare lontano dallo stress diventa fumare un po’ di marijuana ogni tanto, giocare alla playstation, svagarti. Ma tutto questo appanna sempre di più.
Cerchi di non addormentare la ragione e nei rari momenti di lucidità lo sai di stare male, ma non capisci cosa stia succedendo. Passi più tempo in farmacia che in casa, ma non basta, la malattia avanza, ogni giorno ci ripensi, sudi mentre guardi il soffitto; ogni notte dormi male, i pensieri assillano. Si svegliano i mostri.
La tua fidanzata è esausta, non ne può più delle tue follie: da una settimana per farti alzare dal letto vuoi il cash, dentro casa bevi e fumi, il tuo profumo naturale è diventato quello della ganja. L’ultima goccia è non chiamarla più per nome, ma solo sgrilla: ti urla contro, fa le valige, minaccia di andarsene. Tu piangi, ma sai che ha ragione, che la stai facendo soffrire. Aspettami mia signorita, sussurri. Lei non ti risponde più, va verso la porta, tu prendi a gridare che non riesci a farci nulla, ma che la ami e lei ti ama e che il resto si fotta. Ti guarda, con pietà, prende il telefono e chiama per una visita specialistica, degli esami, un consulto.
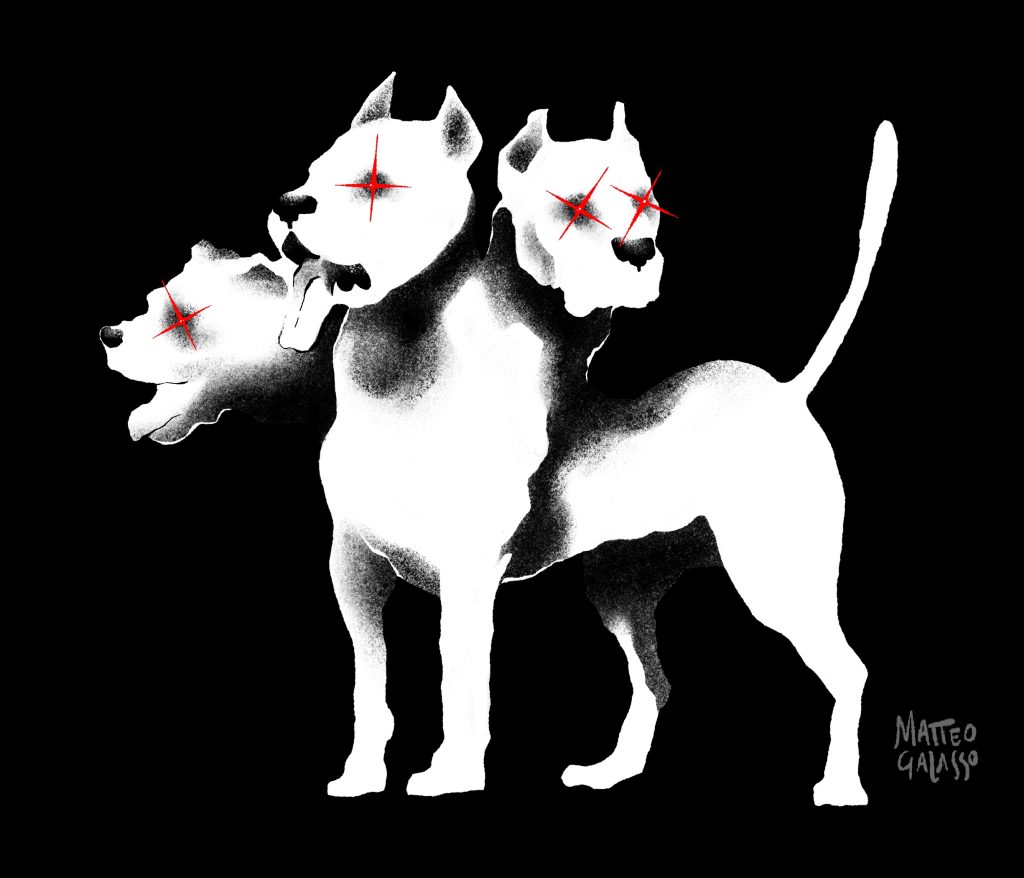
La notte prima degli esami vai in para. L’indomani la situazione è peggiorata ancora: il medico ti sorride e si presenta cordiale, garantendoti il massimo sforzo. Gli stringi la mano e lo ringrazi, ma intanto stai pensando solo un modo per fargli il Rolex dal polso. Ti guarda come se sapesse, ma fa finta di niente e ti accompagna nell’ambulatorio. La visita è veloce, il medico è sicuro e non appare stupito: «La situa è chiara, si tratta di una malattia molto comune ultimamente, che pensavamo estinta e invece è tornata. Una forma di dogofierezza acuta con febbre del cash, che non conosce aspirina», esclama. Per simili patologie i metodi tradizionali non bastano e serve intervenire subito. Terapia sperimentale localizzata: mi prescrive cantautorato classico tutti i giorni, due pezzi dei Baustelle dopo i pasti e almeno quattro tracce dell’album d’esordio dei Cani subito prima di dormire; a fine cura nuovi controlli. La tua fidanzata sorride, il medico la rassicura, anche tu ti mostri ottimista: ma fingi, la verità la sai e loro non la possono capire. Loro non sono come te e non lo saranno mai.
Dopo tre settimane, torni per la nuova visita: nonostante la cura, la dogofierezza è sempre più intensa. Hai passato le settimane in tuta sulla panchina al parco, i weekend senza maglietta col megafono in curva, e al posto dei soliti mille libri, ora leggi solo la Gazzetta dello Sport, che confidenzialmente chiami ‘La Gazza’.
Il medico ti guarda senza parlare, poi ti accompagna davanti a uno specchio e finalmente ti vedi dall’esterno: un uomo adulto, in tuta di felpa, pieno d’oro giallo addosso: denti, catene, gioielli, collane con i santi, madonne e corone.
Il medico è serio, appunta delle cose, infine sentenzia. «I parametri di zarroganza sono davvero troppo alti. Sei ancora quel ragazzo, sempre dogofiero». Guarda la tua fidanzata, ha la testa bassa ma annuisce. «Terapia d’urto», sentenzia. Ti firma una ricetta, l’ultima speranza: la prescrizione stavolta è un biglietto al Forum d’Assago per sentire i Club Dogo dal vivo. Ti spiega che sei parte di un’epidemia generazionale e che partecipare a uno dei dieci concerti a Milano nel 2024 è l’ultima speranza per tutti. Una proposta del Comitato tecnico scientifico, sostenuto dal ministero e dalla protezione civile per arginare il fenomeno spiega. Ma si sbaglia, ho smesso di credere alle favole e a chi me le racconta, non c’è niente da combattere. «Il Dogo è per la gente», gli rispondi, «dalla gente e per la gente»: lo era nel 2002 quando è nato, lo era nel 2014 quando ha rilasciato l’ultimo disco e lo sarà nel 2024, la legge del cane non ammette eccezione.
Ti dà una pacca di conforto, «ci rivediamo il 12 gennaio per altre analisi», ti dice. La tua ragazza nasconde le lacrime. Escono insieme dall’ambulatorio, per firmare i documenti e acquistare online il biglietto. Per lasciarti un momento da solo.
Sblocchi il telefono, guardi il calendario. 12 gennaio.
Senti qualcosa, sale dal sottosuolo e arriva fino a sopra il duomo.
È una voce, è la voce di chi non ne ha.
Ti parla, dice qualcosa, senza equivoci. Non si torna più indietro.
Club Dogo is back, game over. Il sogno di ogni zanza si è avverato.
Ora la stanza è piena di fantasmi, ma tu non reagisci, non ne sei più spaventato.
La tua faccia allo specchio ti guarda, perplessa. Ha ancora domande, ma stavolta sai la risposta.
Io sono Alessandro e non sono mai stato un b-boy.
Scrivo d’arte, leggo i russi e frequento cinema d’essai. Ma mi ascolto anche Mi Fist, quindi cazzo vuoi?
Lo hai sempre saputo.
Ti avevano detto che sarebbe passata con l’età e invece brucia ancora.
12 gennaio, Club Dogo.
La legge del cane che non ammette eccezione.
Illustrazione di Matteo Galasso