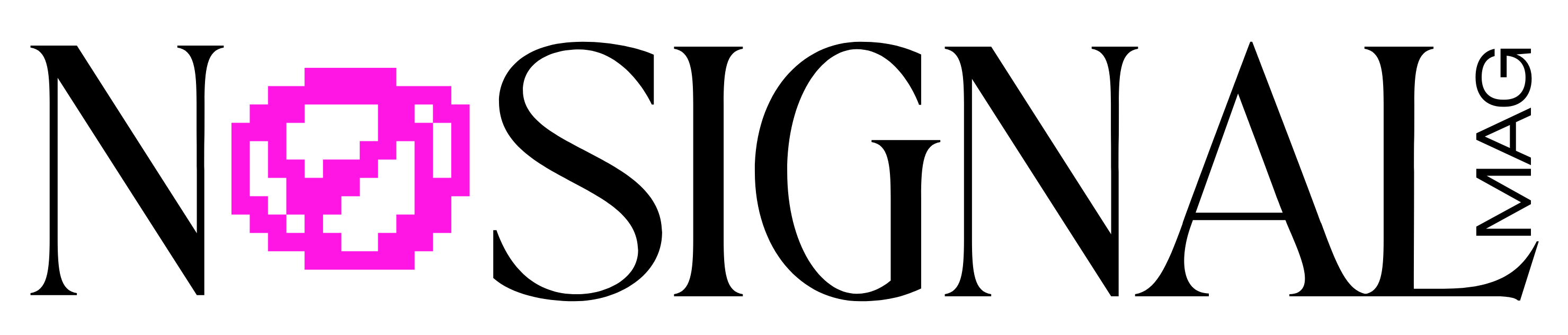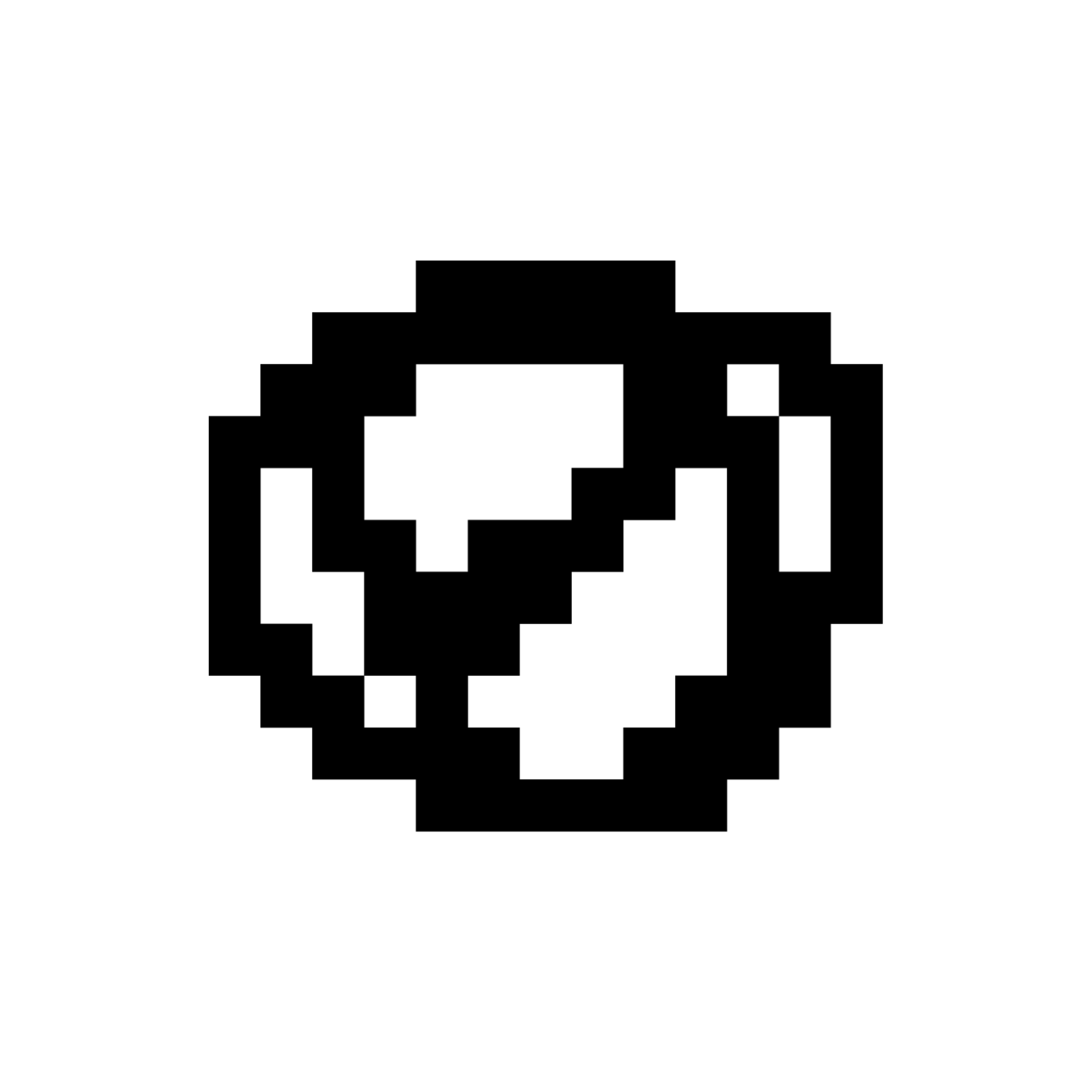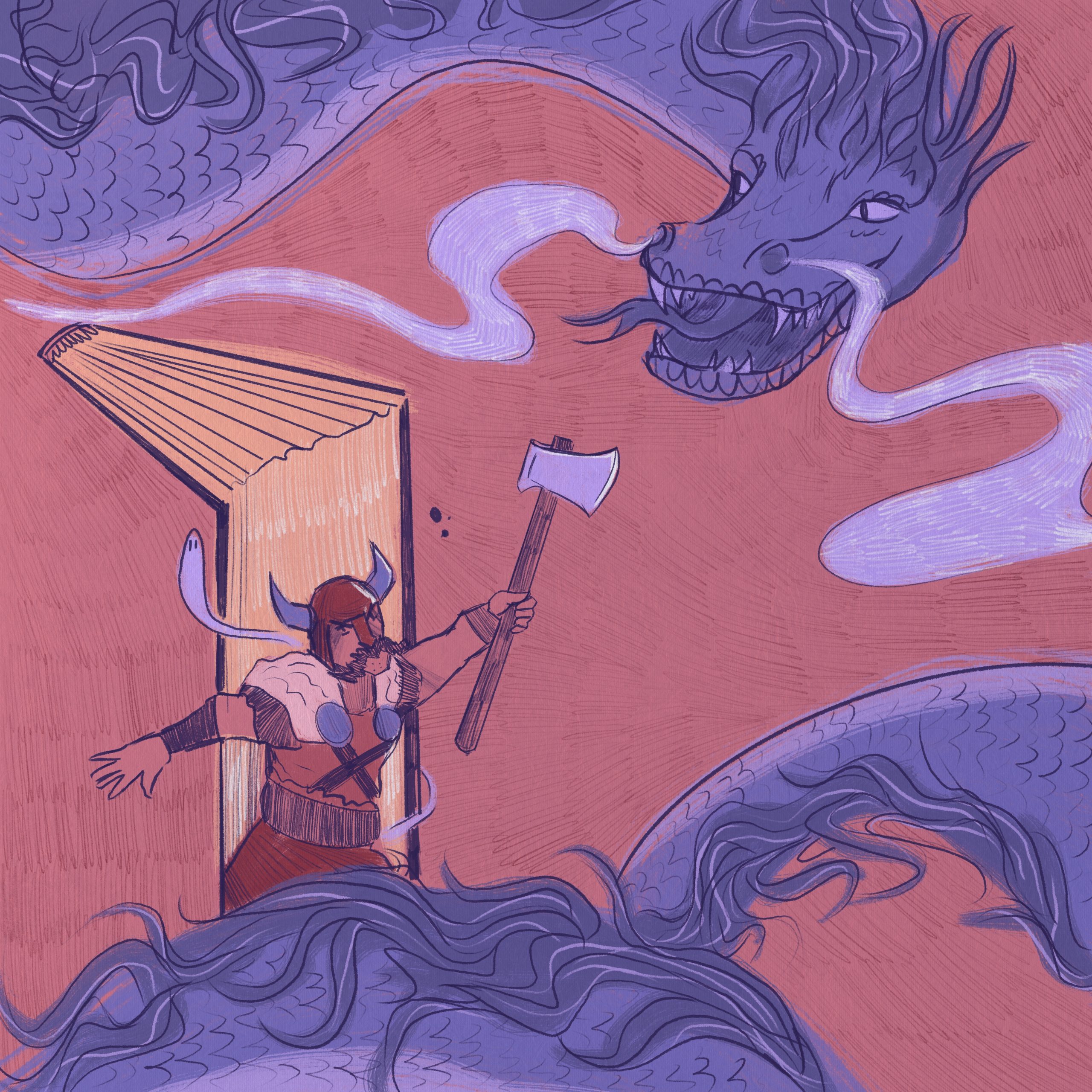Intelligenze naturali
Siamo abituati a pensare alla tecnologia come qualcosa di non scindibile dalla corrente o dai circuiti informatici. Ma prima dell’informatica e dell’intelligenza artificiale la tecnologia era meccanica. L’aratro è tecnologia, la pipa è tecnologia e perfino i ciottoli di selce, quarzite e basalto sulla punta delle lance degli uomini di neanderthal sono tecnologia. Lo scopo di questa tecnologia è aiutarci nello volgere una funzione che questi oggetti sanno (non per nascita ma per metodo costruttivo dato dall’uomo) fare meglio. L’ultimo stadio della tecnologia è l’intelligenza artificiale.
Ma cos’è l’intelligenza e da quanto sentiamo parlare? L’Intelligenza non è da considerare un unico blocco ma un insieme di più intelligenze: «un insieme di capacità mentali e psichiche che permette di comprendere, pensare e spiegare i fatti». È questo il modo in cui Howard Gardner definiva l’Intelligenza Naturale al cui interno sono presenti nove tipi di intelligenza: Linguistica, Logico-matematica, Visuo-spaziale, Interpersonale, Naturalistica, Esistenziale o Teoretica, Musicale, Corporeo-Cinestetica.
Quella Naturale è quindi l’intelligenza che regola i processi, non solo degli esseri umani, (per questo non intelligenza umana) ma di ogni forma di vita sul pianeta. I corvi della Nuova Caledonia fabbricano strumenti per estrarre le larve di insetti dai buchi del legno, I macachi thailandesi usano le pietre per aprire le ostriche, I delfini comunicano attraverso complessi comportamenti sociali e infine (ma non infine) gli elefanti sono dotati di notevole empatia riuscendo a comprendere le emozioni degli altri. L’intelligenza naturale ha quindi sviluppato per anni tutto quello che troviamo sul pianeta, plasmando i modi di vivere e di comportarci.
L’arrivo di una nuova intelligenza, quella artificiale
È il 1956, quando viene sviluppato il programma Logic Theorist, che era in grado di dimostrare 38 dei 52 principi matematici del libro Principia Mathematica, senza limitarsi alla dimostrazione ma creando, per alcuni di essi, nuove e più brevi dimostrazioni.
Quel programma non era diverso dal cervello dei matematici che lo seguivano, aveva immagazzinato informazioni e attraverso dei processi le riconosceva e le elaborava.
Quando John McCarthy, uno dei matematici di quel team, presentò il progetto, in occasione di una conferenza al Dartmouth College, utilizzò il termine «Intelligenza artificiale». Abbiamo così una nata di nascita di questo sistema che nell’immaginario dei progettisti era un sistema che non funziona diversamente da come funzioniamo noi. Porremmo quasi dire che il nostro cervello segue lo stesso sviluppo che segue Chat GTP: una tavola vuota su cui si scrivono informazioni e quando il mondo esterno dà input il nostro cervello risponde ripescando nella ‘libreria’.
Possiamo dire, dunque, che il nostro cervello è uguale all’AI? Assolutamente no. Le risposte del nostro cervello sono il risultato di esperienze accumulate, non soltanto di dati. È in questo punto che le strade dell’intelligenza artificiale e di quella naturale si separano: il nostro cervello possiede un corpo che gli permette di sperimentare, ricevendo stimoli e provando sentimenti come gioia, dolore, piacere e sconforto, che si intrecciano con le conoscenze acquisite non solo tramite l’inserimento di informazioni, ma anche grazie alle esperienze passate. Tale intelligenza è plasmata da un contesto sociale e culturale, elemento che manca completamente agli algoritmi. Questa è la differenza fondamentale tra organismi e meccanismi: i primi hanno lo scopo di vivere, mentre i secondi sono concepiti esclusivamente per eseguire compiti specifici. L’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento sofisticato, non diverso da un aratro, una macchina o una tenaglia, che si limita a svolgere la funzione per cui è stata progettata. Pur condividendo con l’intelligenza naturale il metodo di immagazzinamento dei dati, l’AI non può “alimentarsi” delle esperienze, e, sebbene possa essere estremamente potente nelle operazioni per cui è stata creata, non deve destare timore, proprio come non temiamo strumenti più veloci o più forti. Rimane comunque il fatto che le reti neurali artificiali sono molto meno complesse del cervello umano, composto da miliardi di neuroni organizzati in una gerarchia estremamente sofisticata. Le reti attuali presentano meno livelli di elaborazione rispetto alla sofisticata struttura neurale umana. Questa differenza spiega la maggiore capacità di astrazione e complessità del cervello umano. (Per chi volesse approfondire qui.) Un’intelligenza a cui manca l’elaborazione umana che crea la percezione attraverso input dei dati sensoriali provenienti dall’ambiente esterno. Questi dati vengono elaborati dal cervello attraverso una serie di processi che li trasformano in rappresentazioni interne. Senza contare che non stiamo parlando del concetto di coscienza che aprirebbe ad una discussione ancora più ampia.
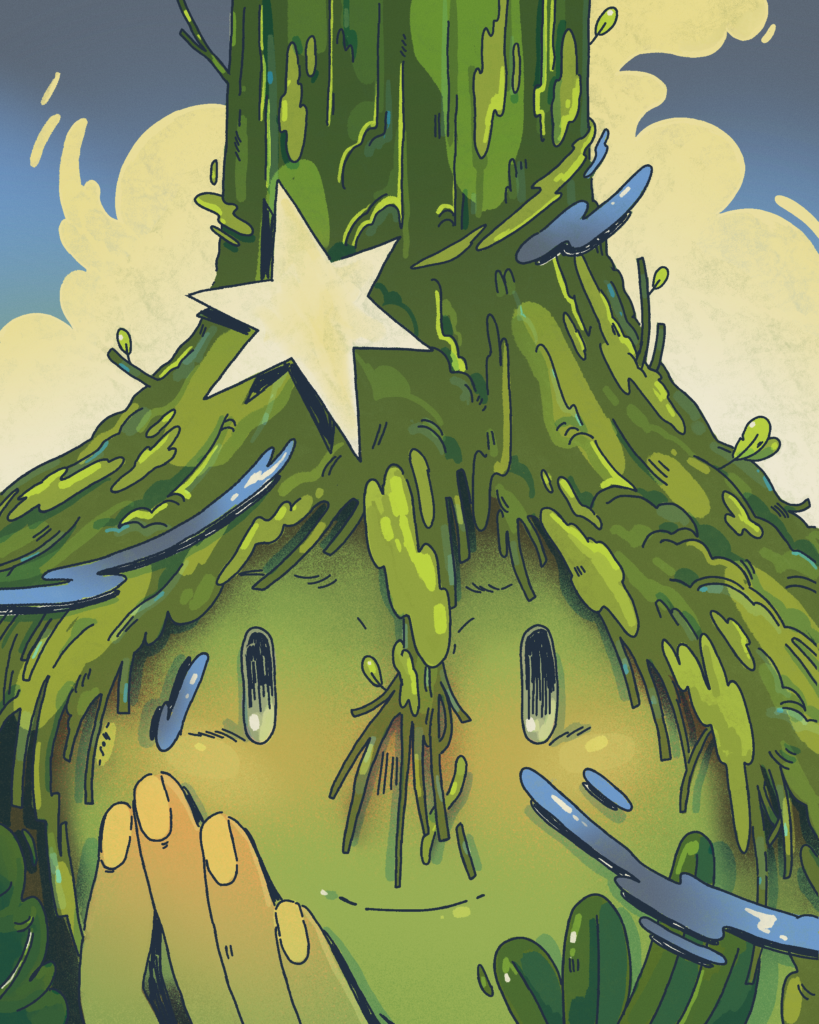
Nove e mezzo
Se è vero che non deve spaventarci è anche vero che, ora sulla terra esiste una mezza intelligenza in più, come sarà lo spazio della loro convivenza?
Bill Gates in un’intervista rilasciata pochi giorni fa, sostiene che stiamo entrando in quella che viene definita l’”era dell’intelligenza gratuita”, un periodo in cui l’accesso a strumenti di intelligenza artificiale evoluta diventerà sempre più diffuso. In questo contesto, numerosi ambiti – dalla diagnosi medica al supporto educativo, fino all’assistenza legale – saranno affidati principalmente a modelli generativi e algoritmi avanzati. Tale trasformazione promette di rivoluzionare il modo in cui svolgiamo molte mansioni, rendendo più accessibili ed efficienti servizi che in passato richiedevano l’intervento diretto di professionisti. Tutto questo ci consentirà di lavorare due giorni a settimana (dice Bill Gates, come disse Romano Prodi venticinque anni fa). Che detto così ci sembra un sogno, ma ogni evento porta ripercussioni; quali potrebbero essere quelle di una società in cui miliardi di individui si trovano improvvisamente ad avere intere giornate libere? Orde di turisti oscureranno i cieli su milioni di aerei in giro per i mondo? Ci sarà una saturazione del mondo dell’arte con tutti questi individui che iniziano a studiare uno strumento musicale intasando così il sistema internet che permette a tutti di pubblicare un brano? Questo mi fa venire in mente una canzone di David Byrne, In the Future, «In the future, there will be so much going on, that no one will be able to keep track of it» Tutti faranno più sesso e avremo una media di 10 figli a testa saturando le città, le scuole, gli ospedali?
Insomma, che questa intelligenza porti il conteggio delle intelligenze a nove e un quarto, un terzo o un mezzo, poco conta, è indubbio che esiste un meccanismo nuovo che ha e avrà un impatto considerevole sul nostro modo di vivere e forse lo avrà anche nel nostro processo di sviluppo cognitivo. Senza contare che si potrebbero presentare anche problemi a livello sociale come quelli dati da algoritmi pregiudizievoli (già sta succedendo) che replicano i bias presenti nei dati di addestramento, risultando in discriminazioni verso certi gruppi. Ad esempio, questi bias possono sbagliare il riconoscimento facciale per le minoranze o penalizzare alcuni candidati nel credito e nel recruiting. È quindi essenziale monitorarli per evitare che perpetuino ingiustizie sociali. Questo richiede una riflessione critica sulla provenienza dei dati e sulle modalità di allenamento dei modelli di IA.
Insomma, ci ritroviamo a dover convincere con un’intelligenza in più, il ciottolo di selce, quarzite o basalto della nostra epoca ed è meglio capire il prima possibile come integrarla davvero nel nostro mondo. ♦︎