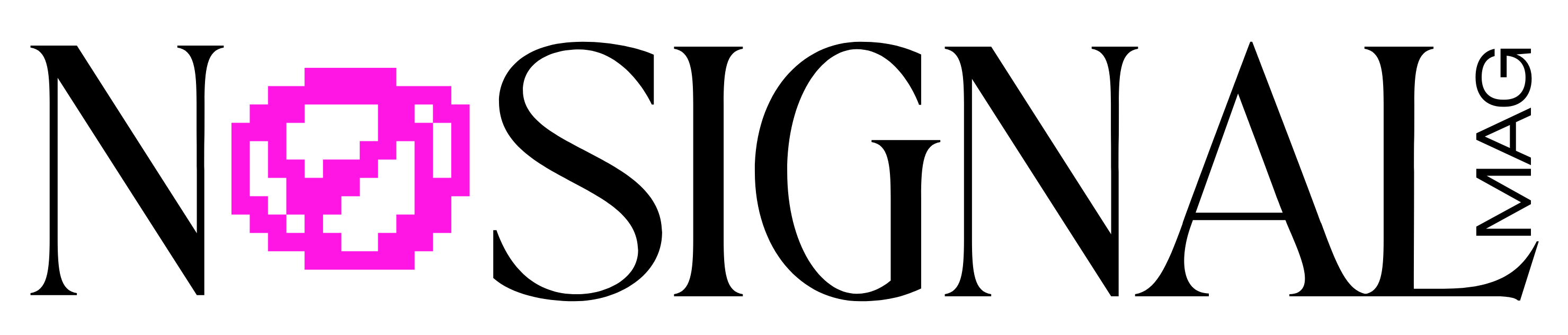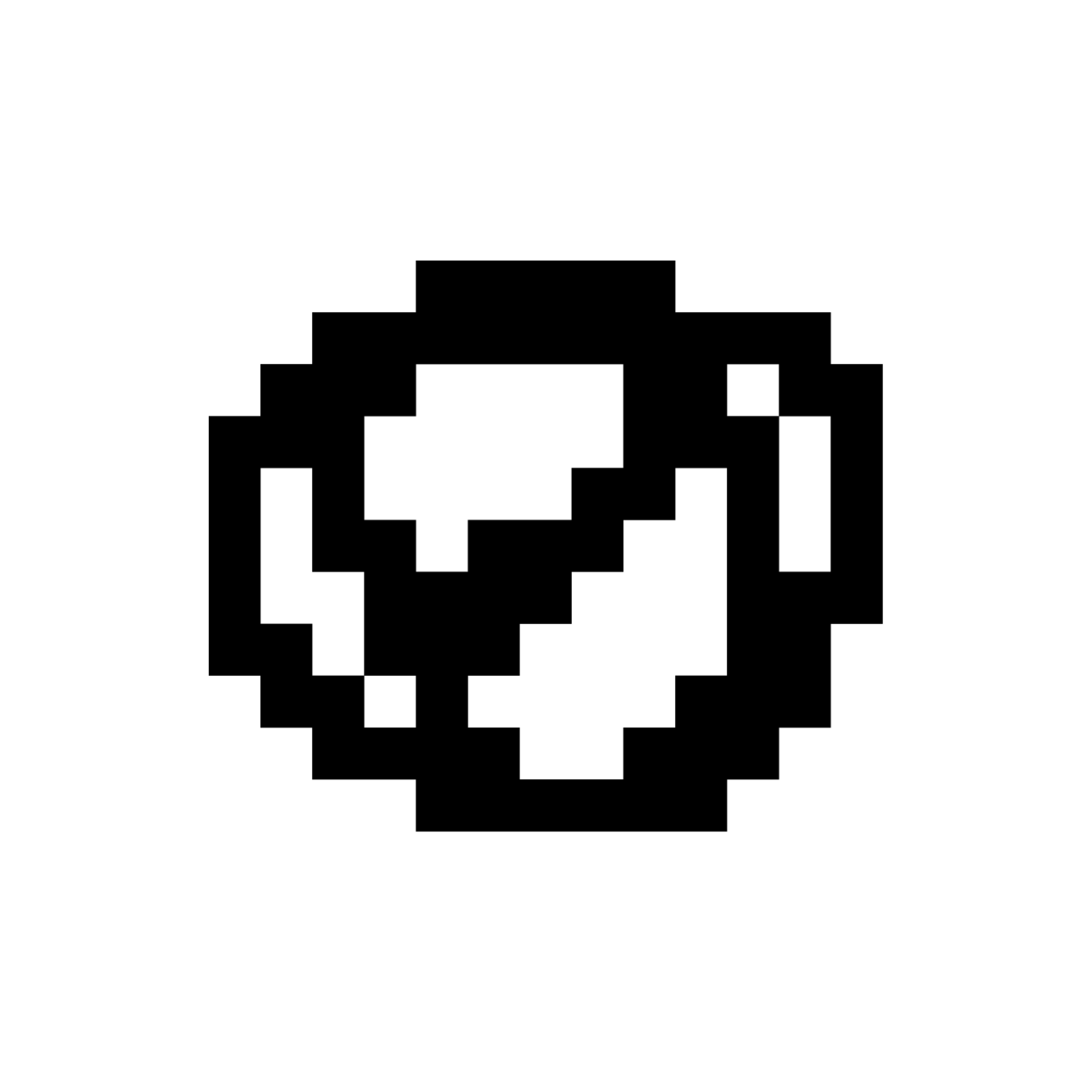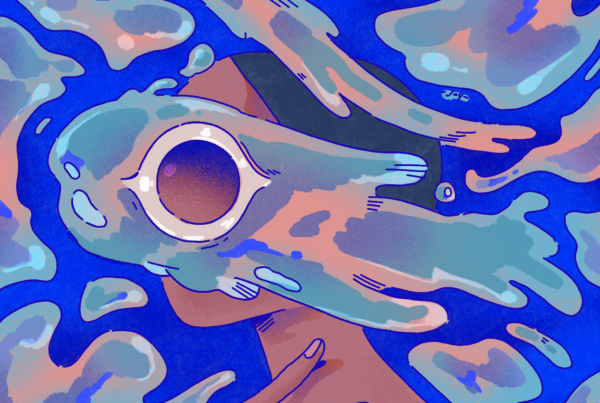L’Orrido
I carlini sono animali orrendi. La Natura tuttavia non crea esseri orrendi, la Natura crea e basta. Non ha categorie estetiche. Non distingue bello e brutto, armonioso o mostruoso: produce forme, vita, varietà. In greco diremmo physis, ciò che cresce da sé. E forse l’orrido del carlino sta proprio in questo: nel non essere stato creato da nessuno ed essere il risultato di anni di incroci e genetica che ne hanno modificato i carratteri fisici.
Questo vuol dire che la natura non può creare quello che noi consideriamo ottimo? No, ma siamo noi a prendere alcune caratteristiche – che hanno determinato le fattezze che contrastano certe nostre categorie estetiche – e associarle a qualcosa di repulsivo.
Tutto ciò che è naturale, è; e come tale scevro da qualsiasi categoria umana. E forse, questa considerazione che abbiamo nei confronti della natura lo si vede nel modo di dire ‘scherzo della natura’, tutto quello che è strano e deforme secondo i nostri canoni, non può mica essere una cosa seria!
Lo scherzo della natura
Nel Rinascimento sono stati condotti i primi studi geologici in montagna. Nel volume De’ corpi marini, che su’ monti si trovano, in un primo momento l’autore Antonio Vasilleri si concentra nella conferma delle teorie dell’epoca, secondo cui i fossili non erano altro che avanzi di antichi banchetti consumati sui monti, animali marini nati da uova inspiegabilmente deposte in altura, oppure tracce lasciate dal Diluvio Universale. E in quanto tali, non potevano esser altro che una burla di quella natura tanto perfetta e quindi incapace di generare simili storture: una sorta di scherzo. Questi scherzi della natura non erano solo conchiglie e fossili. L’espressione ha cominciato a essere utilizzata anche per indicare animali o piante dai caratteri ‘strani’, poco armoniosi, se non addirittura del tutto stonati, rispetto al ‘normale’.
Le cinque categorie dell’orrido
Ho così immaginato 5 canoni che, se presenti e affermati, possono identificare qualcosa come orrido:
Repulsione fisica
Minaccia esistenziale
Deformazione del familiare
Trasgressione culturale
Ambiguità estetica
Prendiamo come caso studio il carlino:
Repulsione fisica: L’orrido agisce innanzitutto sul corpo di chi guarda: il carlino, con il muso schiacciato, gli occhi sporgenti e la respirazione ansimante, suscita spesso reazioni di disagio. Non si tratta di un semplice “brutto cane”, ma di un corpo che, nella sua fisiologia, appare disturbante.
Minaccia esistenziale: Al di là della superficie, il carlino porta con sé un presagio di sofferenza. La sua conformazione anatomica, frutto di una selezione artificiale, implica difficoltà respiratorie, problemi oculari, fragilità ossea. La sua stessa esistenza mette in scena la contraddizione tra l’affetto che suscita e il dolore che incarna, avvicinando chi lo guarda a un orizzonte di morte e malattia.
Deformazione del familiare: Il cane è l’animale domestico per eccellenza, simbolo di fedeltà e compagnia. Nel carlino, però, questa immagine viene deformata: la sproporzione degli occhi, la testa troppo grande, l’assenza quasi totale di muso lo rendono perturbante. È familiare, ma in una forma che tradisce le aspettative di normalità.
Trasgressione culturale: Il carlino sfida le categorie di “bello” e “naturale” che hanno storicamente regolato l’estetica animale. Invece di incarnare l’armonia del corpo in movimento, propone una fisicità segnata dall’anomalia e dalla sproporzione. Il fatto che questa razza sia stata coltivata come simbolo aristocratico e, oggi, come icona pop, evidenzia come l’orrido non sia solo naturale, ma culturalmente prodotto e legittimato.
Ambiguità estetica: Ciò che rende il carlino davvero interessante è la sua capacità di oscillare tra due poli: il tenero e l’orrido. La sua goffaggine, la sua fragilità e la sua aria sofferente lo rendono irresistibile per molti, ma proprio queste caratteristiche suscitano al tempo stesso disagio e pietà. L’orrido del carlino non respinge del tutto: seduce, attrae, invita a un contatto che resta sempre segnato da un’inquietudine sottile.
In questo senso, il carlino diventa una figura emblematica dell’orrido contemporaneo: non più relegato alle catacombe o alle scene macabre, ma infiltrato nel quotidiano, negli spazi domestici, addirittura nei luoghi dell’affetto. È un orrido ambiguo, fatto di attrazione e repulsione, che non allontana ma lega: un orrido che si accarezza.
Vero è che questa griglia, questo modello, potremmo applicarla non solo agli animali, ma anche a una scena, un individuo, un essere, un oggetto, un luogo. Vediamo come funzionerebbe sulla scena di un omicidio di un film. Repulsione fisica: sangue, urla, corpi dilaniati. Minaccia esistenziale: la morte che irrompe davanti allo spettatore. Deformazione del familiare: un salotto normale che diventa teatro di violenza. Trasgressione culturale: violazione di un tabù (uccidere, dissacrare). Ambiguità estetica: l’orrore che diventa spettacolo, fonte di fascino.
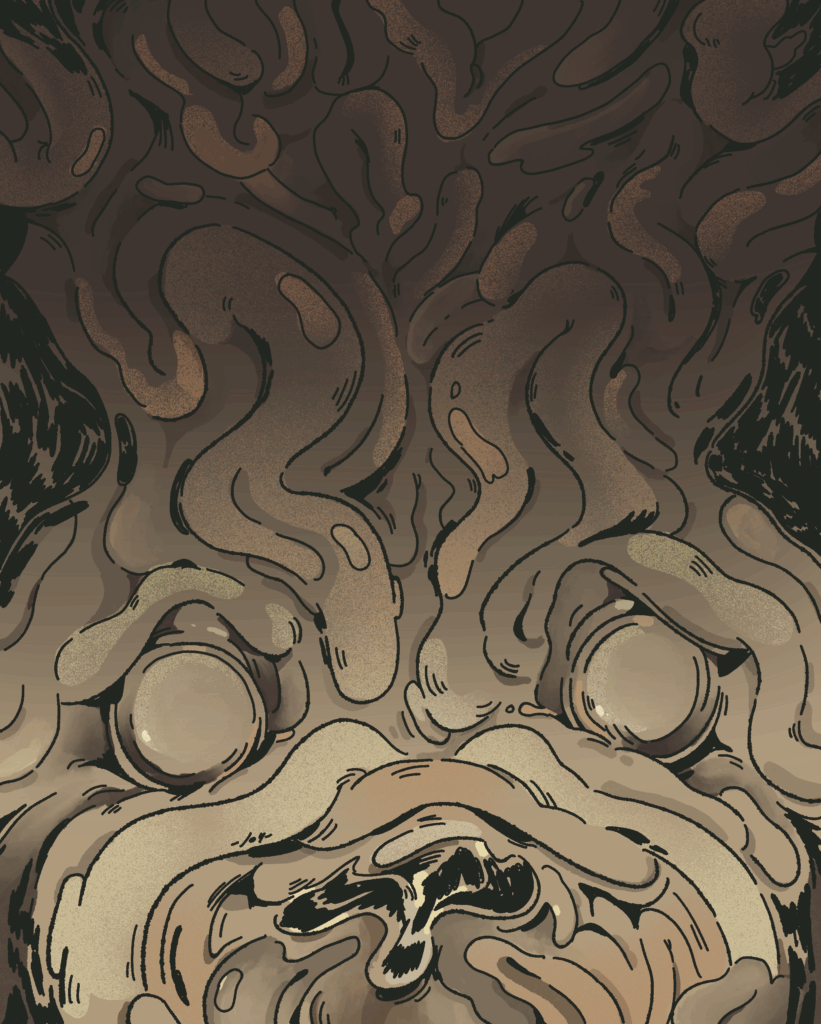
L’orrido nei sensi e nella cultura
Certo, adesso ci stiamo concentrando soltanto sul concetto estetico di orrido, su quello che colpisce la vista. Ma ognuno dei sensi può essere colpito dall’orrido, il disgusto per qualcosa che si tocca o per qualcosa che si assaggia o per qualcosa che si sente. Lovercraft, per esempio, utilizza spesso nella sua scrittura la parola ghastly, orribile, per etichettare i suoni, perché sono suoni che parlano a «oscuri luoghi di coscienza e terrore molto più sottili». Quindi sono suoni con il loro timbro ‘orripilante’ si rivolgono non all’orecchio ma alla coscienza.
Forse la chiave sta proprio nel disgusto. Paul Rozin, uno dei principali studiosi della psicologia del cibo, lo ha definito come un’emozione nata a protezione del corpo da ciò che minaccia di contaminare. È la revulsione di fronte all’incorporazione orale di qualcosa che percepiamo pericoloso o impuro. Ma Rozin mostra anche che il disgusto non è un riflesso universale: ciò che in un contesto appare immangiabile, in un altro è quotidiano. Non è quindi solo biologia, ma apprendimento sociale, tradizione, educazione. Abbiamo visto tutti una volta nella vita i video della preparazione di certe pietanze che i venditori ambulanti in india somministrano agli indiani o ai turisti. La risposta del web è stata fare dei video iperbole dove l’elemento della presa in giro era proprio quello dell’igiene.
Questa intuizione dialoga con l’antropologia culturale di Mary Douglas, che in Purity and Danger scriveva che lo sporco non è una sostanza oggettiva, bensì materia fuori posto. Pulito e impuro non esistono in natura, ma nei sistemi simbolici che le culture costruiscono per darsi ordine. Così il cibo ‘orrido’ – dal formaggio casu marsu in Sardegna, al natto appiccicoso in Giappone, fino agli insetti fritti in Asia – non rivela tanto qualcosa sul cibo in sé, quanto sulle categorie estetiche e morali di chi lo guarda esternamente a quella cultura. Quindi secondo questo punto di vista, ciò che definiamo orrido e con lui tutti gli spettri del suo significato, come il disgustoso per il cibo, vengono ancora scissi, non più in naturale e in artificiale (non creato dalla natura ma dall’uomo) , ma in artificiale e culturale. E così potremmo continuare a sezionare e incasellare l’orrido fino forse a scoprire di arrivare alla sua più piccola unità che è la percezione individuale. Non esiste quindi un Orrido riconosciuto, ma solo perché un senso di orrifico o disgustoso è totalmente soggettivo. Ma di una cosa sono certo, oggettivo o soggettivo, orrido o non orrido, il carlino mi provoca un senso di terrore e repulsione. ♦︎