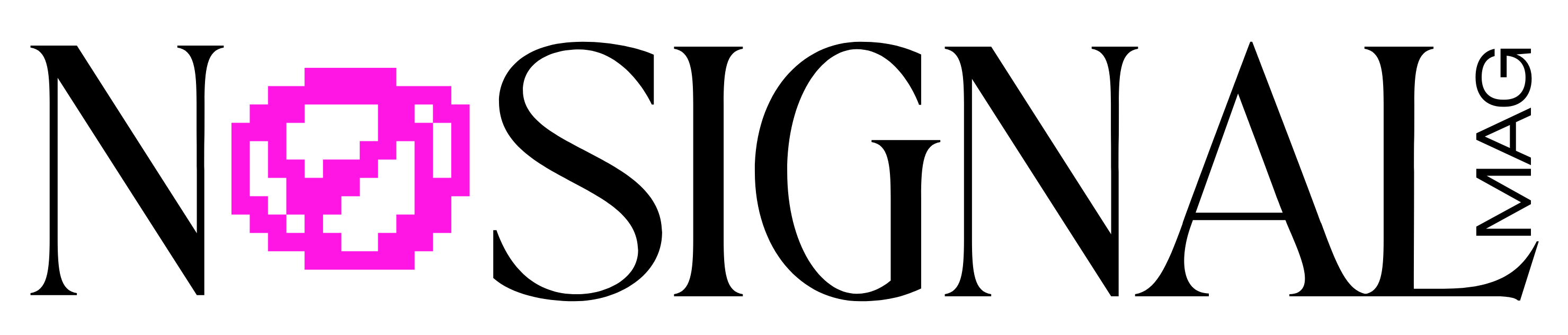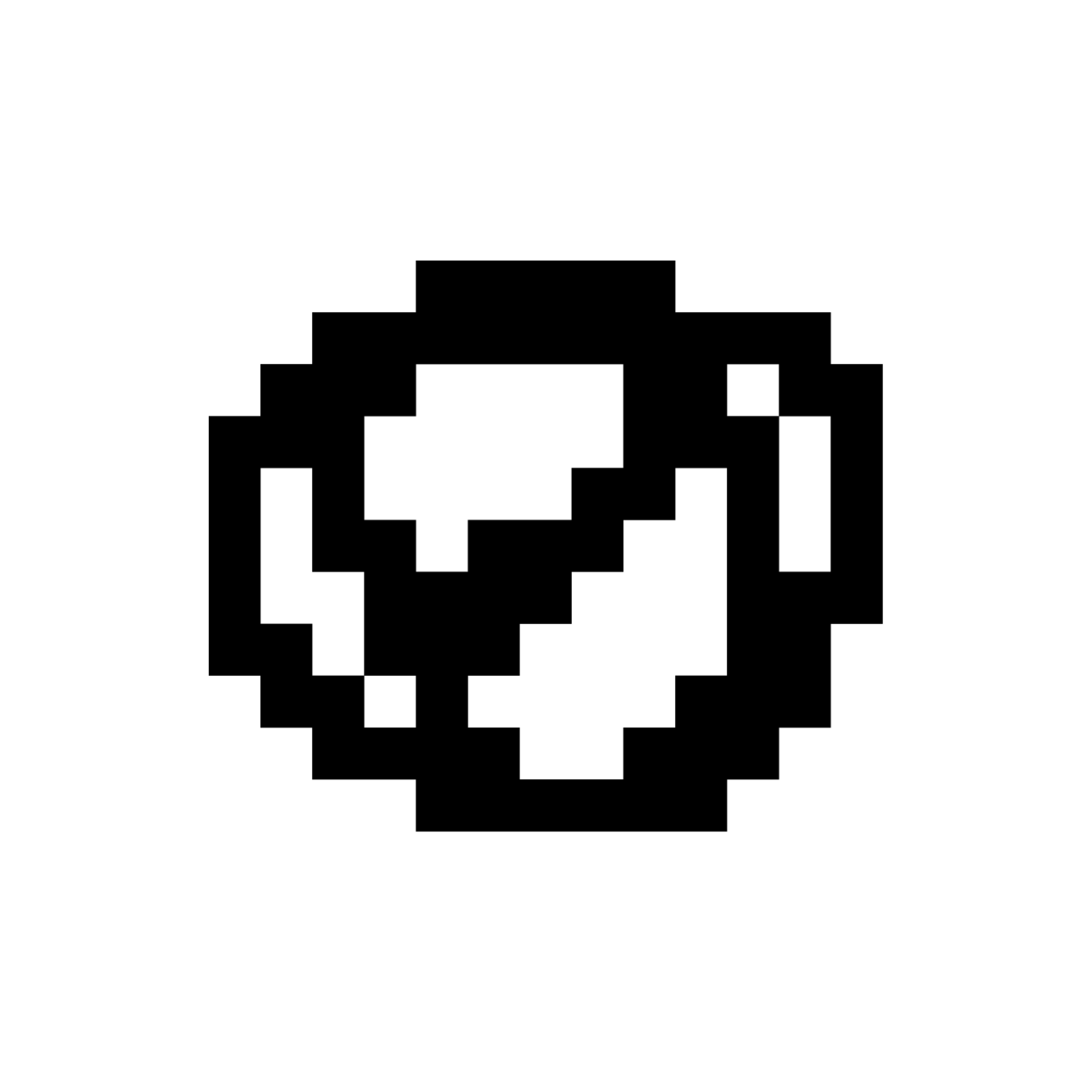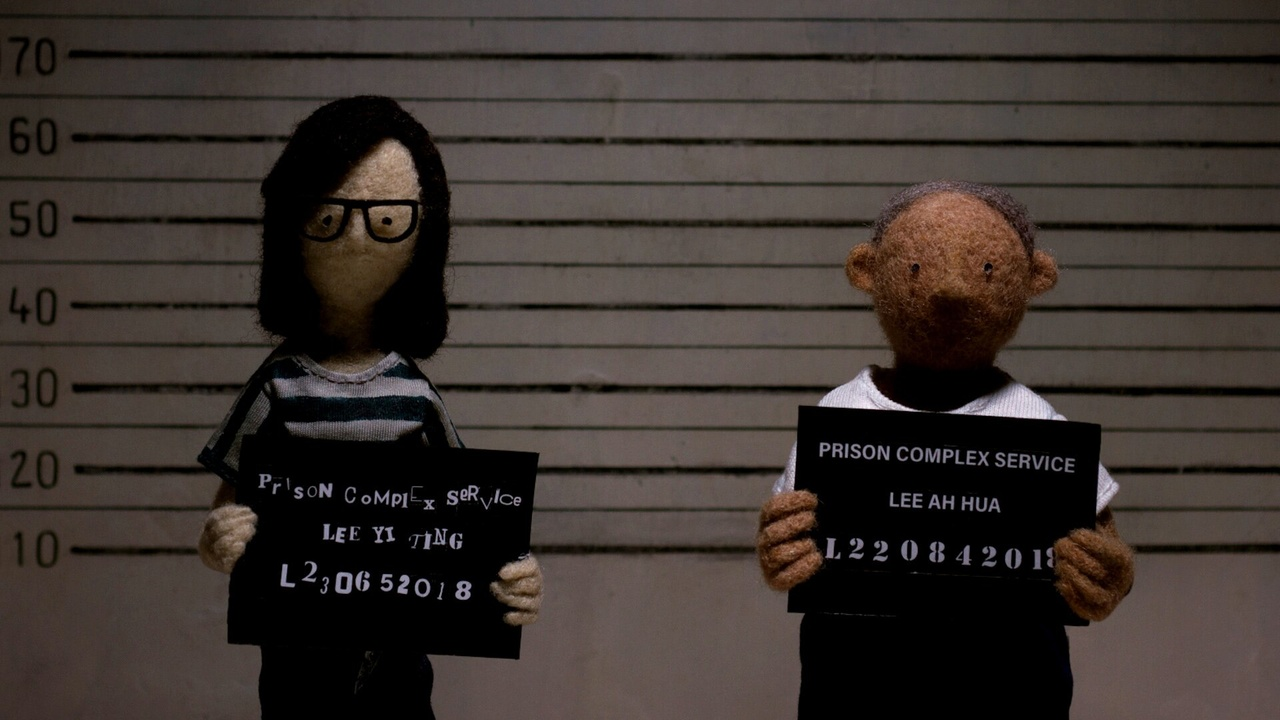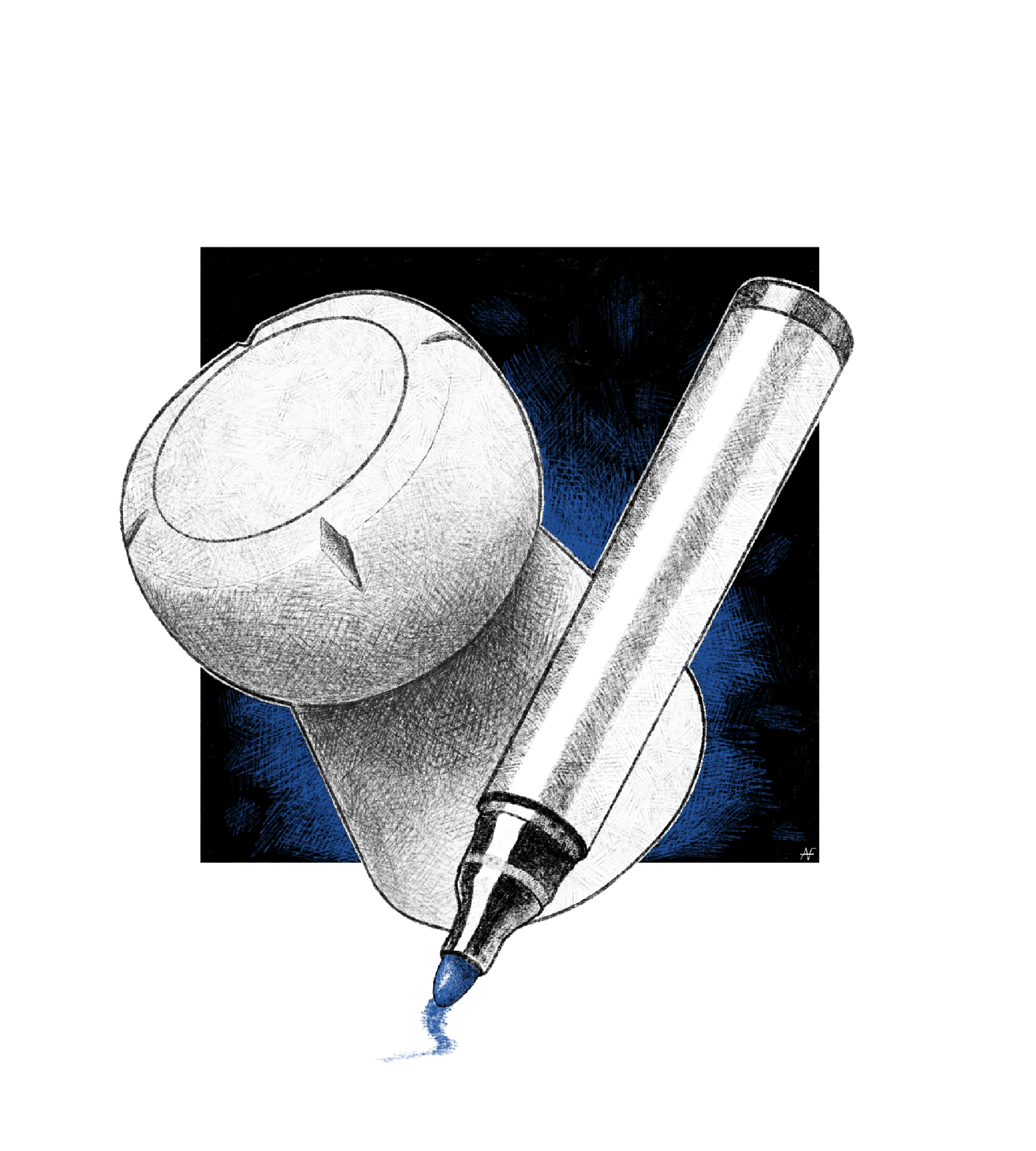Siamo abituati ad associare la parola tecnologia con le più recenti conquiste umane in campo scientifico, elettronico e informatico. Ma il termine racchiude, in realtà, un concetto ben più ampio. La tecnologia accompagna l’uomo fin dalla sua nascita, come recentemente spiegato dal professore Nicola Donti, docente presso l’Università di Perugia. L’essere umano, secondo l’accademico, può essere definito un «animale tecnologico» in quanto ha da sempre dovuto sfruttare questa risorsa per sopravvivere e far fronte alle tante imperfezioni e difetti con i quali la natura lo ha generato.
La tecnologia rappresenta, infatti, qualsiasi ausilio al di fuori del corpo che può essere sfruttato dall’uomo per adattarsi alla vita sul Pianeta, per risolvere i problemi del quotidiano vivere, dal fuoco ai primi rudimentali strumenti realizzati con pietra, legno e ossa. Sotto questo punto di vista, l’intelligenza che permette alle persone di sfruttare la tecnologia può essere paragonata a quella degli altri esseri viventi, anzi si può presumere che, in certi casi, l’uomo abbia trovato talune soluzioni ai suoi problemi proprio osservando il comportamento di altri animali. Si pensi banalmente al reperimento di fonti di acqua e cibo: è probabile che i primi esseri umani si siano resi conto della possibilità di nutrirsi di alcune piante e cereali guardando ad uccelli e altri animali che se ne cibavano. Ma tra i vari difetti intrinsechi nell’uomo vi è la superbia, il desiderio innato di voler dominare sugli altri esseri viventi, umani compresi, e sulla natura stessa.
Questo ha spinto l’essere umano a non accontentarsi delle risorse messe a disposizione dell’ambiente circostante, ma a cercare un progresso tecnologico sempre più rapido e incalzante, mosso da un’inestinguibile sete di potere. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove l’uomo è riuscito a realizzare un’intelligenza complementare a quella naturale: l’intelligenza artificiale.
L’incessante tecnologico ha portato indubbi benefici per l’umanità, ma ha posto e continua a porre numerosi dubbi su quanto sia sostenibile, etico e se non si debba mettere un freno alla sua corsa per evitare che sfugga di mano e si ritorca contro il suo stesso promotore.
Il mito di Prometeo: l’insegnamento degli antichi greci
Ritornando alle parole del professor. Donti, questi propone un interessante lettura di uno dei più famosi miti che gli antichi greci, nella loro lungimiranza, ci hanno tramandato, e attraverso il quale è possibile ricavare una lezione oggi più che mai attuale: la pericolosità di una tecnologia lasciata senza controllo. Nel celebre mito di Prometeo, il Titano che ruba il fuoco agli Dei per donarlo agli uomini viene punito da Zeus, che lo fa incatenare a una roccia nel Caucaso. Guardando al fuoco come metafora dell’intelligenza artificiale, e alle catene come la necessità di porre un freno al progresso, la rilettura del mito di Prometeo ci esorta alla cautela.
Esulando dal dibattito su tecnologia positiva o negativa a seconda di chi la utilizza e come, il punto riguarda gli effetti che l’eccessivo uso della tecnologia ha sulle persone. Si tende a delegare sempre più compiti alla tecnologia, perdendo nel tempo la capacità di eseguirli senza un aiuto esterno. Si pensi, ad esempio, alla capacità di orientarsi, un istinto fondamentale per l’essere umano sin dai suoi albori, oggi sempre più difficile da trovare nelle persone, ormai abituate a farsi guidare da sistemi informatici. Con la creazione di una nuova intelligenza di tipo artificiale, le persone si stanno facendo sostituire dalla tecnologia persino in ambiti e attività ritenuti fino a pochi anni fa imprescindibili dalla presenza umana, come l’arte, la poesia e la scrittura. Un eccessivo demandare funzioni alla tecnologia che rischia di impoverirci e che, forse, andrebbe frenato e rallentato, come ci insegnano i nostri avi.
L’intelligenza artificiale per dominare la natura stessa
L’essere umano, come detto, non si limita a utilizzare la tecnologia esclusivamente per il proprio benessere e per risolvere i problemi dell’esistenza quotidiana. Ritenendosi la specie dominante, la più forte e la più intelligente, l’uomo punta alla supremazia non solo sugli altri individui, ma sull’intera natura che lo circonda, a sottometterla alle sue esigenze piuttosto che limitarsi a trovare soluzioni per far fronte ai limiti che essa gli pone. E spesso lo fa senza chiedersi quanto sia giusto spingersi oltre questi limiti, quanto sia etico e sostenibile per l’ambiente circostante.
Emblematica è l’immagine della copertina del Time che in questa seconda settimana di aprile ha destato l’interesse e il fascino di tutto il mondo (giocandosela con gli spericolati cambi di idea del presidente statunitense): la fotografia di un ‘lupo feroce’, una specie estinta circa 10.000 anni fa. Si tratta di uno dei tre esemplari di questo animale riportati in vita dalla Colossal Biosciences, società di biotecnologie di Dallas il cui principale scopo è scovare DNA di animali estinti e cercare di riportarli in vita.
Il reporter del Time Jeffrey Kluger, al quale è stato concesso di vedere la cucciolata, pur mantenendo il riserbo sul luogo nella quale si trova, spiega che i tre lupacchiotti sono stati creati attraverso tracce genetiche rinvenute in reperti vecchi di 11.000 e 72.000 anni. Il DNA è poi stato manipolato in laboratorio per il 5% al fine di rendere gli animali adatti alla vita sull’odierno Pianeta e permettere una gestazione surrogata degli embrioni all’interno dell’utero di cagne. La Colossal Biosciences ha giustificato il suo operato commentando che, anche e soprattutto a causa dell’uomo, in futuro sempre più specie si estingueranno e le loro ricerche rappresentano, quindi, un tentativo di porre una pezza ai danni che l’essere umano sta causando alla Terra. Ma il fatto che il DNA dei lupi preistorici sia stato modificato e la gestazione sia stata surrogata ha spinto molti esperti a criticare duramente gli esperimenti del colosso statunitense, mostrando i tanti problemi etici che comportano. Alla pari dei dinosauri riportati in vita nei film di Jurassic Park, Romolo, Remo e Khaleesi, questi i nomi dei tre lupacchiotti, non sono in realtà lupi feroci, ma creature artificiali generate dall’uomo in laboratorio. Da questo punto di vista, il metodo proposto dalla Colossal non sarebbe una reale soluzione ai problemi causati dall’uomo alla natura, ma anzi un suo tentativo, ancora una volta, di emularla, di plagiarla a suo piacimento.
Ancora una volta, la questione porta a chiedersi fino a che punto sia giusto spingere il limite dello sviluppo tecnologico e quali siano le implicazioni che questo comporta: oltre ai lupi feroci, quali altri animali potrebbero essere introdotti in natura e come l’uomo potrebbe volerli sfruttare? Quali virus e batteri si rischia di riportare alla luce manipolando DNA custodito in resti fossili di millenni di anni fa? Forse sarebbe più opportuno limitare l’attività umana, l’espansione tecnologica, in modo da prevenire l’estinzione di ulteriori specie, piuttosto che tentare di rimediare a un danno ormai già fatto.
Alcuni studiosi hanno fatto notare come l’uomo tenda a porsi come punto di riferimento anche nel definire gli altri esseri viventi come intelligenti, prendendo a riferimento il concetto di intelligenza umana. Ma quella che per gli esseri umani può essere una scala dell’intelligenza non è per forza valida per altri animali: si tende a ritenere più intelligenti i corvi perché riescono a risolvere problemi, come l’aprire una porta utilizzando un rametto di legno per arrivare al cibo che si trova dalla parte opposta; mentre le galline o i piccioni vengono reputati uccelli dotati di un minore sviluppo intellettivo. Ma che dire dell’organizzazione sociale all’interno di un gruppo di galline e la precisa suddivisione dei turni quando si tratta di mangiare? O dell’incredibile sistema di orientamento dei piccioni viaggiatori e di altri uccelli migratori, il cui segreto ancora oggi non è del tutto chiaro ai ricercatori?
Per non parlare dell’intelligenza all’interno del mondo vegetale, della fitta rete di comunicazione che si sviluppa tra piante che si trovano nella stessa area, spesso del tutto ignorata dalle persone. Pur non parlando, anche loro dialogano, e si muovono pure, ma in modo impercettibile per l’occhio umano. I vegetali abitano questo pianeta da molto più tempo dell’uomo ed è forse a loro che gli esseri umani dovrebbero guardare, fermando la loro corsa sfrenata verso nuove forme di tecnologia e intelligenza che rischiano di rivelarsi incontrollabili, e imparare dalla saggezza delle piante i segreti per adattarsi alla vita sulla Terra. ♦︎