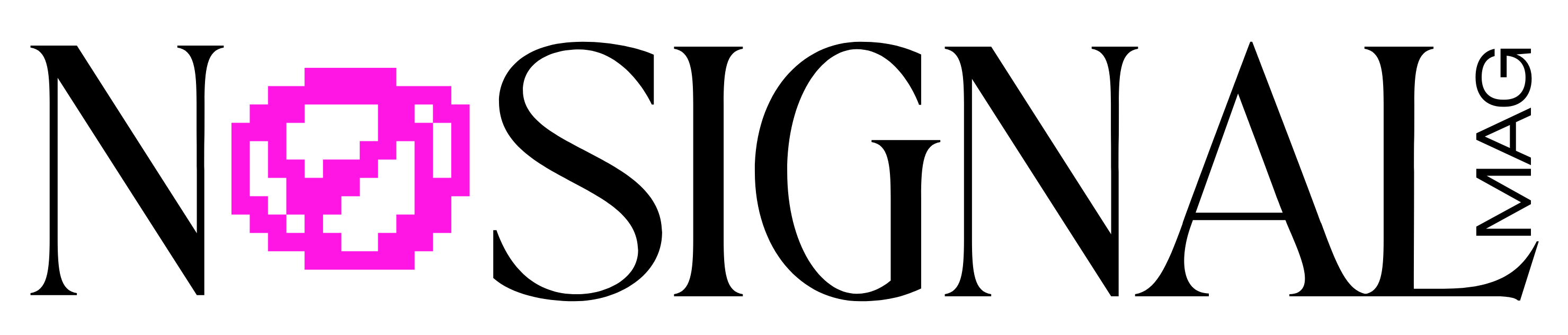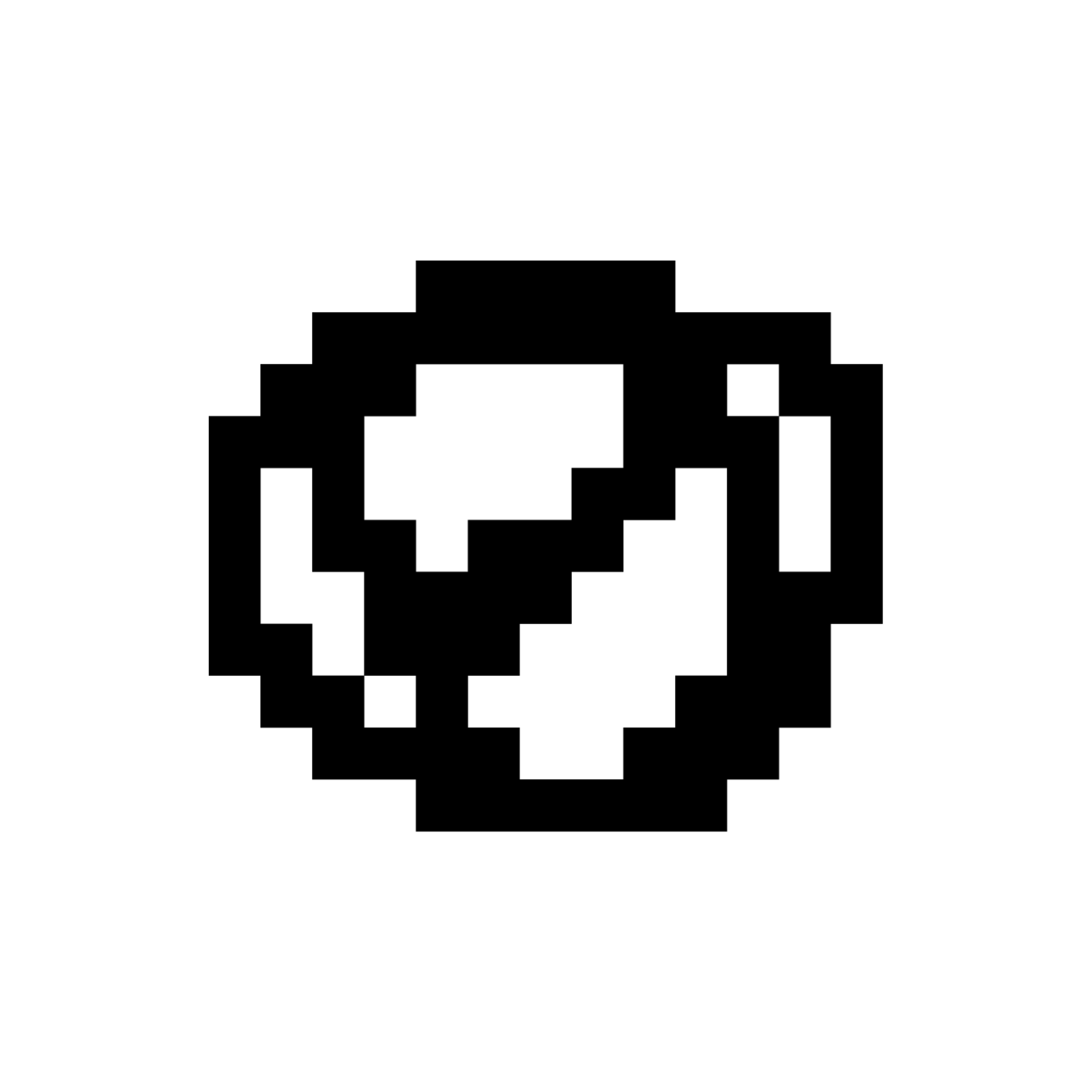Ritratto della migrazione femminile e familiare in Italia, tra legami spezzati e nuove forme di invisibilità.
Tra le stanze di uno sportello immigrazione a Torino si intrecciano le voci di donne migranti – madri, figlie e lavoratrici precarie. A partire dall’incontro con Carolin, arrivata dal Perù con tre figlie e un marito inseguito dalla violenza, questo reportage esplora il vissuto quotidiano della migrazione femminile e familiare. Attraverso testimonianze dirette e il contributo di esperti in etnopsicologia, scienze dell’educazione, sociologia e legislazione italiana in materia d’immigrazione, si indagano le fragilità strutturali dell’accoglienza, le conseguenze psicologiche sui minori e le distorsioni prodotte dalle recenti politiche migratorie italiane. Un racconto che mette al centro la lotta per la dignità e il bisogno profondo di un legame sociale negato.
La prima cosa che noto all’ingresso dello Sportello Immigrazione della Circoscrizione 3 di Torino è che sono tutte donne le persone nella stanza.
Ad accogliermi è Ana, orecchini argento che sembrano conchiglie e un foulard blu elettrico che tiene il ritmo del suo respiro; mi saluta senza allontanarsi dalla scrivania, riempie tutto lo spazio che ha intorno con le vibrazioni della sua voce, con il suo semplice essere lì. A qualche passo da lei, diverse sedie appoggiate alla parete e almeno cinque donne in attesa. Manca ancora mezz’ora all’apertura dell’ufficio. Non potevo mica farle aspettare fuori con questo caldo, dice Ana anticipando la mia domanda.
Le siedo accanto, mi chiede Parli lo spagnolo? Fermami se non capisci qualcosa. Poi un cenno del capo e un sorriso alla prima delle persone in attesa.
La donna che ci si avvicina ha dei lunghi capelli biondi che per tutto il tempo mi domando se siano veri; mostra ad Ana la tessera sanitaria italiana e la carta d’identità dell’Ecuador. È partita dopo che una banda ha ucciso il marito e minacciato lei e i figli di fare la stessa fine. Tra pochi giorni ci sarà l’udienza per decidere se assegnarle il permesso di soggiorno. Dice ad Ana che ha preso il diploma di terza media e trovato un lavoro, chiede quali sono le cose che non deve dire durante l’udienza, Ana sorride e Puoi dire tutto, risponde. Poi nasconde la bocca dietro la mano e aggiunge qualcosa che non capisco. Con l’affitto? chiede quando la donna è già tornata in piedi. Bene, risponde lei, Ho trovato subito un contratto.
È bellissima, mi dice Ana una volta sole, usando una parola che avrei scoperto ricorrente tra le persone conosciute in queste settimane, E poi è bionda, ha la pelle bianca… È per questo che ha trovato subito casa, perché sembra europea.
Ana riporta gli occhi sulle persone in attesa, un altro cenno e, questa volta, sono due le donne che si alzano. È solo una parte della mia famiglia, spiega una di loro avvicinandosi, Ho altre due bambine ma sono a scuola adesso.
È così che conosco Carolin.
La figlia che le siede di fianco ha diciotto anni ma ne dimostra quattro in meno, le altre due ne hanno nove e sei. Da cinque mesi, spiega la donna, vivono in un garage. Nessun bagno, nessuna finestra, niente per riscaldare o raffreddare l’ambiente. Come avete fatto tra novembre e febbraio? chiede Ana; Carolin sorride e alza le spalle.
Lei è stata la prima ad arrivare in Italia, ha raggiunto la madre che lavora come badante fissa di un’anziana signora di Torino. E anche Carolin, come la madre, ha fatto del lavoro di cura il suo mestiere. Mezza giornata però, sennò come faccio con le bambine?
Le due figlie più piccole vanno a scuola, la più grande frequenta un corso di italiano, vorrebbe studiare per diventare infermiera. È il suo sogno, specifica Carolin.
Ripenso a un incontro di qualche settimana prima: donne di varia nazionalità riunite per confrontarsi sulle difficoltà con i figli. Una di loro aveva preso la parola quasi subito. Per mio figlio, aveva detto, qua è tutto razzismo. Cammina per strada, lo ferma la polizia, è razzismo; non riesce a prendere la sufficienza, è perché l’insegnante è razzista. Io non capisco, io sono in Italia da tanto tempo e nessuno mi ha mai discriminata in quanto straniera. Le sue sono scuse.
La parola passa a qualcun’altra, poi a un’altra ancora, finché ognuna di quelle madri in cerchio non ha raccontato la sua su questi figli che non capiscono e con cui non sanno parlare. A quel punto, il conduttore si allontana dalle madri per avvicinarsi alle donne, chiede loro di cosa si occupano ed è la stessa che era intervenuta per prima a parlare. Lo guarda disorientata, poi risponde: Ma come cosa faccio, sono peruviana, che lavoro vuole che faccia?
Era una badante la donna che aveva affermato di non essere mai stata discriminata in quanto straniera. E la sua storia, come la sua professione, era la stessa di tutte le presenti.
Carolin mi racconta che quando ha lasciato il Perù, nel 2022, le sue figlie avevano quindici, sei e tre anni. Mi parla di violenza di strada e organizzata, di mancanza di sicurezza e assistenza sanitaria, di una povertà che cresce ormai senza controllo. Mi dice che è per questo che ha deciso di raggiungere sua madre, partita per l’Italia un anno prima, e di affidare le figlie al marito e a una cugina: perché era il momento di cambiare qualcosa.
Che quella dal Perù verso l’Italia sia in genere percepita come una migrazione buona me lo spiega Roberto Bertolino, esperto di Etnopsicologia della Migrazione e Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di Piemonte e Valle d’Aosta. Il motivo, mi dice, è semplice. Si tratta di una migrazione che coinvolge persone per lo più cattoliche e, se di gerarchia della bianchezza si può parlare, più vicine al bianco. E poi è stata a lungo una migrazione tutta al femminile.
Un aspetto, quest’ultimo, che ha anche un’altra conseguenza fondamentale: perché se è vero che le migrazioni maschili non spostano la catena di cura, è altrettanto vero che quelle femminili lo fanno eccome, modificando l’attribuzione dei ruoli e le funzioni educative e di accudimento. D’altronde per ogni donna che parte, ci sono quasi sempre uno o più figli che restano.
Scopro che la migrazione dal Perù ha iniziato a intensificarsi a partire dal 2016, grazie ad accordi bilaterali tra i Paesi che hanno tolto l’obbligo di visto per l’ingresso in Italia, e che solo dopo la pandemia, con il peggioramento della situazione politica, economica e sociale nel Paese, il fenomeno ha raggiunto dimensioni complesse.
Carolin mi dice che è stata sua madre a consigliarle il mercato del nero – perché nessuno vuole offrirti un lavoro a contratto se non ti conosce, ma a quasi tutti piace far lavorare uno sconosciuto se possono pagarlo di meno; sempre la madre a metterla in contatto con la famiglia per la quale avrebbe lavorato come badante a tempo pieno nei due anni successivi.
E poi di non essere in regola, mi spiega Carolin, non le importava granché: Io pensavo che era per poco, che mettevo da parte dei soldi e ritornavo presto dalle mie bambine. Anche il lavoro a tempo pieno, in questo senso, era un valore aggiunto, un elemento ricorrente in quella che i sociologi chiamano strategia di apnea e che consiste nel ridurre al minimo le spese nel Paese ospitante, per inviare più soldi possibile a casa e velocizzare il tempo necessario al compimento del ritorno – che è un mito molto più che un fatto, perché raramente poi si torna.
Vivere altrove, quindi, come eterno corpo ospite ed eternamente sentirsi in difetto verso chi si è lasciato dietro, dover dimostrare che non si sta tradendo e, soprattutto, che non si è dimenticato dov’è il proprio posto. Che a un certo punto, quasi sempre, diventa in nessun luogo.
Il sociologo algerino Abdelmalek Sayad ha dato un nome preciso a questa condizione: doppia assenza. Assenti là, dove non si vive più; assenti qui, dove non si è mai del tutto ammessi. Uno stato sospeso che si incarna in ogni gesto quotidiano e che il sistema italiano, spiega ancora Bertolino, contribuisce a rafforzare.
I permessi di soggiorno per lavoro infatti non riconoscono la persona, ma il lavoratore. Finché produci, puoi restare. Quando perdi il lavoro, hai sei mesi di tempo per trovarne uno nuovo. Poi diventi “espellibile”.
Quando ho lasciato il Perù, racconta Carolin, le mie bambine erano piccole. Io ho detto lavoro un paio d’anni, metto da parte dei soldi e ritorno. Ma guardando poco a poco la situazione – come lavoravo in Italia, come si stava in Perù dove dopo il Covid è andata sempre peggio – ho cambiato idea, ho deciso di mettere da parte dei soldi per portare qui le mie figlie. Io sono arrivata in Italia il 14 settembre 2022, loro sono riuscita a portarle il 10 giugno 2024. Sono venute accompagnate dalla hostess, perché erano troppo piccole per andare da sole in aereo.
Per essere pronta a ricongiungersi alle figlie, Carolin predispone una serie di cambiamenti nella sua vita in Italia: continua a lavorare come badante ma lascia il posto a tempo pieno per un part time; trova una casa in affitto che possa ospitare tutte e quattro, grazie a un’amica peruviana che fa da tramite e le risparmia quel sottobosco di agenzie di viaggi, sportelli di assistenza fiscale non ufficiali e reti di connazionali che quasi sempre offrono a chi vuole partire dal Perù – o è appena arrivato in Italia – una serie di servizi costosi e spesso inaffidabili o inesistenti.
A dispetto di ogni preparativo, però, l’arrivo delle bambine costringe comunque Carolin a misurarsi col tempo, con la responsabilità di avere qualcuno di cui occuparsi. Sua madre la aiuta come può, ma lavora ancora a tempo pieno e anche per lei le ore, in una giornata, restano quelle che sono. Cinque mesi più tardi, la violenta aggressione subita dal marito di Carolin a bordo del suo taxi rende definitiva una decisione rimandata per settimane: le avrebbe raggiunte anche lui.
Gestire da sola due bambine, mi racconta Carolin, Portarle a scuola, fargli da mangiare e intanto lavorare, era troppo pesante per me, per questo ho detto tante volte a mio marito di venire. Ma lui diceva non lo so, perché per gli uomini è più difficile trovare lavoro qui in Italia. Lui in Perù aveva un taxi. Ma un giorno mi ha chiamata perché lo hanno assaltato di notte, mentre lavorava. Lo hanno ferito a una gamba e gli hanno puntato la pistola qui, alla gola.
Spinge il dito nel punto esatto in cui il metallo doveva aver toccato la pelle del marito, mi mostra delle fotografie, mi dice che ha le prove di tutto ma nessuna denuncia, mi spiega che la denuncia non l’hanno fatta per evitare ripercussioni.
Il 10 dicembre 2024 anche il marito arriva in Italia. La famiglia è finalmente al completo. E la locatrice dà a Carolin un mese di tempo per lasciare la casa in cui vive in affitto con le figlie. Credo che le ha dato fastidio che c’era un’altra persona, commenta lei.
Per un paio di giorni, Carolin e la sua famiglia dormono nella casa in cui lavora la madre. Ma, mi spiega, lì ci sono le telecamere e il figlio della signora ha detto a mia madre che possiamo stare un paio d’ore la mattina, la notte no.
In suo aiuto, allora, interviene un’amica. Conosce una peruviana che può ospitarli nella casa in cui lavora, una cosa di pochi giorni, il tempo di trovare una soluzione.
Dobbiamo arrivare lì alle 21, mi racconta Carolin, Quando la nonita va a dormire. Ci sistemiamo dove ci sono le scarpe, io porto la coperta e il lenzuolo grosso, li sistemo per terra e così dormiamo. Se abbiamo bisogno di andare al bagno, mando un messaggio alla signora peruviana; se la nonita dorme possiamo andare, l’importante è non creare disturbi. La mattina andiamo via alle cinque, prima che la nonita si sveglia. Andiamo nella casa dove lavora mia madre per la colazione, poi le mie figlie piccole vanno a scuola mentre la grande va solo due ore al pomeriggio.
Le chiedo cosa fanno le figlie quando non sono a scuola, mi risponde che girano insieme a lei aspettando le 21. A volte, mi dice, si addormentano sulla panchina perché dopo la scuola sono stanche.
La soluzione che doveva arrivare in qualche giorno, Carolin la sta cercando da mesi. Sei, per l’esattezza. Sei mesi in quella che per lei è la stanza delle scarpe, per me un ripostiglio largo abbastanza da ospitare una sola persona in piedi. E in cui loro dormono in cinque.
Durante la settimana, continua Carolin, lava le figlie strofinandole con un panno umido ma senza sapone. Il sabato e la domenica, nella casa in cui lavora la madre, sono giorni di doccia per tutti.
Che situazioni come questa siano decisamente meno rare di quanto immagino me lo spiega Claudia De Coppi, educatrice del Gruppo Abele che lavora nell’ambito del progetto NOMIS – Nuove Opportunità per Minori Stranieri, cofinanziato da Compagnia di San Paolo.
Mi riferisce che ciò che più preoccupa è l’aspetto evolutivo di minori che, vivendo in condizioni di degrado, non hanno garantite le condizioni necessarie per una crescita evolutiva adeguata, rispetto ai ritmi sonno/veglia, all’alimentazione e alla stabilità dei genitori che garantisce la loro stabilità emotiva, matrice necessaria per la realizzazione di percorsi scolastici e non solo congrui al loro sviluppo.
Mi parla delle tre bambine che segue, vissute per mesi pellegrine da una casa a un’altra, sporche, che dormono ovunque, spesso anche a scuola; di un bambino affetto da una grave forma di ADHD che la neuropsichiatria ha impiegato mesi a prendere in carico e per cui NOMIS ha dovuto pagare un neuropsichiatra infantile privato.
Mi spiega come i figli coinvolti nel processo di migrazione subiscano un numero incredibilmente alto di microtraumi, mi dice: Ci dimentichiamo troppo spesso che i bambini e le bambine di oggi sono gli uomini e le donne di domani. Che tutto quello che trascuriamo oggi, domani saremo costretti a curarlo.
Torno alle parole di Carolin: Le mie bambine non sono abituate a questo, sono abituate a una casa, a un letto. Ripenso a quello che Bertolino mi ha reso evidente: Molti dei ragazzi e delle ragazze che arrivano in Italia per ricongiungersi alle madri si trovano a vivere in condizioni per molti versi peggiori rispetto a quelle del Paese che hanno lasciato, si scontrano con una realtà lontanissima dall’immaginario di benessere che avevano sviluppato. Trovo un senso a quel doppio lutto con cui, ha detto De Coppi, questi ragazzi devono fare i conti: il primo avvenuto anni prima, alla partenza della madre, il secondo che si compie nel momento in cui, per ricongiungersi alla madre, lasciano chi li ha cresciuti al suo posto.
Tutto questo, spiega ancora De Coppi, Si verifica di solito durante l’età evolutiva dei figli, crea ferite che nel tempo si cicatrizzano ma non guariscono mai davvero. Ed è ciò su cui dobbiamo ragionare, su cui il pubblico dovrebbe ragionare.
Chi arriva in Italia, poi, trova una madre con un ruolo sociale molto svalutato, che vive in contesti abitativi precari e asfissianti, di cui non riconosce l’autorità e con la quale manca completamente una consuetudine relazionale. Tutto ciò produce forti conflitti e un importante disagio intrafamiliare, perché queste donne hanno accettato una vita di sacrificio radicale solo per potersi un giorno riunire con i figli, ma quando i figli arrivano scoprono che non le considerano, che non riconoscono la loro autorità, che non le comprendono. I litigi sono frequenti quasi quanto i silenzi e questo genera una crisi profonda, che è anche uno sguardo diverso su tutti gli anni di vita precedenti. Si finisce per chiedersi a cosa è valso tutto quello che c’è stato prima di quel ricongiungimento.
Il conflitto con i figli, però, genera anche una interessante dinamica di svelamento.
Secondo Sayad, lo stigma produce sempre una reazione e la prima, di solito, è proprio quella di assumere lo stigma come identità – per esempio, a ogni nazionalità il suo mestiere. Questi ragazzi rivendicano invece la non volontà di occupare la posizione sociale dei genitori, ai quali rimproverano di essersi lasciati piegare dalla migrazione. Luca Queirolo Palmas, in Il fantasma delle pandillas, afferma che molti dei ragazzi che arrivano in Italia per ricongiungersi alle madri rispondono alla doppia assenza dei genitori con una doppia presenza: non solo vivono in questo Paese ma si appropriano dei suoi spazi pubblici. E questo è particolarmente evidente nel fenomeno delle pandillas – le cosiddette baby gang – e in quella paura che si prova a passare in certi parchi per la presenza di questi gruppi di ragazzi dai giubbotti molto visibili.
Una iper-presenza giovanile, quindi, che nasce in risposta al modo subalterno con cui igenitori si sono inclusi nella nostra società.
Genitori che, peraltro, subiscono molto meno dei figli le conseguenze dell’essere migranti irregolari: se i primi sono infatti facilitati nell’inserimento nel mercato del lavoro in nero che vuole sottopagarli, i secondi si trovano completamente bloccati – possono frequentare una scuola ma non conseguire il diploma di maturità, possono giocare a calcio in un cortile ma non in una squadra perché non possono essere tesserati.
C’è insomma un vero e proprio aspetto regressivo della migrazione che colpisce tutti questi ragazzi e queste ragazze che nel loro Paese vivono l’adolescenza, il tempo in cui una persona inizia ad acquisire più libertà, e che in Italia si ritrovano catapultati in un contesto in cui le autonomie appena conquistate non sono più spendibili, in città che non sanno abitare, in cui si parla una lingua che non possiedono e si vive secondo codici sociali che non conoscono. A questo si aggiunge il fatto che molti di loro, al momento della partenza, sono prossimi ai diciotto anni e quindi alla conclusione del percorso scolastico e all’ingresso in università, ma in Italia vengono quasi sempre assegnati a una seconda superiore con dei compagni molto più piccoli.
Immersi in una realtà in cui faticano a inserirsi, di fronte a una madre che per le caratteristiche del lavoro che fa riesce a essere poco presente – per cui all’assenza fisica si sostituisce un’assenza relazionale – e alla quale non riescono ad attribuire un’autorità genitoriale, questi ragazzi si scoprono soli. Ed è un grande tema l’effetto psichico che tutto questo ha su di loro.
Laura Furno, avvocata dell’Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione (ASGI), mi spiega che a peggiorare notevolmente la situazione, in Italia, è stata l’introduzione di un nuovo decreto – firmato dal Ministro dell’Interno Piantedosi – che ha cambiato radicalmente le regole sulla cosiddetta protezione speciale, quel tipo di permesso che protegge chi non ha ancora un lavoro ma non può essere rimandato nel Paese d’origine.
Il Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20, noto come “Decreto Cutro”, convertito in legge due mesi dopo, continua Furno, ha ristretto i criteri: ha eliminato alcune tutele fondamentali e ha reso molto più difficile trasformare quel permesso in un contratto di lavoro stabile. Con conseguenze durissime su un numero spaventosamente alto di ragazze e ragazzi figli della migrazione e prossimi alla maggiore età, che sentono adesso di avere un futuro ipotecato, di essere spossessati dell’avvenire e iniziano in molti casi a manifestare sintomi di isolamento, apatia, ritiro sociale.
Bertolino mi racconta che la Frantz Fanon, Associazione torinese impegnata nello sviluppo di interventi clinici nel campo della salute mentale dei migranti, segue moltissimi di questi ragazzi e queste ragazze e che i loro sintomi sono gli stessi che in Svezia segnano l’inizio della Sindrome da rassegnazione: giovani che in risposta alla consapevolezza di non poter appartenere a nessun luogo, entrano in una condizione apatica sempre più radicale fino a sviluppare coma dal punto di vista neurologico.
Fuori dall’Italia ci sono ragazzi, mi spiega Bertolino, che stanno in coma anche sette – otto anni. Quelli che si risvegliano, raccontano di aver continuato a percepire tutto anche durante il coma; e in effetti sono tantissimi gli studi che mostrano come un clima familiare di speranza influenzi i tempi di ripresa, così come un maggiore coinvolgimento dei figli nelle procedure di regolarizzazione della condizione migratoria della famiglia rende più frequente l’insorgere dei sintomi tipici di questa sindrome.
Una caratteristica ricorrente della migrazione, d’altronde, è che i figli diventano presto più socialmente competenti dei genitori e si ritrovano a fare da mediatori tra la famiglia e l’esterno – per esempio, sono spesso loro a dover leggere e tradurre il decreto di espulsione ai genitori.
Guardando all’Italia e a quelle che lo stesso Bertolino conferma essere forme sempre più diffuse di ritiro sociale, non si può non riconoscere una fase embrionale di Sindrome da rassegnazione.
Sindrome perfettamente descritta dalla regista Dea Gjinovci nel docufilm Wake up on Mars, che racconta le vicissitudini di una famiglia kosovara in Svezia: due figli in coma, vittime della suddetta sindrome, e il figlio più piccolo che coltiva il sogno di svegliarsi su Marte e trovare un mondo migliore.
Il documentario è scandito proprio dal lavoro di questo bambino per costruire la sua navicella spaziale – lavoro per il quale la Gjinovci ha coinvolto degli amici artisti francesi, anche se nel documentario questo non è mostrato. La cosa interessante è che la regista racconta che quando ha iniziato a seguire questa famiglia, il figlio più piccolo stava a sua volta iniziando a sviluppare sintomi di apatia e rassegnazione e che il documentario è stato un percorso non solo di rappresentazione ma anche di cura. Lo stesso bambino le ha detto: Il brutto è che nessuno ci guardava, tu hai fatto sì che gli altri ci guardassero.
È sempre Bertolino a mostrarmi come, quando si parla di migrazione e in particolare di salute mentale legata al tema della migrazione, non c’è alcuna distinzione tra medicina e politica.
Non puoi parlare della salute mentale di queste persone, mi dice, senza parlare anche di politica. E non mi riferisco alla politica di partito, ma all’ordine politico del discorso. La sofferenza psicologica di questi ragazzi e queste ragazze è una sofferenza politica. Sono quelle che potremmo chiamare le patologie della cittadinanza, o meglio della non cittadinanza.
In loro il disagio psichico coincide spesso in buona parte con il disagio politico, a cui rispondono in vari modi: alcuni con lo sviluppo di sintomi psichici, alcuni con forme di rivendicazione sociale che passano anche attraverso manifestazioni che, senza spogliarle della loro rilevanza penale – perché se mi spacchi la faccia e mi rubi il cellulare, mi hai spaccato la faccia e rubato il cellulare -, hanno una fortissima componente espressiva di ordine politico.
E un lavoro di cura che psicologi e psichiatri tentano di fare con molti di questi ragazzi è proprio quello di ripoliticizzare la sofferenza, evitare che diventi una sofferenza puramente individuale.
Io posso anche, semmai ci riesco, farti essere meno depresso, continua Bertolino, ma se il problema è che tu non hai il permesso di soggiorno, sarai sì un po’ meno depresso ma sempre senza diritto ad appartenere. E allora io trovo molto interessante che questo nuovo spaccato di migrazione e le difficoltà che questi ragazzi vivono in Italia consentano di leggere in modo più netto, più chiaro, più trasparente l’ordine politico della loro sofferenza e ci facciano capire come la vera questione sia come costruire un legame sociale. Perché l’unica alternativa a questi ordini di sofferenza – e anche a quelli di devianza – è la costruzione di un legame sociale, difficile di per sé nella migrazione ma radicalmente di più se si parla di soggetti non riconosciuti e quindi illegittimi sul nostro territorio.
Chiedo a Carolin come stanno le sue figlie. Mi risponde che all’inizio si lamentavano di non avere una casa ma lei ha spiegato loro che una casa la avranno, che serve solo un po’ di pazienza.
E hanno capito? domando.
Sì, hanno capito, risponde, Ho chiesto se vogliono tornare in Perù. Ho detto che se loro dicono che vogliono tornare, io lavoro e ritorniamo insieme. Le più piccole mi hanno detto che no, che a loro piace andare a scuola qui, che gli piace la maestra, che in Perù c’era troppa paura sempre e sono contente di stare in Italia.
Le sue bambine hanno nove e sei anni.
Tu come ti senti? le chiedo ancora.
È la prima volta, da quando abbiamo iniziato a parlare, che la vedo piangere.
Dura pochi secondi, si passa con impazienza le mani sugli occhi. Scusa, mi dice.
E poi: È da due settimane che sto molto male, però è così, capisco che deve essere diverso. Bisogna combattere per una vita migliore e io ho le mie figlie per cui combattere. Loro sono contente perché stare qui con la mamma e il papà è diverso che stare sole in Perù. E io mi sento contenta di stare qui, di lavorare. Mio marito ha anche lavorato quattro giorni in un magazzino, lo hanno pagato in nero, ma appena arriva il permesso di soggiorno sarà meglio. Per l’uomo è un po’ più difficile. Ma lui spera. E dobbiamo avere pazienza. Siamo stanchi, sì. Ma sappiamo che questo è solo momentaneo.
Carolin sorride, mi chiede se c’è altro che voglio sapere, mi spiega che è quasi ora di prendere le sue figlie a scuola. Torna in piedi e lo stesso fa la figlia che le sedeva a fianco. Io vado, ciao, mi dice Carolin. La figlia china un po’ la testa su un lato, mi tende la mano, stringe la mia con delicatezza.
Grazie, mi dice mentre la madre cammina già verso l’uscita. Mi accorgo che è la prima volta che la sento parlare. Non riesco a frenarmi dal chiederle Tu come stai?. Una domanda banale, e insieme l’unica possibile. Una domanda che, dall’espressione che mi rivolge, penso non le abbia ancora rivolto nessuno. E su cui sospetto non si conceda di interrogarsi neanche da sola.
Per un tempo che mi sembra lunghissimo, lei fissa i suoi occhi asciutti e di un castano intenso nei miei, poi sorride e alza le spalle. Carolin la chiama dalla porta d’uscita, lei si volta senza dire nient’altro. ♦︎