La vita nel campo di lavoro
Come anticipato, il viaggio pare condurre le persone verso una sempre maggiore umanità e un miglioramento costante, se così si può definire, della loro condizione. Benchè si tratti sempre di un campo di lavoro, i prigionieri sono, infatti, trattati, da un certo punto di vista, meglio rispetto ai carceri delle città. Anche il campo, dunque, non è immune dalla trasformazione che si percepisce mano a mano che ci si immerge maggiormente nella natura e che ci si distacca dalla civiltà. Lo stesso colonnello a capo del campo, tale Ushakov, e, ancor più, la moglie, paiono compatire i prigionieri e quasi provare amarezza per la loro misera condizione. Ovviamente, trattandosi di un ambiente ancora contaminato dall’uomo e dalla società sovietica, contro la quale il racconto di un ex deportato non può che scagliarsi, anche all’interno del campo 303 vi è chi è rimasto fedele al regime e a tal punto corrotto da questo da perdere la sua umanità. La figura che incarna maggiormente questi difetti è il secondo comandante del campo, il cui nome non viene neppure citato dall’autore, con la giustificazione di non essere rimasto impresso nella sua memoria, ma da tutti i prigionieri riconosciuto come il Politruk. Dalle sue parole traspare chiaramente l’ideologia del regime dittatoriale e la considerazione che lo stesso ha della natura umana: “guardatevi, sembrate degli animali”, afferma il comandante rivolgendosi ai prigionieri. Quindi prosegue ironizzando sul fatto che i polacchi ritenevano di essere un popolo civilissimo e affermando che all’interno del campo, sotto la guida del compagno Stalin sarebbero progrediti, divenendo buoni cittadini. Ai deportati viene, infatti, concessa la possibilità di seguire delle vere e proprie lezioni che, a detta del Politruk, avrebbero fatto cambiare loro mentalità: tradotto, il sistema li avrebbe corrotti.
In questo ossimoro, l’autore rende molto bene l’idea di quanto il regime denaturalizzi l’uomo e distrugga la civiltà, malgrado ritenga all’opposto di favorirla.
Ma, come detto, i capitoli nei quali viene descritta la vita all’interno del campo di lavoro sono gli ultimi nei quali si percepisce un certo dominio dell’uomo sull’ambiente naturale e dove si vede una società più evoluta e corrotta. Dal momento della fuga, gli evasi si immergono completamente nella natura e, anche per dovuta precauzione, per lunga parte del viaggio evitano il contatto con l’ambiente civilizzato, per cui il paesaggio naturale incontaminato è l’assoluto protagonista e la natura ha il sopravvento, nel bene e nel male. È da essa, infatti, che dipende la sopravvivenza dei fuggiaschi.
Il lungo viaggio: l’uomo a diretto contatto con la natura selvaggia e la civiltà che permane
Una volta abbandonato il campo, i fuggitivi si immergono completamente nella natura e ad essa, e alle sue “variazioni di umore”, sono costretti ad appellarsi per sopravvivere.
L’ambiente cambia costantemente durante un viaggio di miglia e miglia e i sette uomini devono adattarsi alle sue variazioni, passando dal freddo pungente della foresta siberiana, al caldo opprimente del deserto del Gobi, per tornare al freddo delle cime Himalayane. Anche il terreno sul quale si muovono cambia repentinamente aspetto, rallentando talune volte e favorendo tal altre il loro peregrinare, con fiumi da guadare e montagne da scalare. Ma, allo stesso tempo, la natura offre ripari, siano essi fitti boschi o vere e proprie grotte, oltre che cibo per sfamarsi e acqua per dissetarsi e lavarsi, gli stessi che possono, in altri casi, trasformarsi in pericoli e difficoltà, come l’episodio dello sciame di locuste o il diluvio incontrato appena varcato il confine mongolo. Non è, quindi, un percorso caratterizzato costantemente dall’agonia quello dei sette fuggitivi, ma vi sono sporadici momenti nei quali i prigionieri possono addirittura godersi il viaggio. La parola “tetro”, così sovente incontrata nei primi capitoli tanto da essere uno degli aggettivi più caratterizzanti le descrizioni, non compare praticamente mai nella parte di racconto che riguarda il viaggio dopo la fuga dal campo. Ed è, come affermato, nell’ambiente naturale e nelle persone che sono rimaste maggiormente a contatto con esso, che i fuggiaschi troveranno il maggior livello di civiltà e altruismo, partendo dal boscaiolo incontrato nei pressi del lago Bajkal, quando ancora si è in territorio russo e la paura di essere scoperti e catturati è alta, passando ai nomadi mongoli che si incrociano una volta varcata la tanto sospirata frontiera, fino ad arrivare ai più sparuti villaggi e ai pochissimi esseri umani che si possono scorgere tra le vette Himalayane. Malgrado innumerevoli culture diverse, con lingue incomprensibili e usanze, spesso, inconsuete, tutte queste persone, rimanendo maggiormente vicine alla natura che le circonda e meno influenzate dal progresso della civiltà moderna, dimostrano come l’uomo a contatto con l’ambiente naturale non sia, in realtà un barbaro incivile, ma, all’opposto, conservi una certa innocenza primordiale che lo porta a vivere sereno e ad essere altruista con i suoi simili, seppur stranieri e poco presentabili come dovevano apparire gli evasi. In tutti i riferimenti agli incontri fatti con gli abitanti dei diversi luoghi toccati durante il viaggio, anzi, viene sottolineata la gioia provata dalle persone nel poter offrire un aiuto a quegli esuli pellegrini. Chiarisce bene e con poche parole questa caratteristica delle genti mongole e tibetane la frase pronunciata da un circasso che i prigionieri incontrano appena approdati in Tibet, il quale afferma che non serve parlare la stessa lingua in quei territori, ma è sufficiente fare un inchino a un tibetano e attendere la sua reazione: se questi ricambia il gesto, null’altro è necessario per essere considerati dall’uomo degli amici e godere della sua ospitalità.
Una maggiore sintonia e un fortissimo legame di altruismo si creano e si consolidano, man mano che si prosegue nel viaggio, anche fra gli stessi sette fuggiaschi. Scontato, si potrebbe affermare, per delle persone che devono affrontare insieme una tale impresa. Ma non si può, tuttavia, non riconoscere come la vita al di fuori della società e a maggior contatto con l’ambiente naturale, con tutti i problemi e le difficoltà che comporta, abbia contribuito a far nascere nei sette pellegrini questo sentimento di comunione e fratellanza. Sentimento che non è favorito solo dai momenti piacevoli e spensierati del cammino, nei quali gli ex prigionieri possono finalmente concedersi il lusso di rilassarsi ed essere sereni, ma, ancor più, dalle insidie che la natura pone loro di fronte. Non è, infatti, sufficiente superare la frontiera e approdare in terra mongola, per sentirsi sollevati e procedere nel viaggio in tranquillità. Gli elementi continuano ad infuriare sui sette, come se la natura li volesse perseguitare, senza mancare anche di ironia. Se nella foresta siberiana il gelo era il nemico peggiore e i fiumi un impedimento da attraversare, nel cambiamento di paesaggio, inoltrandosi nelle lunghe pianure mongole fino a giungere al deserto del Gobi, i corsi d’acqua diventano un miraggio, un sogno al quale aggrapparsi per resistere alla sete e all’arsura. Gli esuli devono passare, quindi, da un inferno di ghiaccio ad uno di fuoco, senza cibo e senza riserve idriche. La natura non è presentata come un male corrotto quale la società civile sovietica, ma la sua ostilità verso l’uomo è, in tutta la seconda parte della narrazione, assai evidente e rende la vita dei fuggitivi misera e acerba, quasi al pari delle torture delle prigioni russe. Non tutti sopravvivranno a questa prova e la morte accompagnerà anche al di fuori della società i prigionieri.
Tuttavia non traspare mai una visione negativa della natura: essa fa semplicemente il suo corso.
Non si può neppure affermare che il distacco dalla civiltà e dalla società sia totale. Gli uomini, pur vivendo per mesi lontano da città e paesi e immersi nella natura incontaminata, non si fanno mancare sporadici incontri con gli abitanti di piccoli villaggi o con i pescatori cinesi che navigano lungo i fiumi mongoli a bordo delle sampan, e non si tirano indietro dal tentare, ogni volta, di socializzare e comunicare con loro: il rapporto umano permane sempre. Come permane anche un certo contatto con la civiltà lasciata alle spalle dai fuggitivi, a dimostrazione del fatto che l’autore non si pone l’obiettivo di criticare la società in generale, ma unicamente il regime staliniano. Un bellissimo esempio di quanto sostenuto lo si ha durante l’incontro tra i sette ex prigionieri e una famiglia di mongoli, la quale dona ai pellegrini del tabacco e un intero giornale, una recente copia della Stella Rossa, per poterne arrotolare delle sigarette. Lasciati allontanare i generosi mongoli, i sette uomini si fiondano tutti attorno al quotidiano e lo leggono avidamente, dato che erano mesi che non potevano avere notizie della Russia e del mondo nel quale vivevano prima di essere deportati. Dimostrazione del fatto che in loro permane un interesse e un attaccamento alla vita precedente.
Una trattazione completa quella che emerge fra le righe del romanzo di Rawicz, nella quale il tema del rapporto fra uomo e natura e uomo e società, per quanto possano pesare le influenze dell’esperienza da deportato dell’autore, viene proposto nelle sue innumerevoli sfaccettature e che, grazie alla stessa esperienza del viaggio, permette di confrontare e far risaltare bene le differenze fra i diversi modi di vivere dell’uomo all’interno dei due ambienti.
Un interessante spunto ancora oggi, in mondo sempre più complesso ed evoluto tecnologicamente, ad imparare ad apprezzare non solo il ritorno alla natura, condizione che già si sta diffondendo sempre più negli ultimi tempi, ma soprattutto la semplicità di genti e culture che dall’evoluzione sono rimaste lontane e dalle quali le società sviluppate possono imparare ancora molto, guardando a loro non con occhi “occidentali”. E in conclusione di questa trattazione pare perfetta, a coronamento del pensiero dell’autore, la frase detta da uno dei sette fuggiaschi, il lituano Marchinkovas, quando ormai il loro viaggio stava per giungere al termine, parlando delle persone incontrate in Mongolia e in Tibet, e riferendosi proprio, in particolare, alla loro ospitalità: “Questa gente mi fa sentire molto umile. Il loro comportamento aiuta a cancellare l’amaro ricordo di altri che hanno perso ogni rispetto per l’umanità
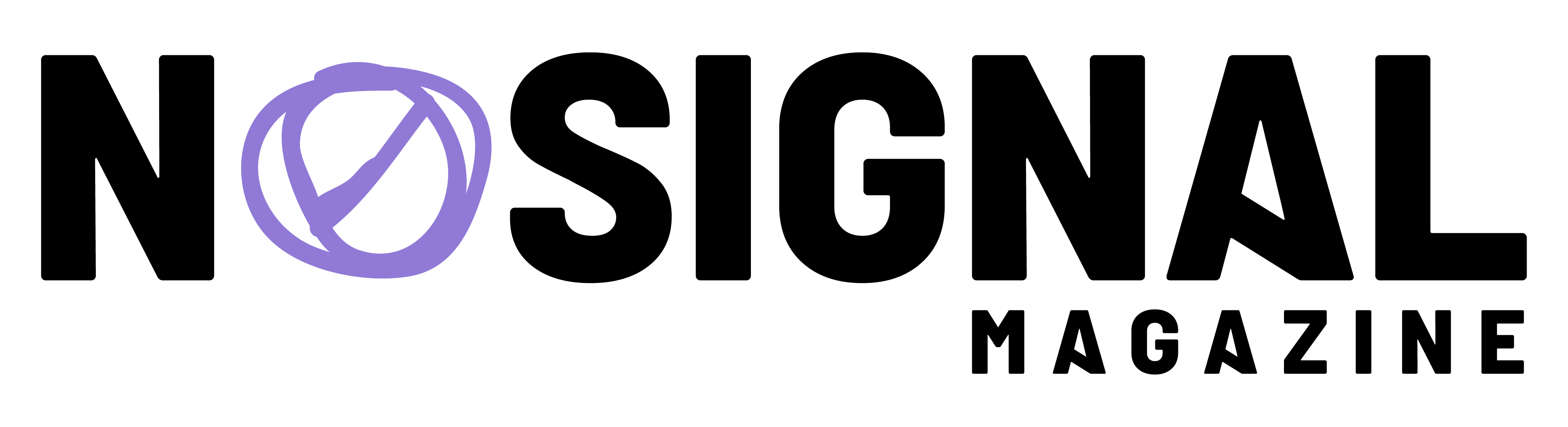








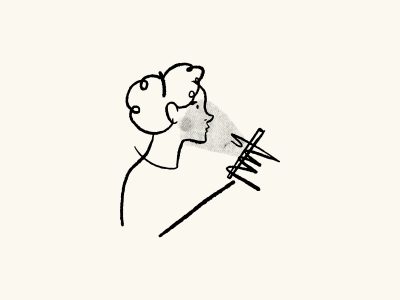







[…] Darvaza rappresenta un esempio lampante di come l’essere umano, nella sua superbia, pensi invano di poter controllare la natura che lo circonda. Ma la terra è sempre pronta a ricordargli quale sia il gioco di forza nel rapporto fra i viventi e l’ambiente che li circonda. (per approfondimento https://nosignalmagazine.it/the-long-walk-natura-uomo/) […]